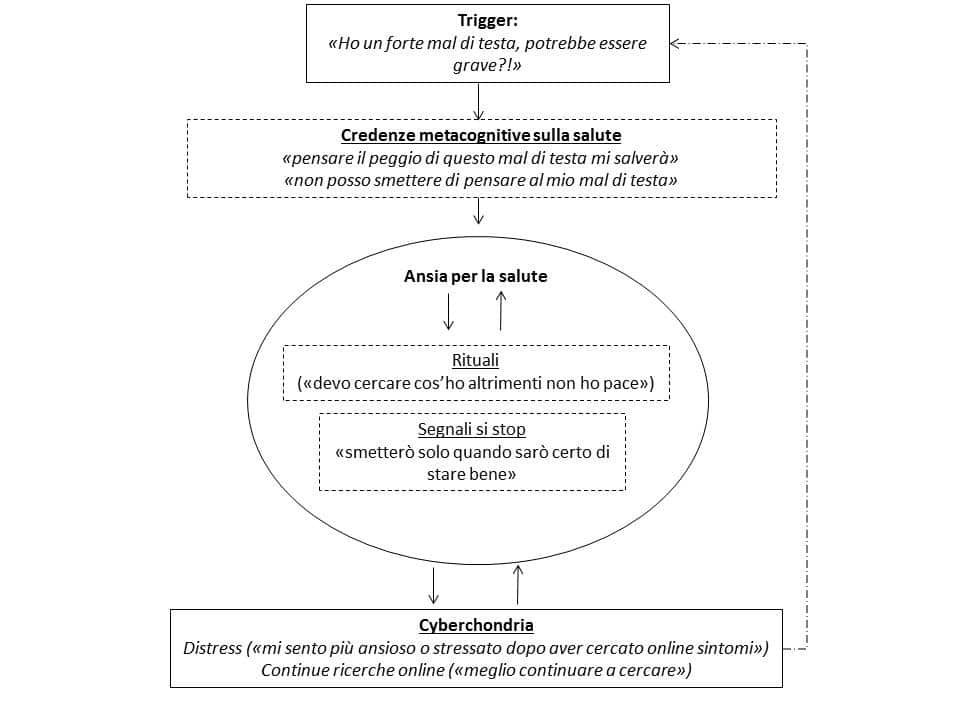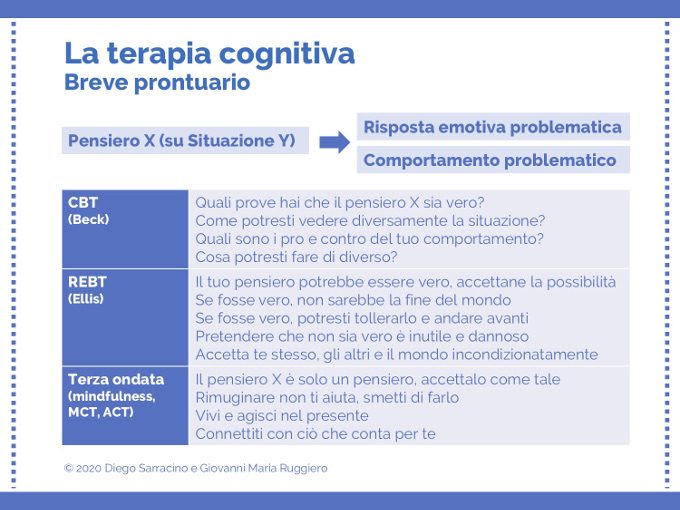Sesso e social media: impatto e soluzioni
La visione di film ricchi di scene sessuali incide significativamente sui comportamenti degli adolescenti come, ad esempio, l’anticipazione dei primi rapporti sessuali, la tendenza ad avere più partner e la minore propensione ad usare il preservativo negli incontri casuali.
Uno degli aspetti fondamentali e più complessi nella vita dell’essere umano è senz’altro la
sessualità.
La dimensione sessuale e gli atti ad essa correlati rappresentano, nella gerarchia dei bisogni, un elemento primario come Abraham Maslow (1954;1971) indicò nella celebre “Piramide dei Bisogni”. Si tratta infatti di un aspetto fisiologico, situato alla base delle necessità umane, strettamente legato al corretto compimento dell’individuo.
La sessualità riguarda sia le pratiche finalizzate al piacere e alla riproduzione, sia gli aspetti psico-sociali, fondamentali per la costruzione dell’identità, relativi al genere maschile e/o femminile, ivi comprese le modalità di espressione dei generi ed il vissuto interiore individuale, da cui possono derivare esperienze disforiche come quelle annoverate nei principali manuali diagnostici (ad esempio la “Disforia di genere” nel DSM-5).
L’ambito sessuale è stato oggetto di numerosi studi da parte di discipline quali biologia, psicologia, etologia e sociologia e concerne tutta la vita relazionale dell’individuo.
Ogni essere umano, sin dalla nascita, viene accolto ed accudito in base alla propria connotazione biologica ed al ruolo culturale relegato al genere e, crescendo, costruisce la propria identità sessuale, caratterizzata da una commistione di variabili quali i rapporti con l’ambiente familiare, la cultura in cui è inserito e l’interazione con l’altro.
Una divisione basata sull’identità di genere è più complicata di una basata sui meri comportamenti sessuali per almeno due ragioni: innanzitutto l’identità è un costrutto complesso da definire nella sua interezza, in secondo luogo, ogni essere umano ha una concezione diversa della propria identità sessuale e del ruolo di genere che può derivarne.
È utile ed altresì doveroso, differenziare il termine “sessualità” da “attività sessuale”: nel primo caso si fa riferimento specificatamente agli aspetti psicologici, sociali e culturali del comportamento sessuale umano, mentre col secondo termine ci si riferisce generalmente alla messa in atto del rapporto sessuale vero e proprio.
Questi due concetti, ampiamenti usati ed a volte confusi, sono intrinsecamente legati fra loro e sono l’uno il presupposto dell’altro; infatti, l’insieme degli aspetti psico-sociali legati alla concezione e all’espressione del sesso, inteso in senso lato, esercitano un’influenza sul comportamento e sulle attività sessuali.
In virtù di quanto detto il sesso può essere immaginato come un ampio contenitore di elementi positivi e negativi che concorrono a delineare il benessere psichico; basti pensare alle teorie freudiane principali e a come lo sviluppo psicosessuale in età evolutiva incida sull’investimento psichico nell’età adulta.
La scoperta dei propri organi riproduttivi e della loro utilità, la manipolazione, la fantasia sessuale, l’autoerotismo, il desiderio e la scoperta del piacere sono tutti aspetti positivi che dovrebbero essere normalizzati da parte degli adulti, piuttosto che censurati, per garantire un corretto raggiungimento della maturità.
La poca attenzione e la scarsa sensibilità al tema determinano una serie di outcomes negativi come la repressione, i disturbi legati alla sessualità, la concezione di un “sé” inadeguato rispetto alle aspettative sociali, le perversioni violente, l’astinenza, sino ad arrivare a ciò che oggi dilaga con esiti psicologici devastanti tra le comunità più giovani con l’avvento dell’era digitale: “slut shaming”, “body shaming”, “revenge porn”, bullismo, cyberbullismo, ecc…
Specialmente durante il periodo di quarantena forzata sono risultati ancora più influenti i messaggi veicolati dalle principali fonti di informazione come, ad esempio, smartphone, tablet, computer, televisione, ecc…
Non meno rilevanti sono gli effetti che la pornografia ha avuto ed ha tutt’ora sul comportamento dell’essere umano, soprattutto sui giovani.
A tal proposito, Martellozzo e colleghi (2016) hanno effettuato un interessantissimo studio per comprendere l’impatto della pornografia online sui ragazzi, attraverso un sondaggio che ha coinvolto circa 1000 preadolescenti e adolescenti, di età compresa tra gli 11 e i 16 anni.
I risultati hanno dimostrato come la visione ripetuta di contenuti pornografici può avere un effetto desensibilizzante rispetto all’impatto di immagini e/o video, portando i giovani a sperimentare meno ansia e disgusto rispetto a ciò che si sta osservando.
Il rischio maggiore è che questo accesso facilitato ed incontrollato a qualsiasi contenuto online possa condizionarli, specialmente quelli più introversi e sensibili, che molto spesso sperimentano difficoltà nella sfera sessuale (ad esempio ansia da prestazione, impotenza, insicurezza e vergogna legate alla percezione di sé stessi) inficiando pesantemente anche il concetto di intimità.
Pertanto, vista la rilevanza e la complessità del fenomeno in questione, risulta ancora più cruciale il ruolo dell’educazione sessuale, ossia quell’insieme di attività volte ad istruire individui di tutte le età circa l’importanza dell’essere informati sul sesso e le tematiche ad esso connesse (maturazione sessuale, anatomia e fisiologia dell’apparato genitale, i cambiamenti durante la fase di pubertà, la psicologia, le problematiche di tipo morale, la conoscenza delle abitudini legate al contesto di provenienza dei ragazzi) per sfatare i miti e ridurre le distorsioni cognitive.
Chiarite queste premesse, ora il focus si sposterà sull’impatto che il cinema e più in particolar modo i contenuti sessuali espliciti di film e serie, hanno sul comportamento dei giovani.
Contrariamente alla pornografia, i contenuti filmici o seriali non a “luci rosse” possono essere maggiormente filtrati in base ad un più corretto modo di intendere il sesso, in quanto atto sessuale.
Infatti, mentre nel primo caso la trasformazione dei contenuti sessuali in didattici comporta significative perdite economiche, nel secondo questo problema non si presenterebbe in egual misura poiché il sesso non è l’elemento centrale.
Molti attualmente sono i film o le serie tv, che presentano scene esplicite e/o eccessivamente enfatizzate; basti pensare ad un film cult degli anni Ottanta come 9 settimane e ½, alla più recente saga cinematografica Cinquanta sfumature o alla serie tv Game of Thrones.
Un’importante nonché preziosa eccezione nel panorama televisivo è costituita dalla serie Sex Education, un prodotto che raffigura molte delle difficoltà che derivano dai primi approcci sessuali (e le conseguenze che queste possono avere sul rapporto con sé stessi e con gli altri) in tutte le sfaccettature possibili, in modo naturale e concreto ma con leggerezza ed ironia.
Prima di entrare nel merito della disamina di alcuni studi scientifici legati all’impatto dei suddetti contenuti sui giovanissimi, è doveroso premettere che la tv ha descritto spesso gli adolescenti come individui introversi, tormentati, indecisi, quasi apparentemente disinteressati all’argomento per inerzia.
In effetti potrebbe anche essere così, tuttavia si sentiva il bisogno di una storia più rilassata, moderna ma ancora attenta alle problematiche dei più giovani e capace di comunicare loro senza troppi moralismi o patimenti.
Come già affermato precedentemente, la serie televisiva Sex Education rappresenta sia un’alternativa alle classiche serie adolescenziali che un’importante scommessa sul modo di affrontare l’argomento “sessualità”.
Parlano chiaro le sceneggiature che trattano non solo di sesso, ma anche di rapporti contorti, amori non corrisposti, scoperta di sé, bullismo e omosessualità.
Un caso emblematico è rappresentato dalla singolare storia di Otis, un adolescente britannico, figlio di una scrittrice e terapista sessuale di fama nazionale, con un problema ansiogeno che interferisce con la sua esposizione sociale e, più in particolar modo, con le pratiche di autoerotismo.
Egli non accetta l’aiuto di sua madre poiché infastidito dalla sua continua e pressante invadenza nella vita scolastica e intima; la sua storia rappresenta quella difficoltà che molti adolescenti sperimentano nel dialogo con i propri genitori, specialmente quando si affrontano argomenti delicati come la sessualità.
Sulla scorta di quanto detto, film, documentari e serie tv, costituiscono, dunque, una preziosa fonte di svago e divertimento, ma anche di conoscenza.
Che tali prodotti abbiano un forte impatto emotivo sugli spettatori, è argomento noto.
Oltre ciò è rilevante anche che esercitino una forte influenza sugli atteggiamenti e i comportamenti: ad esempio, diversi sono stati gli studi empirici che hanno indagato l’aumento dell’aggressività nei giovani a causa di una fruizione più ampia e poco censurata di scene violente in televisione o al cinema (Anderson e colleghi,2003).
Uno studio longitudinale condotto dallo psicologo americano dell’University of Missouri, Ross O’Hara, si è occupato del rapporto tra sesso e cinema, attraverso un quesito piuttosto interessante: le scene “bollenti” presenti e trasmesse sul grande schermo, hanno un’influenza sui giovani e, eventualmente, in che misura?
A questa ricerca, durata complessivamente sei anni (2003-2009), hanno partecipato 1228 persone (di cui 611 maschi e 617 femmine) di provenienza principalmente europea.
Dallo studio è emerso come nel campione, la visione di film ricchi di scene piccanti, incida significativamente sui loro comportamenti come, ad esempio, l’anticipazione dei primi rapporti sessuali, la tendenza ad avere più partner e la minore propensione ad usare il preservativo negli incontri casuali.
I risultati suggeriscono che la limitazione di film a contenuto erotico negli adolescenti, ritarderebbe il loro debutto sessuale e ridurrebbe la sensation seeking, normalmente esperita durante questa fase evolutiva, e, dunque, anche il loro impegno in comportamenti sessuali rischiosi futuri.
Fare ciò può essere un compito estremamente arduo, date le abbondanti quantità di sesso (Gunasekera, Chapman & Campbell, 2005) e violenza esplicita (Nalkur, Jamieson & Romer, 2010) ritratte nei film; tuttavia un approccio promettente consisterebbe nell’educazione all’alfabetizzazione mediatica, ossia la capacità di accedere ai media, di riconoscere e valutare criticamente i loro diversi aspetti e contenuti.
Una ricerca condotta da Pinkleton e colleghi (2008) ha mostrato dei risultati importanti in merito alle condotte sessuali rischiose degli studenti statunitensi. Precisamente, è stato attivato un programma curriculare di alfabetizzazione mediatica su un ampio campione (N=532) di studenti di scuola media, confrontati con un gruppo di controllo, per verificare i cambiamenti rispetto ai miti ed alle aspettative sul sesso.
Gli esiti di questo quasi-esperimento sono stati estremamente positivi: si è registrato un aumento della responsabilizzazione e della self-efficacy nel resistere alla pressione dei pari circa le prime esperienze sessuali, riducendone la percezione della prevalenza “normativa” durante la pubertà e migliorando il loro atteggiamento verso l’astinenza.
Considerando i risultati di questi studi circa l’impatto, le conseguenze ed i possibili interventi sulle condotte a rischio, sorge spontaneo chiedersi in che termini gli adolescenti parlino di sesso.
Uno studio più recente, condotto da Rosita Maglie nel 2017, ha messo in evidenza degli aspetti interessanti circa la comunicazione CMC (computer-mediated communication) sul tema della salute sessuale e riproduttiva.
In particolare, sono stati osservati gli scambi comunicativi tra esperti in materia e adolescenti all’interno dei cosiddetti “Q&A Websites”, ossia piattaforme in cui si possono rivolgere delle domande ed ottenere delle risposte garantite da equipe di professionisti.
Dal punto di vista metodologico, questi dialoghi virtuali vengono collezionati in un grande corpus, suddiviso in domande (Q-posts) e risposte (A-posts), e sottoposti alla analisi linguistica, con il supporto di software che consentono di osservare con più fluidità i dati.
Il sito oggetto di questa indagine è Kinsey Confidential, ma ci sono altri studi che seguono la medesima direzione tematica e metodologica (Harvey, 2013; Maglie, 2015). Le domande rivolte dai giovani sono estremamente rappresentative della loro idea di sessualità e delle relative preoccupazioni e conoscenze.
Vengono annoverate diverse pratiche sessuali con una notevole ricorrenza, timori rispetto alle conseguenze dei loro comportamenti, malattie sessualmente trasmissibili, probabilità di gravidanza, orientamento sessuale, pregiudizi, stereotipi ecc…Oltre a questi contenuti, è stato dato rilievo alla forma espressiva, in quanto i ragazzi contrappongono ai loro dubbi una buona padronanza del lessico sessuale, dimostrando di saper adeguatamente utilizzare e destreggiarsi tra i termini tecnici del campo medico.
Gli esperti che provvedono a fornire le risposte hanno una grande responsabilità sulle proprie spalle, in quanto devono offrire una comunicazione accogliente, comprensiva, empatica e non giudicante, normalizzando le preoccupazioni, informando accuratamente sui rischi e su come prevenirli, evitando prescrizioni specifiche che solo delle visite mediche o degli esami approfonditi possono offrire.
In accordo con le conclusioni dello studio, questi dati sono rilevanti ai fini della pratica clinica e dovrebbero incoraggiare a migliorare due aspetti: in primis, gli stili comunicativi verbali, normalmente infruttuosi o inadeguati per la fase evolutiva, che implicano un dialogo esente dai filtri virtuali (es. l’anonimato, la scrittura e il contesto asincrono); in secondo luogo, la qualità delle informazioni fornite dagli adulti, per incrementare la consapevolezza e la responsabilità.
In aggiunta, è auspicabile promuovere il benessere e la salute sessuale in un’ottica di prevenzione primaria, piuttosto che di intervento.
In conclusione, considerato quanto sino ad ora è stato detto, è necessario che in futuro la sessualità, data la sua intrinseca delicatezza ed importanza per l’essere umano, si associ ad un filone educativo ad hoc, oltre a ben sperare che tutto ciò che arrivi, per vie dirette o indirette, allo sguardo degli inesperti e dei più piccoli, possa essere modulato e filtrato in maniera adeguata, a garanzia del benessere psicosessuale delle generazioni prossime all’età adulta.