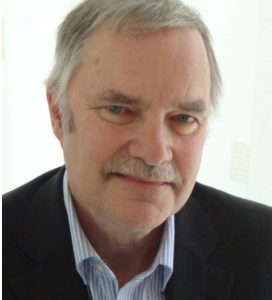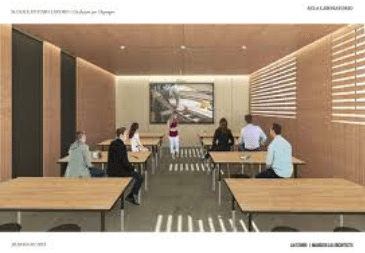Il Family Based Treatment: trattare i disturbi alimentari in adolescenza
Firenze. Inizi di ottobre. Due giornate formative tenute dal dott. Armando Cotugno sul trattamento dei Disturbi dell’Alimentazione in adolescenza attraverso il protocollo Family Based Treatment (FBT; Lock, Le Grange, 2018; Treasure, 2010, 2017).
I
Disturbi Alimentari (DA) possono essere definiti come persistenti comportamenti finalizzati al controllo delle forme corporee e del peso, che danneggiano la salute fisica o il funzionamento psicologico e che non sono secondari a nessuna condizione medica o psichiatrica conosciuta (Fairburn et al., 2003).
Funzionamento
In generale, i fattori di mantenimento sono molteplici e relativi a: comportamento alimentare e alterazioni del Sistema Nervoso Centrale, in particolare riduzione della sostanza grigia e alterata modulazione del sistema fame-sazietà (Kalivas& Volkov, 2005), distorsione dell’immagine corporea, stile cognitivo, stile emotivo, stile interpersonale. I pazienti non percepiscono azioni, pensieri ed emozioni come originati da sé, i bisogni sono quindi eteroderminati e vi è una difficoltà ad identificare sensazioni interne e stati mentali. In una fase adolescenziale, 13-15 anni circa, i cambiamenti corporei modulano la percezione di chi siamo, di come siamo accettati, del nostro sé nel mondo.
Il Family Based Treatment ritiene che questi cambiamenti possono aumentare, anche in relazione alle risposte dell’ambiente, il nostro senso di inefficacia, di vulnerabilità percepita. Nel periodo adolescenziale c’è un’attenzione particolare all’immagine percepita e all’immagine sociale, se la percezione dell’autoimmagine non è congrua con l’immagine di noi nel mondo aumenta la sensazione di vulnerabilità e quando viene sperimentato un senso di incertezza di solito la risposta comportamentale è aumentare il controllo. Ma come arriva l’adolescente a prediligere il controllo sul cibo rispetto a tante altre risposte disfunzionali? Treasure e colleghi sostengono che se lo schema nucleare del sé è basato sul costrutto efficace-competente/inefficace-incompetente e il dominio nel quale tale aspetto del sé si sviluppa è quello dell’immagine corporea, allora vi è un’ipervalutazione del peso e delle forme corporee ed è plausibile sviluppare un Disturbo dell’Alimentazione. Se le mie forme rispettano determinati canoni sociali di magrezza allora il mio sé è efficace, senza questa equazione percepisco un senso di incertezza, mi sento vulnerabile, ho paura, aumento la sensazione di incertezza nel mondo, devo controllare la mia alimentazione per ridurre il senso di vulnerabilità/pericolo. Nel caso della Bulimia Nervosa o del Disturbo da Alimentazione Incontrollata (DAI) la vulnerabilità percepita attiverebbe la disregolazione emotiva che porta alla perdita di controllo. È importante sottolineare che la sensazione di efficacia/inefficacia cambia nel corso della vita. Quando i domini di vita vengono ristretti nel tempo, a fronte di un aumento della complessità dei contesti di vita, è possibile che si instauri una patologia. La patologia che si instaura dipende dal rapporto tra l’immagine del sé e il dominio di vita, o i domini, di riferimento.
A livello sociale, una vulnerabilità di base temperamentale è accentuata da un ambiente di vita invalidante creando il circolo vizioso descritto in precedenza. Per quanto riguarda l’aspetto comportamentale, l’ipercontrollo è collegato con una scarsa capacità di agency (Fassino et al., 2002; Dimaggio, Ottavi, Popolo, Salvatore, 2019). In relazione all’aspetto medico, un DA causa notevoli conseguenze somatiche e fisiche che mettono seriamente a rischio la salute di chi ne soffre e rende questi disturbi molto gravi e pericolosi.
Nei DA l’esperienza corporea è alterata, il corpo vissuto è percepito in modo egodistonico quindi compiti multitasking mettono questi pazienti in difficoltà poiché li rendono meno consapevoli dato che la loro attenzione è focalizzata: non hanno la capacità di auto percepirsi e di prestare attenzione a più cose contemporaneamente. Utilizzare misure oggettive (bilancia, taglia, centimetro, tazza, cucchiaino, ecc…) aiuta questa tipologia di pazienti a creare un ponte tra il proprio corpo e la realtà percepita amplificando la consapevolezza della loro connessione col il mondo intorno.
Il trattamento FBT
L’FBT (Lock, Le Grange, 2018; Treasure, 2010, 2017) è un modello anglosassone e si basa sul fatto che davanti a un adolescente con disturbo alimentare i genitori, e la famiglia in genere, sono una possibile fonte di sostegno e di aiuto alla gestione. Le dinamiche che si creano nell’ambito familiare, nella vita quotidiana e in particolare durante i pasti, non sarebbero tanto causa del disturbo, ma contribuiscono al loro mantenimento. L’ipercriticismo e l’ipercoinvolgimento della modalità genitoriale peggiora la malattia poiché non vi è la funzione di contenimento, ma è presente l’evitamento delle problematiche (Lock, Le Grange, 2018). L’FBT fornisce inizialmente sostegno alle figure genitoriali che vengono investite del ripristino del peso dell’adolescente con disturbo alimentare. I genitori possono contare, da parte dell’equipe terapeutica, su un intervento di educazione, di sostegno e di validazione per la loro fatica. L’equipe quindi comprende psichiatra, nutrizionista e terapeuta FBT. L’accordo tra queste tre figure è un punto di forza, ma anche una potenziale debolezza. Di forza poiché più l’equipe è coesa, guidata dagli stessi principi, più la prognosi è favorevole. Di debolezza perché lo stesso accordo spesso non è facile mantenerlo, richiede molti incontri congiunti di discussione dei casi clinici, spazi e tempistiche idonee.
Vengono coinvolti i genitori per ragazzi al di sotto dei 18 anni. Nella prima fase si pone l’attenzione agli aspetti specifici del DA e alla distorsione dell’immagine corporea. Nella seconda fase del trattamento si lavora sulle difficoltà interpersonali, sul perfezionismo clinico, sulla bassa autostima, sull’intolleranza alle emozioni. L’obiettivo primario è quello di ripristinare il peso, e di questo se ne fanno carico i genitori, e solo secondariamente migliorare il processo di autonomia e svincolo dell’adolescente.
Le sedute di FBT, secondo il modello anglosassone (Lock, Le Grange, 2018; Treasure, 2010, 2017) si svolgono sempre in un setting familiare se siamo di fronte ad un minore di 18 anni. Il trattamento dura 6-12 mesi, circa 10-20 sedute. Vi sono principalmente tre fasi:
- Fase 1 (seduta 1-10). I genitori si assumono la responsabilità del ripristino del peso del paziente.
- Fase 2 (seduta 11-16). I genitori restituiscono il controllo alimentare al paziente.
- Fase 3 (seduta 7-20). Si discute sui compiti specifici dello sviluppo dell’adolescente.
Il trattamento è preceduto da una fase di assessment di circa 1 mese, dove vengono prescritti esami medici, vengono somministrati i test psicologici e si effettuano i primi colloqui (con il paziente e separatamente con i genitori). Successivamente, ogni seduta del trattamento si apre con il prendere nota del peso e si fa un grafico aggiornato di settimana in settimana. La prima seduta è focalizzata sulla psicoeducazione e sullo stabilire gli obiettivi primari (uscire dalla malattia) e secondari del trattamento (cambiamento cognitivo e autonomia). La gestione di tutto ciò che riguarda il cibo passa nelle mani genitoriali. Si dà il compito di fare almeno un pasto al giorno condiviso (anche in presenza di separazione tra i genitori) con tutta la famiglia. La seconda seduta è dedicata al pasto condiviso. Si lavora su chi prepara i pasti, chi decide cosa mangiare, chi fa le porzioni, di solito deve essere sempre uno dei due genitori. La famiglia deve portare tutto l’occorrente per il pasto, dalle vettovaglie, alle varie portate fino alle bevande. Vengono forniti tavolo e sedie. Il pasto condiviso è videoregistrato e nelle sedute successive è possibile visionare insieme degli spezzoni al fine di migliorare il funzionamento e condividere insieme momenti di difficoltà, che si verificheranno anche a casa, e momenti di risoluzione delle problematiche. Viene osservata la capacità dei genitori di aiutare il paziente. Alla fine della portata si chiede ad uno dei due genitori di chiedere al paziente di “mangiare un cucchiaio in più” e si osservano le dinamiche e i comportamenti di tutti i membri della famiglia, le difficoltà a gestire l’eventuale rifiuto del paziente, si inizia a costruire una bozza di schema relazionale familiare. Se c’è qualche membro in disparte, soprattutto nelle situazioni di difficoltà, si chiede di provare a dire qualcosa per aiutare gli altri familiari. A volte i fratelli sono un’ottima risorsa. Alla fine della seduta si validano tutti i membri della famiglia per lo sforzo fatto e i risultati raggiunti. Nelle sedute successive si lavora sul materiale emerso e su quello che porta la famiglia in relazione a ciò che avviene a casa durante i pasti e nella vita quotidiana, si aiuta il paziente a liberarsi delle
credenze sul proprio corpo gradualmente anche attraverso l’utilizzo dello specchio in seduta, fino ad arrivare alla restituzione del controllo alimentare al paziente e a poter lavorare su tutto ciò che emerge di rilevante.
Le basi teoriche di riferimento provengono da varie teorie di riferimento come DBT (Linehan, 2011; Swenson, 2018), CBT (Beck, 1984), CBT-E (Dalle Grave, 2012), Control Mastery Theory (Weiss, Sampson, 1999; Gazzillo, 2016) utilizzando tecniche comportamentali e tecniche di mindfulness. L’FBT ha 5 fondamentali assunti di base:
- Prospettiva non colpevolizzante.
- Atteggiamento cooperativo con la famiglia.
- Empowerment genitoriale. I genitori si fanno carico del ripristino del peso.
- Separazione del paziente dalla malattia.
- Focus iniziale sui sintomi.
L’atteggiamento del terapeuta è attivo, non controllante. Il terapeuta è un consulente esperto, sostiene l’autonomia dei genitori, è cooperativo.
I vantaggi del trattamento FBT sono molteplici tra cui: evitare il ricovero residenziale, riconsiderare il ruolo socio-affettivo della famiglia come una priorità clinica e adottare un protocollo validato scientificamente. Gli svantaggi risiedono soprattutto nell’applicazione fedele del protocollo anglosassone con tutte le difficoltà inerenti eventuali differenze culturali.
Il paziente, secondo gli autori, può attuare prevalentemente due comportamenti: supplica o minaccia. Di fronte ad un paziente che supplica, la famiglia risulta invischiata, ipercoinvolta, inibisce lo svincolo e infantilizza. Vengono definite “famiglie canguro”. Quando il paziente attua la minaccia la famiglia risulta avere atteggiamenti di critica, è disimpegnata sulle regole, è presente coercizione e una forte conflittualità: vengono definite “famiglie rinoceronte”. In queste difficili situazioni il sistema di protezione o attacco va in tilt e la cura si disorganizza. Il genitore si trova nel circolo dell’impotenza fatto di colpa, rabbia, paura, vergogna, ipercoinvolgimento ansioso e criticismo ostile. L’obiettivo dell’FBT è aiutare il genitore, validandolo, ad aiutare il proprio figlio nell’acquisizione di un’autonomia funzionale.
Si utilizzano tecniche mindful come osservare, descrivere e stare senza giudicare, trovare ciò che è efficace in quel momento, non ciò che è giusto. L’FBT non è una terapia fondata prevalentemente sulle dinamiche familiari che hanno portato al disturbo, ma primariamente e gerarchicamente si esce dal DA e solo successivamente si lavora sulle dinamiche connesse al disturbo. È importante cogliere e annotare, per un momento successivo, le eventuali colpevolizzazioni, l’accudimento invertito, tutte le dinamiche presenti. L’atteggiamento attivo, metacognitivo e mindful del terapeuta, l’esternalizzazione e il dialogo condiviso, modulano la paura e il criticismo della famiglia. Il DA viene visto come un deficit dell’esame di realtà, la paziente è malata e bisogna uscire dallo stato di pericolo.
I sintomi alimentari sono segni di ansie profonde,e tentativi disfunzionali di curarle, soprattutto di curare un senso pervasivo di inefficacia personale (Lock, Le Grange, 2018; Treasure, 2010, 2017). Questo senso di inefficacia personale porta il paziente a sentirsi vulnerabile, a sperimentare incertezza, ansia, paura e di conseguenza ad attuare strategie di coping, come il controllo sul peso e le forme corporee e la conseguente restrizione alimentare. Il controllo sul cibo ridurrebbe la vulnerabilità percepita, ma di fatto è una fonte di mantenimento. Per esempio dice la paziente G., 15 anni da poco compiuti, BMI di 15. “…a scuola non mi sento mai la vera me, lì devi a volte essere qualcun’altra per essere accettata, vedo le altre sempre con una marcia in più, faccio fatica e poi mi viene un peso che spesso diventa più forte tipo pugno allo stomaco. Le altre sono tutte magre, truccate, vestite alla moda e stanno avanti, io no… se mangio meno e sto attenta sarò come loro…”
Di fronte a un’adolescente con indice di massa corporea (Body Mass Index, BMI) inferiore a 17, in alcuni casi molto gravi arriva anche a 15, ci si focalizza sulla condizione medica in primis. La malnutrizione interferisce con i processi di maturazione e frontalizzazione dell’encefalo: regolazione emotiva, auto riflessività, metacognizione sono tutte capacità che in un cervello in crescita vengono compromesse e quindi diventa molto pericoloso. Fin dalle ricerche degli anni ’40 (Minnesota Study, 1944) a oggi si è visto che la malnutrizione modifica l’assetto psicologico dell’individuo ed ha anche effetti comportamentali e fisici. Se con un paziente che soffre di DA, il terapeuta lavora direttamente sulla malnutrizione, che è una strategia di coping, per recuperare lo stato di benessere, il paziente sentirà venir meno la sua percezione di controllo, sentirà inefficacia, vulnerabilità, aumenterà la paura, aumenterà anche il controllo e la rigidità e avrà maggiore restrizione alimentare. Con i DA è importante quindi lavorare in primis non sulle strategie di coping, ma sulla motivazione sottostante che spinge quel paziente a mettere in atto la restrizione alimentare. La malnutrizione crea infatti di base dei meccanismi di mantenimento comportamentale, fisico e psicologico con effetti sociali, quello che i pazienti con DA cercano di ottenere, mantiene il disturbo stesso. Le strategie di cambiamento devono partire dalla consapevolezza che se il paziente è costretto ad abbandonare uno schema che in quel momento, seppur disfunzionale, è fonte di sicurezza, allora parallelamente bisogna costruire un’altra strada alternativa più funzionale. L’intervento è mirato ad una desensibilizzazione sistematica dove il cibo (stimolo ansiogeno) viene presentato gradualmente e in contemporanea a stimoli che elicitano risposte emotive antagoniste all’ansia e alla paura. Attraverso l’aiuto del nutrizionista si cerca di ristabilire un più naturale accesso al cibo e contemporaneamente vengono insegnate le abilità per muoversi all’interno di contesti “difficili” come pasticcerie, supermercati, ristoranti e si lavora su come alimentarsi in contesti sociali. Parallelamente l’attenzione è posta sulla riduzione del pensiero fisso e pervasivo per il cibo e sull’aumento dell’autoefficacia e dell’autostima. Le tecniche utilizzate sono prevalentemente cognitive-comportamentali e tecniche di mindfulness. Mentre si lavora sulla costruzione di parti sane, desideri sani che emergono nelle sedute, come ad esempio leggere, ascoltare la musica, camminare nei boschi, alternative a quelle disfunzionali, si deve tener conto che la regolazione emotiva ha necessità di maggior tempo per migliorare, rispetto alla flessibilità e alla coerenza centrale. Infatti, il livello di interferenza emotiva è maggiore in chi soffre di AN pura (Kaye et al., 2009; Tchanturia et al., 2004; Fassino et al., 2002; Green et al., 1996).
Conclusione
L’obiettivo ultimo del trattamento FBT è promuovere l’autonomia del paziente che soffre di DA. Nel momento in cui il paziente è in uno stato di pericolo per la sua malattia, è considerato impossibilitato a provvedere momentaneamente a sé stesso. Tutta la gestione di contenimento, le decisioni su come, cosa e quanto mangiare passa nelle mani delle figure genitoriali, che proprio per questo oneroso compito devono essere grandemente supportate e validate. Il compito dell’adolescente è seguire le indicazioni dei genitori per uscire dallo stato di malattia e ripristinare il peso corporeo. Deve essere fatto uno sforzo metacognitivo per comprendere il genitore che in questo momento si trova in una combinazione di emozioni quali impotenza, colpa, paura, fallimento ed oscilla tra la protezione e l’attacco alla fonte del pericolo. In questi casi l’agente e la vittima della minaccia percepita coincidono, i genitori tendono infatti a vedere il proprio figlio come colui che fa i “capricci” non come malato, oscillando appunto tra l’iperprotezione (“dai su se non hai fame non fa nulla… dai prova un altro po’ fallo per me…”), all’attacco (“e su da però se fai così non la finiamo più, ti rendi conto di quello che stai creando?…”). Per fare una similitudine, è come se avessimo di fronte un paziente che soffre di asma e lo esortassimo continuamente a respirare bene. Il protocollo FBT aiuta il genitore a sostenere le emozioni negative, aiutandolo a regolarle per agire in modo congruo e sano verso i bisogni di cura della figlia.
Il fine settimana formativo è stato stimolante e ha sollevato molti spunti di riflessione. Mi chiedo quanto e come un tale protocollo sia applicabile alla clinica privata. Sicuramente un limite è da ricercare nel costo che il paziente si troverebbe ad affrontare nonché nelle tempistiche degli incontri con le diverse figure dell’equipe, sia da parte del paziente stesso, che da parte dei professionisti. Probabilmente con un’ottima fase di progettazione iniziale, ipotizzando un pacchetto generale dell’intervento, tali limiti potrebbero essere superati. Un’ulteriore riflessione è sul coinvolgimento del paziente che, nelle prime fasi del trattamento, sembrerebbe nullo. L’adolescente, in realtà, porta i suoi stati emotivi che vengono sempre trattati in un’ottica familiare e la famiglia stessa si prende in carico la gestione delle dinamiche. Gli incontri sono finalizzati al sostegno e alla validazione familiare in primis, all’acquisizione di strategie di gestione, alla comprensione del funzionamento, sempre tenendo in considerazione la famiglia tutta e solo in una seconda fase al lavoro verso l’autonomia del paziente.