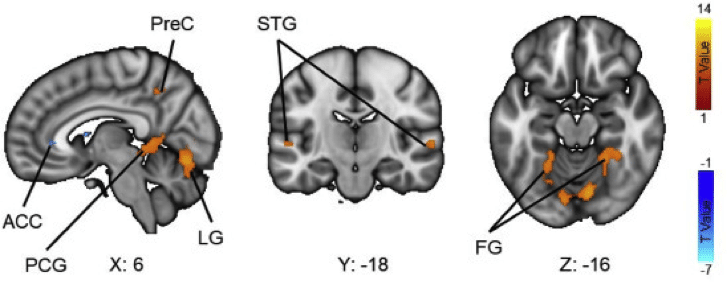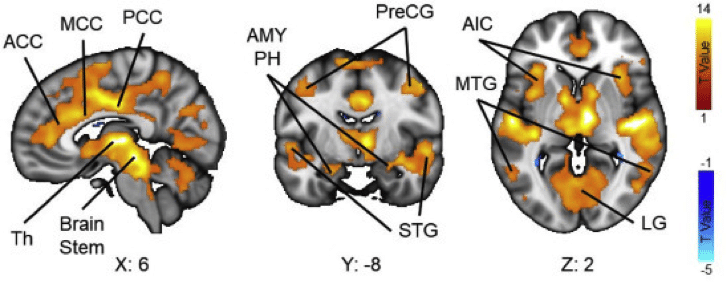La storia di Andrea: il Disturbo da Uso di Stimolanti – Modelli teorici e caso clinico
La presentazione di tale storia all’attenzione dei colleghi è mossa dal tentativo di colmare il gap nella letteratura clinica delle dipendenze circa il trattamento psicoterapeutico della dipendenza da uso di stimolanti (cocaina).
Il caso che verrà presentato, in maniera discorsiva, deve essere contestualizzato: si tratta di un
trattamento cognitivo-comportamentale somministrato a un paziente in regime residenziale presso una comunità terapeutica.
Tale caso clinico è stato trattato primariamente con la tecnica del colloquio motivazionale integrata ad una psicoterapia cognitivo-comportamentale comprendente nello specifico la psicoeducazione del disturbo, le tecniche cbt classiche, le tecniche cbt specifiche per la dipendenza da uso di cocaina, la prevenzione delle ricadute e il protocollo di terapia cognitiva basata sulla mindfulness (MBCT).
Modelli teorici di riferimento
Il modello di DiClemente e Prochaska
Fa da sfondo al trattamento il modello del cambiamento transteoretico di DiClemente e Prochaska del 1982 in quanto esso è molto importante per valutare la motivazione del paziente a iniziare e portare avanti un trattamento per il suo disturbo. Questo vale ancor di più nelle dipendenze dove la motivazione gioca un ruolo importante per la sopravvivenza. Tale modello è anche alla base della formulazione del colloquio motivazione di Miller e Rollnik (1991) che è stato utilizzato all’inizio del trattamento di Andrea. Per una trattazione più esaustiva di questo modello si rimanda a Esposito (2017).
Il modello di Marlatt
La “relapse prevention” o prevenzione della ricaduta, rappresenta il trattamento cognitivo-comportamentale centrale delle dipendenze ed è stato sviluppato per la prima volta da Chaney et al. nel 1978 per gli alcolisti.
Marlatt (1982 in Dèttore, 2018; Bugari 2017), successivamente, sulla scia di questo studio dedicherà la sua carriera a studiare i comportamenti di ricaduta dei dipendenti formulando un modello ancora oggi utilizzato alla base delle terapie.
Secondo l’autore, il processo tipico della ricaduta inizia con l’esperienza di stress, spesso derivante da uno squilibrio esistenziale. Ciò può portare a un desiderio di indulgenza, accompagnato dalla sensazione di avere il diritto a qualcosa di piacevole. Questi fattori di fondo a loro volta conducono a situazioni ad alto rischio, definite come minacce al controllo personale sul comportamento di dipendenza da sostanze e comprendono situazioni come il trovarsi in un bar o stati come il sentirsi ansiosi, rabbiosi e depressi.
A ciò si aggiungono delle distorsioni cognitive e delle decisioni disadattive che preparano a un “lapse” (scivolone) e quindi a un “relapse” (ricaduta). La distinzione concettuale fra le due consiste nel fatto che il primo è un occasionale, isolato e limitato episodio in cui il soggetto cede al comportamento di dipendenza da sostanze, a differenza del secondo, in cui il cedimento è importante e reiterato più volte in tempi ravvicinati (ibidem).
In tali situazioni di rischio, particolarmente importanti sono le abilità che permettono al soggetto di far fronte alle condizioni che pongono a rischio l’astinenza. Il passaggio dalle situazioni ad alto rischio al lapse, o al relapse, viene mediato da alcuni meccanismi specifici: il primo meccanismo è il cosiddetto “problema della gratificazione immediata” (PIG), che è caratterizzato dal focalizzarsi sulle caratteristiche piacevoli immediate del comportamento di indulgenza all’uso di sostanze, trascurandone le conseguenze negative a lungo termine (ibidem). Tale processo, unitamente a inadeguate capacità di problem solving e al rinforzo indotto dall’effetto bifasico delle sostanze d’abuso aumenta la probabilità del verificarsi di un lapse. Il passaggio al relapse, oltre al PIG, conta di un secondo meccanismo denominato “effetto di violazione dell’astinenza” (AVE) costituito da una complessa reazione cognitiva e affettiva alla violazione di una regola di astinenza proibente, o comunque limitante, un determinato comportamento abusante (ibidem). La forza dell’AVE dipende dalla misura in cui il soggetto è in grado di giustificare il lapse in modo egosintonico e da altri elementi come l’impegno nell’astinenza, la presenza di persone significative e la durata dell’astinenza. Inoltre, tale forza dell’AVE, dipende da processi attribuzionali: se il lapse viene attribuito a fattori esterni, instabili e specifici allora l’AVE sarà minimo; tuttavia, se l’attribuzione è interna, la forza dell’AVE è massima con un intaccamento dell’autostima e dell’autoefficacia (ibidem). Per Marlatt è fondamentale come il soggetto interpreta le eventuali e occasionali lapse.
Il modello di Pithers
È noto come il modello di Marlatt sia stato ampliato e applicato ad altre tipologie di disturbi molto simili a quelli delle dipendenze da sostanze come per esempio i disturbi sessuali e disturbi alimentari. Nel campo dei disturbi sessuali e, nello specifico, delle parafilie, Pithers (1990 in Dèttore 2018) amplia il modello di Marlatt (1982, in Dèttore 2018) fornendo due interessanti contributi: il primo è che il lapse viene definito come il verificarsi di un comportamento a rischio che viene considerato come il primo segno prevedibile di perdita di controllo, mentre il relapse è l’attuazione del comportamento di abuso (nel caso di Pithers il reato sessuale) senza che ciò implichi il ritorno a livelli precedenti di comportamento di abuso. Il secondo contributo è quello della formulazione delle “decisioni apparentemente irrilevanti”, cioè la decisione apparentemente irrilevante avviene in genere quando il soggetto è riuscito ad astenersi dal comportamento di dipendenza tipico per un certo tempo, con conseguente senso di incremento della propria auto-efficacia; se intervengono situazioni di stress o di squilibrio esistenziale, la sensazione di privazione può aumentare e quindi anche il desiderio di abbandonarsi al comportamento proibito. A questo punto interviene la decisione apparentemente irrilevante: essa riguarda il compiere azioni o l’inserirsi in circostanze che non sembrano legate al comportamento di abuso, ma che invece in ultima analisi pongono il soggetto in situazioni ad alto rischio.
Il modello di Beck et al.
Beck et al. (1993) formula un modello cognitivo per la comprensione del circolo vizioso di mantenimento dell’uso di sostanze.
Secondo l’autore, per definizione, i tossicodipendenti sono persone che hanno difficoltà a fermare l’uso in modo permanente. Possono aver iniziato a usare volontariamente, ma non credono di potersi fermare o non decidono di fermarsi volontariamente. Al primo segno di problemi medici, finanziari o interpersonali, molti pazienti ignorano, minimizzano o negano i problemi o li attribuiscono a qualcosa di diverso dalla sostanza. Altri possono essere consapevoli dei problemi, ma valutano i vantaggi dell’uso come maggiori degli svantaggi. Man mano che i problemi aumentano, molti utenti diventano più ambivalenti e cominciano a vacillare nella loro decisione di usare.
Un cospicuo fattore nel mantenimento dell’uso di droghe è la comune convinzione che il ritiro dall’uso produrrà effetti collaterali intollerabili (ibidem). Tuttavia, questi effetti variano enormemente da persona a persona e l’impatto è notevolmente amplificato dal significato psicologico associato ai sintomi di astinenza. Questi significati sono spesso più salienti delle reali sensazioni fisiologiche di disagio psicofisico dei sintomi da astinenza. La maggior parte dei consumatori di cocaina che partecipano a programmi di disintossicazione, ad esempio, si sentono meglio nelle prime fasi dopo che smettono di usare.
Secondo Beck et al. (1993) il principale ostacolo all’eliminazione dell’utilizzo o del consumo è la rete di convinzioni disfunzionali centrate sulla droga o sull’alcol. Esempi di queste convinzioni possono essere: “non posso essere felice se non posso usare” e “sono più sotto controllo quando ho bevuto qualche drink”. Un individuo che sta pensando di eliminare l’uso di droghe o alcol può sentirsi triste o ansioso. La cessazione del ricorso a droghe o alcol è vista come una privazione della soddisfazione e del conforto o una minaccia al benessere e al funzionamento. L’arresto può significare, per alcuni, rimuovere l’uso della “coperta di sicurezza” per attenuare la disforia umorale.
Gli individui dipendenti tendono spesso a smettere di usare o bere. Tuttavia, quando sperimentano il craving, si sentono delusi se si trattengono dall’utilizzare o bere. Percepiscono i loro sentimenti di delusione e angoscia come intollerabili; il pensiero “non posso sopportare questa sensazione” li sconvolge ancora di più. Quindi, si sentono spinti a cedere alla brama per dissipare il senso di perdita e la loro angoscia. I pazienti spesso hanno una serie di credenze che sembrano diventare più forti quando decidono di smettere di usare. Tali credenze possono essere del tipo: “se non posso usare, non potrò sopportare il dolore (o la noia)”, “non c’è più niente che va nella vita per me”, “sarò infelice” o “io perderò i miei amici.”
Un’altra serie di credenze si concentra sul senso di impotenza dell’individuo dipendente nel controllare la brama: “il desiderio è troppo forte”, “non ho il potere di fermarmi”, o “anche se lo fermassi – ricomincerà da solo”. Queste credenze diventano profezie che si autoavverano (Merton, 1971; Fiore, 2015). Poiché i pazienti credono di essere incapaci di controllare i loro impulsi, sono meno propensi a cercare di controllarli e, quindi, a confermare la loro convinzione nella loro impotenza nel superare la loro dipendenza.
Schema Therapy, TMI e DBT
Oltre ai modelli teorici citati sopra sono state utilizzate tecniche e riferimenti alla Schema Therapy (Young et al. 2003), alla Terapia Metacognitiva Interpersonale (Dimaggio, Semerari, 2003; Dimaggio et al., 2013) e alla Dialectical Behavior Therapy (Linehan, 1993; Linehan et al., 2000; Fiore, 2017).
La storia di Andrea
Andrea è un uomo di 45 anni della periferia di una grande città del Nord Italia; viene in comunità perché ha perso il lavoro, la compagna e non ha più un posto dove stare. Al primo colloquio si presenta abbastanza nervoso, spiegando di essere molto motivato ad entrare nella struttura comunitaria e a sottoporsi ad un trattamento per l’uso di sostanze.
Andrea tiene a sottolineare che il suo problema principale è la mancanza di un’occupazione lavorativa perché a suo dire è sempre riuscito a controllarsi nell’uso del fumo di cocaina. Prima del nostro incontro il paziente ha fatto un percorso di alcuni colloqui con la sua assistente sociale di riferimento e controlli delle urine presso il suo Ser.D di appartenenza.
Il primo colloquio termina con l’illustrazione del percorso terapeutico e con la firma di un contratto di ospitalità e la sottoscrizione di diverse regole.
Il paziente si mostra talvolta cauto talvolta deciso ad illustrare i suoi problemi. Racconta: “Mi sono deciso ad entrare perché vivevo in un garage senza acqua e senza luce; usavo la torcia del cellulare la sera. Il garage è di mio padre ma lui non sa nulla che io sono là; non c’è un buon rapporto tra noi… Non potevo continuare così”. Successivamente illustra il problema della mancanza di un lavoro con queste parole: “Il mio problema è principalmente il lavoro; io ho sempre fumato e ho sempre gestito la cosa, poi quando ho perso il lavoro ho perso tutto”. Alla mia domanda “perché hai perso tutto?” risponde: “Per questa merda di cocaina. Mi sto rendendo conto che è un problema, che ci ho speso una barca di soldi, certo che è la cocaina. Però da oggi in poi basta”. Riportiamo ancora una descrizione di un suo vissuto drammatico nelle settimane precedenti al nostro primo incontro: “Un giorno mi sono svegliato, mi sono guardato allo specchio e mi è venuta la nausea, mi sono fatto schifo, non volevo guardarmi e mi sono detto che non potevo continuare così, che non me lo merito. Mi sono messo a piangere, cosa che non faccio quasi mai e mi sono detto che dovevo intervenire, che dovevo fare qualcosa e mi sono deciso ad entrare.”
Storia personale e familiare
Andrea è il terzogenito di quattro figli (due maschi più grandi e una sorella più piccola) di una famiglia siciliana immigrata al Nord negli anni ’60. I fratelli sono tutti sposati con figli. La madre del paziente è deceduta qualche anno fa.
Andrea racconta di un padre violento e punitivo e di una madre passiva e dipendente dalle decisioni del marito. Ha avuto in infanzia diversi episodi di abuso fisico con punizioni esemplari molto forti. Il paziente racconta: “una volta alle elementari avevo spiato una mia compagnetta di classe. Mio padre quando l’ha saputo ha voluto punirmi: prima mi ha picchiato, poi mi ha spogliato e mi ha legato nudo fuori dal balcone al terzo piano dove noi abitavamo”. Successivamente nella prima adolescenza Andrea stava più fuori casa che dentro perché aveva paura del padre; racconta di furti, uso di marijuana, vandalismo e bullismo nei confronti di altri ragazzi. Il paziente racconta un altro episodio di violenza del padre: “Mio padre aveva saputo che avevo rubato, io sono tornato a casa. Ha iniziato ad aggredirmi fisicamente. Io sono riuscito a scappare, ma lui mi stava aspettando nella porta di casa. Poi alla fine sono dovuto tornare e me ne ha date tante.”
Per quanto riguarda la scuola, Andrea ha frequentato con molta fatica sino alla terza media con vari episodi di violenza in classe con i compagni e con i professori seguiti da periodi di sospensione e di espulsione dagli istituti. Successivamente al periodo scolastico Andrea intraprende sostanzialmente una vita movimentata, lavorando precocemente all’età di 16 anni, compiendo, a suo dire, vari furti, estorsioni, truffe e parallelamente usando sostanze: principalmente marijuana e cocaina.
Successivamente si sposa con una ragazza dopo pochi anni di fidanzamento, storia che però finisce con un divorzio a cui segue un periodo di depressione.
Storia del problema
Il paziente riferisce di usare sostanze dall’età di 11 anni circa, iniziando alle medie con la marijuana. Andrea frequentava amici più grandi di lui con i quali si trovava coinvolto inevitabilmente in situazioni legate a giri di stupefacenti. Oltre alla marijuana, verso i 16 anni ha provato anche diversi allucinogeni quando ha iniziato a frequentare le discoteche, poi successivamente è passato all’uso prevalente di stimolanti e, nello specifico, cocaina fumata.
Andrea sostiene di aver iniziato a fumare per caso; racconta: “eravamo fermi in un parcheggio con tutti gli amici, poi uno mi fa, ma tu non hai ancora fumato? Allora fanno tutto il rituale, dei passaggi che per me erano incomprensibili e mi hanno fatto fumare cocaina per la prima volta. Subito mi sono sentito scosso, agitato, eccitato e con la voglia di avere una donna. Questo è stato il mio primo episodio”. Dopo questo primo episodio Andrea non comprava direttamente lui la sostanza e non era frequente l’uso. Giorno dopo giorno però si trovava sempre di più in situazioni simili con persone che ne facevano uso. Successivamente, tuttavia, aveva imparato ad usarla in solitudine, perché, a suo dire, non gli piacevano le reazioni delle persone con cui stava.
Il paziente racconta che, quando era fidanzato e sposato, la sua compagna non sapeva nulla del suo uso di sostanze e che non voleva assolutamente lo sapesse. Racconta anche che un periodo critico e di aggravamento dell’uso è stato a seguito del divorzio con la stessa compagna. Poi dice: “io la usavo anche perché facevo lavori notturni. Mi aiutava. Mi faceva stare bene e non pensare ai problemi, alle menate di tutti i giorni”. Aggiunge: “quando lavoravo ho sempre gestito. Non sono mai andato fumato al lavoro. Nessuno si è mai accorto di niente e nessuno mi ha fatto mai casino per questa cosa. Poi quando non ero di turno e facevo serata spendevo tutto quello che avevo in cocaina.”
Valutazione psicodiagnostica
La valutazione psicodiagnostica è stata effettuata tramite colloquio clinico e la somministrazione di alcuni questionari e scale come il CBA 2.0 – Cognitive Behavioural Assessment (Sanavio, Bertolotti, Michielin, Vidotto, Zotti, 1997) e la SCID-5 PD – Intervista strutturata per i disturbi di personalità del DSM-5 (First, Williams, Benjamin, Spitzer, 2015). Il primo inventario ha messo in evidenza punteggi significativi per la scala dello psicoticismo (disadattamento sociale) e della depressione; alla SCID-5 PD, invece, è emerso un disturbo antisociale di personalità e un disturbo ossessivo-compulsivo di personalità, oltre ad alcuni tratti borderline e narcisistici, questi ultimi sotto soglia di diagnosi.
Dalla fase di assessment, quindi, è emerso un quadro abbastanza complesso della situazione psicologica di Andrea. Oltre al disturbo da uso di stimolanti è emerso un forte substrato depressivo, una tendenza del paziente ad essere ansioso e a somatizzare nonché un marcato disadattamento sociale. Come la maggior parte dei pazienti che fanno uso di sostanze, la richiesta di presa in carico è stata di tipo sociale (casa, lavoro).
Contemporaneamente alla fase di valutazione è stata sondata la motivazione del paziente e incrementata ulteriormente con la firma di un vero e proprio contratto che fosse decaduto qualora il paziente non avesse rispettato le regole della struttura ospitante e le norme basilari della terapia individuale per questo tipo di disturbo. E’ stato ampiamente ribadito che successivamente al trattamento cognitivo-comportamentale del disturbo da uso di stimolanti doveva essere somministrato un trattamento specifico per i tratti patologici di personalità, anche se questi sono, giocoforza, stati trattati anche nel corso di questo trattamento e in quelli di gruppo come qui sotto riportato.
Trattamento
Il trattamento ha avuto una durata di 8 mesi, con sedute a frequenza settimanale della durata di un’ora (32 sedute). Tale trattamento individuale è stato un’integrazione tra il colloquio motivazionale proveniente dalla terapia centrata sul cliente di Rogers (1951), l’educazione razionale emotiva (Ellis, 1962; Knaus, Bokor, 1975), la terapia cognitivo-comportamentale per la dipendenza da cocaina (Beck, 1993; Carroll, 1998) e la terapia cognitiva basata sulla mindfulness (Segal et al., 2013). Parallelamente al trattamento individuale Andrea ha seguito dei gruppi di apprendimento di abilità (skills training) come da protocollo della Terapia Dialettica Comportamentale (Linehan, 1993).
Colloquio motivazionale
Successivamente alla fase di assessment è stato effettuato un colloquio motivazionale nello stile di Miller e Rollnik (1991). Il colloquio motivazionale è una metodologia di colloquio messa a punto da Miller e Rollnik a partire dal 1980 e rivolta soprattutto a persone con dipendenze patologiche e deriva dall’approccio di Carl Rogers sulla terapia centrata sul cliente (1951). Tale stile di colloquio si basa: sulla consapevolezza che devono essere presenti delle abilità di counseling per costruire una buona relazione terapeutica; sulla costruzione di domande aperte e sulla riformulazione; sulla comprensione del processo di cambiamento come di un processo a fasi; sull’appropriatezza del linguaggio. Gli autori sostengono sia di primaria importanza verificare l’importanza percepita del problema e l’autoefficacia percepita dal paziente. Il colloquio motivazionale presuppone, inoltre, l’utilizzo di diverse tecniche quali: domande aperte, ascolto riflessivo, sostenere e confermare il cliente, evocare affermazioni in direzione del cambiamento.
Evocare affermazioni in direzione del cambiamento è stata una delle tecniche più importanti che è stata utilizzata con Andrea. Attraverso questa tecnica si è potuto evidenziare attraverso varie domande: gli svantaggi della situazione attuale, i vantaggi del cambiamento, la fiducia nella propria capacità di riuscire e l’intenzione di cambiare.
Ecco alcune domande fatte a Andrea per sondare le quattro aree qui sopra riportate:
- Svantaggi della situazione attuale:
T: Cosa la preoccupa della situazione attuale?
A: “Che non ho più nulla e non so come vivere.”
T: Che difficoltà ha avuto in relazione all’uso di sostanze?
A: “Il fatto che ho speso tanti soldi e che mi dovevo ritirare per non farmi vedere in giro.”
T: Cosa crede che accadrà se non farà alcun cambiamento?
A: “Penso che succederà qualcosa di brutto, o finirò in carcere o morirò.”
- Vantaggi del cambiamento:
T: In che modo vorrebbe che le cose fossero diverse?
A: “Vorrei avere un posto dove stare e mangiare regolarmente, poi un lavoro, vorrei fare le cose normali.”
T: Quale sarebbe il lato positivo di smettere di usare cocaina?
A: “Che sarei più lucido per ottenere le cose che voglio, sarei più concentrato; poi non spenderei tutti quei soldi e sarei più presentabile anche per la mia famiglia.”
T: Cosa è importante per lei?
A: E’ importante essere sano, lavorare, avere una famiglia e stare bene.
- Fiducia nella propria capacità di riuscire:
T: Cosa è che le dà il coraggio di cambiare?
A: “Che non può continuare così, non me lo merito, non è quello che voglio.”
T: Cosa le fa pensare che se decidesse di cambiare sarebbe in grado di farlo?
A: “Perché sono che sono in regola, so lavorare e mi so comportare con le persone, sono educato e non mi tiro indietro se c’è da fare qualcosa.”
T: Cosa e chi potrebbe aiutarla a fare questo cambiamento?
A: “Mi potrebbe aiutare stare nella vostra struttura e stare concentrato su quello che devo fare, poi sicuramente un lavoro; mi potrebbe aiutare ricucire i rapporti con mio padre e avere contatti con mia sorella e una mia vicina che mi hanno sempre aiutato e credono in me.”
T: Cosa pensa di fare?
A: “Penso che accetto questo percorso e farò del mio meglio.”
T: In che modo potrebbe ottenere i risultati desiderati?
A: “Ascoltando le vostre indicazioni e impegnandomi a non usare.”
In questo modo è stato possibile esplorare le potenziali capacità del paziente a produrre cambiamento e le ragioni, il bisogno e il desiderio di cambiare.
Psicoeducazione
Nelle prime fasi della psicoterapia individuale si sono svolte sedute di informazione sul disturbo da uso di sostanze, sulle dipendenze, sui disturbi ad esse associati, incluse le informazioni di tipo medico-sanitario.
È stato molto importante sfatare, fin da subito, miti e idee disfunzionali sull’uso delle sostanze (Baldini, 2010) come: “tanto la cocaina non dà assuefazione, quindi posso smettere quando voglio”, “mi faccio solo quando decido io, il fine settimana con gli amici”, “ho già dimostrato in passato che quando voglio posso smettere”, “ho bisogno della cocaina perché mi fa sentire sempre al massimo, perfetto, senza debolezze”.
In seguito è stato effettuato con il paziente un training educativo di base sulle emozioni per via della ricorrente presenza di alessitimia nei pazienti con dipendenze. Tale training si basa sull’educazione razionale emotiva (Knaus, Bokor, 1975) e sulla REBT (Ellis, 1962). Per ogni emozione è stata data una definizione dell’emozione prima soggettiva poi con l’aiuto del terapeuta è stata rimodulata; gli è stato chiesto di localizzare la sensazione fisica dell’emozione nel corpo e si è lavorato sulla funzione delle emozioni, sulla loro durata e sull’allenamento a riconoscerne l’intensità. Una volta compreso il significato della sintomatologia è stato introdotto il modello cognitivo-comportamentale con l’A-B-C (Ellis, 1962 in DiGiuseppe, 2014).
Tecniche di fronteggiamento
Esercizi di respirazione diaframmatica e Rilassamento muscolare progressivo di Jacobson
In quanto il paziente presentava una tendenza ad essere ansioso e attivato è stato ritenuto opportuno fornirgli subito degli strumenti spendibili al bisogno che lo aiutassero ad abbassare l’emotività e la tensione con degli esercizi di respirazione diaframmatica ed il rilassamento muscolare progressivo di Jacobson, nella forma abbreviata (1928 in Galeazzi, Meazzini, 2004).
Ristrutturazione cognitiva
Andrea, all’inizio, ha fatto un po’ di fatica a comprendere l’A-B-C (Ellis, 1962 in DiGiuseppe, 2014) per cui è stato importante elicitare delle memorie autobiografiche per mettere in luce la connessione evento-pensiero-emozione (Di Maggio et al., 2013).
Dall’analisi funzionale sono emerse varie distorsioni cognitive (Beck, 1976; Morgese, 2018) nei pensieri automatici negativi di Andrea, quali: astrazione selettiva (penso sempre a fumare, sono irrecuperabile), generalizzazione (oggi tutti usano coca), personalizzazione (oggi Walter è troppo serio, sicuramente ce l’ha con me per qualcosa), pensiero dicotomico (per me è così oppure non se ne fa nulla), catastrofizzazione (non ne verrò mai fuori). La ristrutturazione cognitiva è stata una tecnica trasversale a tutto il trattamento e ha permesso a Andrea di capire che poteva esistere un altro modo di pensare oltre al suo, che non bisogna essere definitivi nelle proprie convinzioni e affermazioni e che quindi il modo di pensare poteva essere cambiato e quindi stare meglio.
Di seguito riporto uno spaccato di terapia dove riflettiamo sulla sua distorsione cognitiva di astrazione selettiva/generalizzazione con il pensiero “penso sempre a fumare, sono irrecuperabile”:
T: “prima ha detto una cosa abbastanza rigida, se ne è accorto?”
A: “io? Quale?”
T: “Lei ha detto: penso sempre a fumare, sono irrecuperabile.”
A: “eh si, veda lei! Guardi la mia situazione, ora ce l’ho sempre in testa come un chiodo fisso, perché ho sempre fumato e so fare quello.”
T: “capisco, quindi lei ritiene di essere irrecuperabile perché pensa sempre 24 ore su 24 alla cocaina?”
A: “si, ma non 24 ore su 24, ma la maggior parte del tempo, ora un po’ meno rispetto a prima.”
T: “okay, bene, quindi mi sta dicendo che ci pensa spesso, ma non sempre, giusto?”
A: “si, spesso, ma non sempre.”
T: “questa cosa che ha detto adesso è importante, perché ci aiuta a non generalizzare, anche perché è quasi impossibile che una persona possa avere la mente occupata dallo stesso pensiero 24 ore al giorno, cosa ne pensi?”
A: (ride) “si è vero, ho detto una cazzata.”
T: “non ha detto una cazzata, è stato il suo modo di dire, in maniera un po’ amplificata, che ci pensa e che avrebbe il desiderio di usare.”
A: “si è così.”
T: “e questo desiderio e pensiero quasi costante le fa credere di essere irrecuperabile.”
A: “si perché penso che sono uno stupido a non saperlo reprimere o che non so evitarlo.”
T: “si è comprensibile, però lei non è stupido. Uscire dalla droga non è semplice, liberarsi dalla sostanza non è semplice. Il fatto che lei ci pensi sempre non è indicativo del fatto che lei sia dotato ti scarsa intelligenza, ma è un sintomo molto comune e normale.”
A: “si ma mi fa sentire una merda.”
T: “questo è un altro discorso.”
A: “perché io ce la devo fare dottore, perché sono stufo, sono veramente stanco.”
T: “mi sembrano dei buoni propositi e delle buone motivazioni, rimanga concentrato sull’obiettivo e si ricordi sempre quest’ultima frase che mi ha detto.”
Gestione della contingenza
La gestione della contingenza è un modello di terapia comportamentale in cui un individuo viene rinforzato o ricompensato per l’evidenza di un cambiamento comportamentale nella direzione dell’obiettivo di cura, nel caso delle dipendenze: l’astinenza (Petry, Martin, 2002).
Questo approccio è fondamentalmente basato sui principi del condizionamento operante o apprendimento strumentale definiti per la prima volta in modo sistematico da Burrhus Skinner (1938 in Meazzini, Carnevali, 2016), secondo cui un comportamento viene appreso o modificato in funzione delle sue conseguenze. Vale a dire, ciò che un individuo fa o impara a fare dipende dalle conseguenze del suo comportamento stesso.
L’uso delle sostanze e anche le dipendenze, comprese quelle comportamentali, possono essere viste come una forma di un condizionamento operante, in cui la ripetuta associazione tra stimoli di contesto, assunzione di sostanze (risposta comportamentale), attivazione del sistema della ricompensa (rinforzo positivo) può portare prima all’aumento della risposta comportamentale, cioè l’uso di sostanza e poi alla sua fissazione.
Come terapia comportamentale, la gestione della contingenza mira a cambiare la struttura di rinforzo che opera nel comportamento dei soggetti dipendenti, in cui il rinforzo delle sostanze o del comportamento oggetto della dipendenza è dominante (Petry, Martin, 2002). Ciò è possibile erogando rinforzi positivi come conseguenza dell’astinenza o di comportamenti che possono competere con l’uso della sostanza e la dipendenza.
In concreto un intervento di gestione della contingenza nelle dipendenze può prevedere un controllo frequente delle urine, per verificare l’astinenza, e l’immediato rinforzo contingente per ogni campione negativo, pulito. Il rinforzo può essere monetario, ad esempio voucher o premi, oppure in benefits, come abbonamenti per palestre, biglietti del cinema, concerti, piscina e così via (ibidem).
In questo caso con Andrea è stato utilizzato un controllo urine ogni 4 giorni per tutta la durata del trattamento e i rinforzi consistevano in:
- Uscita dalla comunità una volta alla settimana per una mattina/un pomeriggio.
- Uscita dalla comunità due volte alla settimana per una mattina/un pomeriggio.
- Uscita dalla comunità per mezza giornata rimanendo in zona.
- Uscita dalla comunità per andare a trovare i familiari (dalle 8 alle 22).
- Due giorni fuori dalla comunità.
- L’uso della TV.
Analisi funzionale della sostanza
La terapia cognitivo-comportamentale del disturbo da uso di sostanze (Carroll, 1998; Setti, Benato, 2010) dà molta importanza alla fase di analisi funzionale della sostanza. L’analisi funzionale permette di individuare le cause di un comportamento problematico analizzandone la funzione: è quindi importante capire gli effetti conseguenti poiché sono essi stessi che mantengono il disturbo. Utilizzare l’analisi funzionale è molto utile per lo sviluppo della consapevolezza nel paziente della funzione che la sostanza ha rispetto alla sua personalità, ai suoi schemi cognitivi e ai rapporti interpersonali.
L’analisi funzionale della sostanza ricostruisce la dinamica di un episodio di assunzione di cocaina per individuare in modo preciso come abbia preso avvio, quali pensieri e quali sensazioni abbia provato il paziente, quale comportamento abbia messo in atto e infine quali siano state le conseguenze positive e negative (Setti, Benato, 2010).
Nel caso di Andrea fumare cocaina voleva dire: fermarsi e prendersi del tempo per sé in solitudine, fare aggregazione sociale, fronteggiare episodi di depressione, fronteggiare il senso di vuoto e la noia, fronteggiare il senso di bassa autostima, sentirsi abile socialmente e attivo a fare qualcosa. Il paziente è stato sorpreso di tutte le funzioni che la sostanza aveva per la sua vita e iniziava a capire l’entità e la portata dell’uso di stimolanti, ma anche che la sua personalità doveva essere aggiustata.
Ripetere più volte tale analisi permette al paziente di imparare a riconoscere le situazioni per lui a rischio relative alle emozioni che prova, a stimoli ambientali e a eventi stressanti. Inoltre, incrementa la motivazione al trattamento e permette di costruire una solida base per una buona alleanza terapeutica perché i pazienti riescono a capire il significato dell’uso della sostanza.
Prevenzione delle ricadute
Successivamente al primo step di analisi funzionale della sostanza siamo passati al cuore della terapia cognitivo-comportamentale della dipendenza da cocaina. La prevenzione delle ricadute è una macro fase centrale in questa tipologia di trattamento e che comprende: la gestione del desiderio (Kadden et al., 1992 in Carroll, 1998), l’individuazione di comportamenti protettivi e alternativi all’uso (Monti et al., 1989 in Carroll, 1998), con le cosiddette “decisioni apparentemente irrilevanti”, ed infine l’esercitazione sul mettere in atto un “piano di difesa multifunzionale” (Jaffe et al., 1988 in Carroll, 1998).
Gestione del desiderio
È importante per i pazienti comprendere che provare un certo desiderio rappresenta un fatto normale e abbastanza comune e occorre infondere la credenza funzionale che provare desiderio non significa che le cose stanno andando male o che si avrà una ricaduta. La gestione del desiderio (Carroll, 1998) si compone di passi ben precisi costituiti da:
- Capire e descrivere il desiderio: cioè vedere insieme al paziente quando il desiderio sovviene durante il giorno, la sua frequenza e durata, ma soprattutto riflettere sul senso del desiderio, sul significato che ha per il paziente e sulle preoccupazioni che esso suscita.
- Identificare le cause scatenanti. Questa analisi comprende l’individuazione di tutti i fattori che portano all’uso della droga ed emerge più volte nel corso del trattamento.
- Affrontare il desiderio con varie strategie quali la distrazione, il parlare del desiderio, l’accettazione del desiderio e il ricordare le conseguenze negative dell’uso di cocaina.
Individuazione dei comportamenti alternativi
Questo passo è molto importante nel trattamento della dipendenza perché propone al paziente modalità differenti di comportarsi e di pensare invece di usare la sostanza. L’individuazione dei comportamenti alternativi (Carroll, 1998; Setti, Benato, 2010) ha permesso a Andrea di essere creativo e di pensare per la prima volta dopo tanto tempo come riempire la vita di tutti i giorni sostituendo la sostanza. Questa tecnica presuppone:
- L’individuazione di comportamenti a rischio, come tutte le azioni che massimizzano la probabilità di usare cocaina.
- L’individuazione di comportamenti protettivi, cioè azioni che proteggono il paziente e controllano lo stimolo (cambiare numero di cellulare, telefonare al terapeuta o una persona cara, andare in un posto sicuro, evitare i luoghi rischiosi, uscire di casa senza soldi, cambiare strada o percorso, evitare le persone che usano sostanze).
- L’individuazione di comportamenti alternativi, cioè azioni funzionali che sostituiscono il tempo impiegato dal desiderio e dall’uso della sostanza (leggere, fare una passeggiata, fare ginnastica, giocare al computer, disegnare o dipingere, scrivere, cucinare, trovare un’attività piacevole).
In questo punto del trattamento è bene ragionare sulla modalità di rifiuto della cocaina e una sulle decisioni apparentemente irrilevanti in termini pratici, operazionali e, soprattutto, molto realistici.
Per quanto riguarda la modalità di rifiuto della cocaina abbiamo si sono effettuati dei role play per imparare a rispondere negativamente all’offerta della sostanza. Il role play in questione prevedeva la seguente scaletta di comportamenti e frasi: prima cosa dire no; guardare gli occhi l’altra persona; chiedergli di non offrire più cocaina; non aver paura di porre dei limiti; non lasciare la porta aperta a offerte future e ricordarsi la differenza tra modalità di reazione passiva, aggressiva e assertiva che ho introdotto nel corso del trattamento.
È stato molto importante introdurre il riconoscimento delle decisioni apparentemente irrilevanti. Questa tecnica si basa sul modello di Pithers (1990 in Dettore 2018) introdotto nella terapia cognitivo-comportamentale proposta da Carroll (1998), e si basa sull’assunto che, mentre è possibile in ogni momento prima dell’uso interrompere la catena, è molto più difficile farlo alla fine della catena stessa, quando i pazienti si trovano già in situazioni in cui la cocaina è disponibile e gli stimoli condizionati abbondano. Pertanto, è molto utile riconoscere le decisioni che, normalmente, intervengono all’inizio della sequenza, quando il rischio, il desiderio e la disponibilità della cocaina sono relativamente bassi (Carroll, 1998).
Le decisioni apparentemente irrilevanti vengono trattate tramite il riconoscere, l’evitare e il fronteggiare: riconoscere le decisioni apparentemente irrilevanti e i pensieri collegati, evitare le decisioni rischiose, far fronte alle situazioni ad alto rischio.
Con Andrea abbiamo identificato alcune decisioni apparentemente irrilevanti che sono tipiche del suo uso:
- Usare alcool, marijuana, pastiglie;
- Tenere alcool in casa;
- Non eliminare gli accessori connessi all’uso della cocaina;
- Frequentare o fermarsi con persone che fanno uso;
- Tenere nascosto ai membri della famiglia che ha fatto uso/fa uso;
- Non comunicare alle persone con cui usava cocaina che ha deciso di smettere;
- Non programmare la settimana con attività di vario tipo;
- Fronteggiare la stanchezza in modo funzionale.
Oltre a questo elenco è stato chiesto ad Andrea di riportare alla mente il ricordo di almeno tre situazioni specifiche dove ha usato cocaina, cercando di ripercorrere la catena degli eventi antecedenti all’uso nel modo più scrupoloso possibile in maniera da identificare le azioni, i pensieri, e le emozioni e gli stati mentali associati.
Sviluppare un piano di difesa multifunzionale
La prevenzione delle ricadute si identifica come nucleo centrale della terapia cognitivo comportamentale del disturbo da uso di sostanze e delle dipendenze e ciò, nel caso della dipendenza da cocaina, presuppone lo sviluppo di un piano di difesa multifunzionale (Jaffe et al., 1988 in Carroll, 1998). Nello specifico occorre invitare il paziente a pensare ad almeno tre principali eventi stressanti che potrebbero capitare nei mesi seguenti il termine del trattamento e quali potrebbero essere le relative reazioni. Questo perché quando i pazienti sono molto stressati, sentendosi vulnerabili possono riutilizzare le vecchie e familiari strategie di difesa piuttosto che quelle maggiormente funzionali, imparate e messe in atto durante il trattamento. Il piano di difesa di base che di solito si utilizza nelle dipendenze da sostanza comprende:
- Una certa quantità di numeri telefonici di emergenza;
- Ricordare le conseguenze negative delle ricadute;
- Dei pensieri positivi che sostituiscono quelli che portano all’uso.
- Distrazioni facilmente realizzabili.
- Una serie di posti sicuri dove è possibile attendere il superamento della crisi senza troppe tentazioni e stimoli.
Andrea ha compilato una flashcard (Young, 2003) da tenere sempre con sé, che formula in maniera chiara e sintetica il piano di difesa multifunzionale (Jaffe et al., 1988 in Carroll, 1998) progettato in seduta.
Problem Solving
Successivamente sono state introdotte delle strategie di risoluzione dei problemi in quanto il paziente presentava la tipica impulsività dei consumatori di sostanze di fronte a un evento difficile od un problema di vita. Ad Andrea è stato utile capire che la soluzione migliore, cioè più efficace, per risolvere il problema era quella di non accumulare i problemi singoli facendone uno insormontabile (con le varie emozioni amplificate annesse) e di non lasciarsi travolgere dall’onda di ansia, insicurezza e tristezza o rabbia collegata agli eventi, ma di mettere da parte queste emozioni (analizzandole poi successivamente) e concentrarsi sul processo di risoluzione del problema, rispondendo alla domanda: cosa posso fare io per risolvere questo problema?
I pazienti con dipendenza da uso di sostanze hanno scarse capacità di problem solving, ma queste possono essere apprese ed allenate insieme a una serie di altre abilità come previsto, per esempio, nel modello della DBT della Linehan per i consumatori di sostanze (Linehan, Dimeff, 2000). Le strategie di problem solving fanno parte del modulo “abilità di tolleranza della sofferenza” che a sua volta è uno dei quattro moduli per la terapia di gruppo della Dialectical Behavior Therapy (Linehan, 1993).
Il problem solving viene definito come quel processo cognitivo autodiretto, attraverso il quale si cerca di identificare soluzioni efficaci e adattive da applicare ai problemi incontrati nella vita quotidiana (D’Zurilla, Goldfried, 1971). Le strategie di problem solving sono abilità di coping versatili e generali, utili ed efficaci in un ampio range di situazioni difficili.
L’insegnamento di tali strategie parte dal presupposto che di fronte ai problemi quotidiani e alle difficoltà relazionali spesso le modalità di fronteggiamento dei pazienti si limitano a reazioni del tutto impulsive. L’assunzione di sostanze può rientrare in queste modalità impulsive e rappresentare in alcuni casi un modo generalizzato di risoluzione delle difficoltà (Cavalieri, 2010).
L’obiettivo dell’insegnamento delle strategie di problem solving è fornire al paziente una strategia generale che gli consenta di affrontare nel modo più appropriato le varie situazioni conflittuali ricorrendo alle proprie risorse personali.
Mindfulness
L’ultima parte del trattamento è stata dedicata all’introduzione delle abilità di mindfulness, nella formulazione della terapia cognitiva basata sulla minduflness di Segal et al. (2013) per favorire un atteggiamento di distacco dai propri pensieri, quindi allenare le funzioni di decentramento e di automonitoraggio (Dimaggio, Semerari, 2003). Inoltre, tale tecnica ha permesso di promuovere gentilezza e compassione verso il paziente stesso in un clima di accettazione e libertà.
Conclusione della terapia ed Esito del trattamento
Successivamente alla mindfulness è stato utile ripassare i punti chiave del trattamento, le tecniche utilizzate e quali sono stati i momenti di maggiori difficoltà, nonché ciò che è stato fatto per superarli. Il paziente nell’ultima fase della terapia si è dimostrato impaurito e desideroso di sostegno per la conclusione del rapporto terapeutico.
Il trattamento ha avuto un esito positivo. Il paziente è sempre stato negativo al controllo urine e non ha mai effettuato un lapse o un relapse. L’atteggiamento di ricaduta era però visibile a livello umorale e comportamentale e durante il trattamento è avvenuto almeno 3 volte.
Relazione terapeutica
La relazione terapeutica è stata molto travagliata. All’inizio il paziente è stato agganciato bene anche per la sua motivazione. In seguito, la motivazione al trattamento e alla sospensione protratta dell’uso ha creato delle difficoltà relazionali tra il terapeuta principale e il paziente, o con gli altri operatori della comunità, anche per alcune credenze che venivano a galla in momenti particolari, come ad esempio: “questo trattamento non mi serve, io sto bene” oppure “io ho bisogno di un lavoro e ce la faccio”, oppure “lei non mi può insegnare niente”: pensieri carichi di aggressività e derivanti in larga parte dal sottostante disturbo di personalità.
Le difficoltà relazionali consistevano in errate interpretazioni del paziente circa le riflessioni che venivano fatte in seduta e le conseguenti emozioni che emergevano in maniera eccessiva non venivano gestite adeguatamente sfociando in chiusure nette da parte di Andrea. Dopo tali episodi, tuttavia, il paziente riusciva a capire l’errore di ragionamento che compiva ed inoltre apprezzava l’assertività degli operatori nel spiegargli il perché succedeva tutto questo.
È doveroso sottolineare che con pazienti aventi queste tipologie di disturbi, le rotture dell’alleanza terapeutica capitano molto spesso, poiché alla base vi è quasi sempre uno schema di sfiducia (Young et al., 2003). Tuttavia, è possibile prevedere come esiterà il ciclo interpersonale messo in atto dal paziente (Dimaggio et al., 2013). In questi casi, il terapeuta deve ricorrere a delle tecniche di disciplina interiore perché è molto facile agganciarsi emotivamente al copione messo in atto dal paziente. Se riconosciuto in tempo, attraverso un adeguato distacco, è possibile, in maniera assertiva, riportare il paziente al presente facendogli notare il suo funzionamento nel qui e ora, e chiedendogli cosa vuole comunicare e perché, naturalmente validando il vissuto del paziente.
Nonostante queste difficoltà il paziente ha portato avanti con impegno il trattamento e ha sempre mostrato interesse nel capire il suo funzionamento.
Follow-up
È stato effettuato un controllo a 1, 3, 6, 12 e 24 mesi dalla fine del trattamento. Non c’è stata una ricaduta e il paziente è sempre stato negativo al controllo urine. Al termine del dodicesimo mese dalla fine del trattamento è stato dichiarato in remissione protratta come da DSM-5 (APA, 2013), con la specificazione “in ambiente controllato”, che poi è decaduta dopo che il paziente è entrato nella fase di sgancio del percorso comunitario.
Punti di forza e limiti
I punti di forza del trattamento dell’uso da stimolanti di Andrea sono riassumibili in una parola: integrazione. Integrazione non solo di varie tecniche terapeutiche (di fatto sono state utilizzati elementi teorici e tecniche di orientamenti diversi, vedi sopra), ma anche di varie figure differenti all’interno della comunità come quella dello psicoterapeuta, dell’educatore, dello psichiatra, del medico di medicina generale, dell’assistente sociale e di altro personale. Tutte le figure hanno saputo contribuire entro i loro limiti professionali.
I limiti di tale trattamento sono riconducibili essenzialmente al fatto che il paziente si trovava in regime residenziale, in una comunità terapeutica, per cui l’accesso alle sostanze d’abuso era fortemente limitato rispetto a un trattamento non-residenziale; ed inoltre, la motivazione al trattamento era condizionata dallo stato economico del paziente, perché costui non disponeva di una entrata fissa, di un lavoro e di un alloggio dove eventualmente stare.