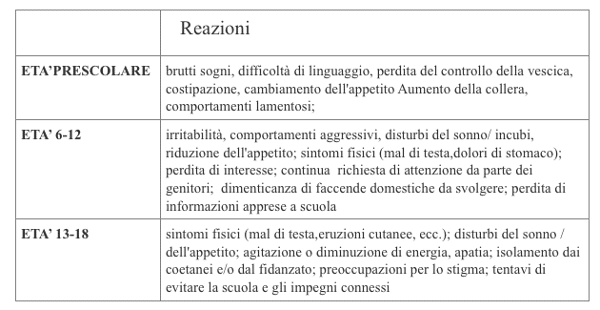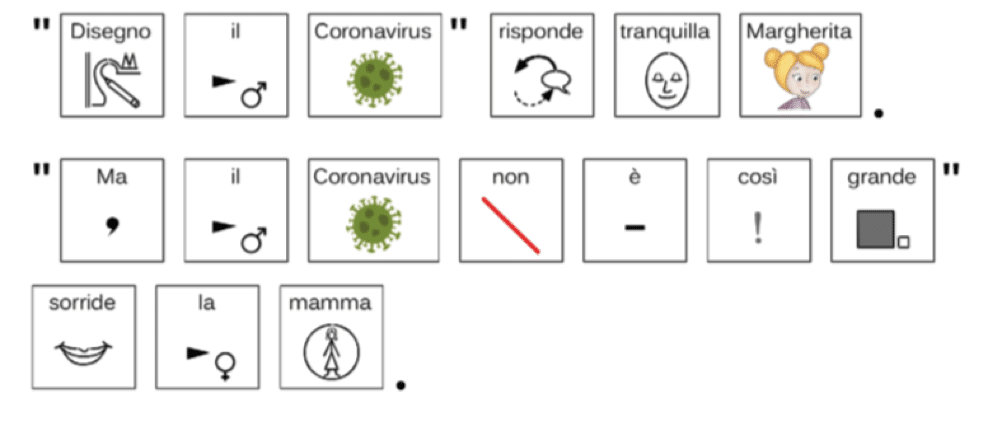Siamo l’esercito del selfie… ma perché? La FoMO come predittore dell’uso problematico dei social
“Fear of Missing Out” (FoMO) significa “paura di essere tagliato fuori”. Questo fenomeno è correlato con l’uso eccessivo dei social network ed è caratterizzato dal desiderio di restare continuamente connessi con quello che gli altri stanno facendo (Przybylski et al., 2013).
Mazzieri Elena – OPEN SCHOOL Studi Cognitivi, San Benedetto del Tronto
Vi ricordate il tormentone di qualche estate fa “L’esercito dei selfie”? Per un periodo non si poteva accendere la radio senza ascoltare questa canzone. Un singolo molto orecchiabile, che volenti o nolenti tutti noi abbiamo canticchiato sotto l’ombrellone. Sostanzialmente ci ricorda come ormai il
telefono sia diventato un prolungamento del nostro braccio, e che spesso siamo più interessati alle interazioni online rispetto a quelle “in carne ed ossa”. Una osservazione tanto semplice quanto veritiera: spesso siamo più interessati a ricevere like e a controllare cosa stanno facendo gli altri che a parlare con chi abbiamo davanti a noi.
Ammettiamolo, tutti noi conosciamo qualcuno che, molto elegantemente, mentre gli stiamo parlando ci ignora e controlla il suo smartphone. Hanno addirittura coniato un nuovo termine per questo atteggiamento: phubbing. In poche parole si tratta dell’atto di snobbare qualcuno in un setting faccia a faccia, concentrandosi sul proprio telefono piuttosto che parlare con la persona direttamente (Chotpitayasunondh & Douglas, 2016; Kenny, 2016). E se anche tutti noi pensiamo che questo sia un comportamento fastidioso ed irrispettoso, quando sentiamo vibrare il telefono, anche se stiamo parlando, un’occhiatina allo schermo la lanciamo comunque.
Proviamo a pensarci: siamo a cena fuori, in un ristorante. Accanto a noi c’è una tavolata di ragazzi. Cosa vediamo appoggiati sul tavolo accanto a posate e tovaglioli? Eccoli lì! Smartphone di tutti i tipi che si illuminano continuamente per la miriade di notifiche che i ragazzi ricevono. E se non sono sul tavolo, è perché i ragazzi li stanno tenendo in mano per fotografare e postare ogni attimo di quello che stanno facendo. Sulla bacheca dei nostri social siamo inondati di foto di piatti di ristoranti e di sorrisi in posa. Per non parlare poi della classica foto estiva delle gambe con lo sfondo del mare! E noi, nel nostro ufficio o a casa, a rimuginare sul fatto che il mare lo vedremo, nella migliore delle ipotesi, soltanto con il binocolo.
Siamo annoiati, ci facciamo un giro sui social e vediamo che gli altri stanno facendo cose che noi non possiamo fare. Alcuni di noi potrebbero sentirsi un po’ infastiditi, altri tristi, dipende sempre da quello che pensiamo. Ma ritorniamo per un attimo alla tavolata di ragazzi al ristorante seduti accanto a noi. Provate ad immaginare quanti post e foto pubblicheranno di quella serata. Ed ora provate ad immaginare di essere l’amico che è rimasto a casa. Non ci interessa sapere se è rimasto a casa perché malato, perché i genitori non lo fanno uscire, perché gli amici non lo hanno chiamato. Proviamo a immaginare cosa può pensare e a come può sentirsi quel ragazzo che, sfogliando i social, continua a vedere gli amici divertirsi mentre lui è a casa. Con il proseguire della serata gli altri continueranno a postare e lui continuerà a controllare i vari post con l’ansia di sapere cosa si sta perdendo. Che fatica essere adolescenti ai tempi dei social!!
Da sempre i ragazzi (e non solo, diciamo la verità), hanno avuto la tendenza a pensare a cosa gli altri stanno facendo (Abel et al., 2016). Negli anni ’70 e ’80 tra gli studenti c’erano persone con sintomi ansiosi riguardanti l’essere esclusi da determinate esperienze, quali, ad esempio, le relazioni romantiche (Simon, 1982). Ma ora sono arrivati i social, e possiamo sapere in tempo reale cosa gli altri stanno facendo e, di conseguenza, cosa ci stiamo perdendo.
Il desiderio di avere relazioni interpersonali è innato, e per soddisfarlo le persone cercano di appartenere a gruppi sociali. Al giorno d’oggi i gruppi sociali esistono sia dal punto di vista fisico che virtuale, e le persone hanno accesso ai gruppi sia online che offline (Franchina et al., 2018). I social media offrono un luogo dove gli utenti possono restare in contatto con i loro gruppi sociali. Social network quali Facebook o Instagram, ad esempio, offrono una connessione online a persone attraverso i loro canali personali, facilitando il mantenimento dei rapporti (Franchina et al., 2018).
I gruppi virtuali sono altrettanto reali ed importanti quanto i gruppi fisici. Non riuscire a connettersi con questi gruppi tramite i social può causare l’impressione di sentirsi tagliati fuori dalla vita reale (Clayton et al., 2015).
L’esclusione sociale conduce ad una perdita del senso di appartenenza, la quale causa ansia. Quando le persone non possono accedere ai propri profili social, possono sentirsi in ansia proprio perché temono di essere esclusi socialmente (Abel et al., 2016). L’esclusione sociale inoltre elicita sentimenti di mancanza di valore (Abel et al., 2016). Questi sentimenti conducono le persone a compararsi agli altri sui social (Tandor et al., 2014), al fine di decidere il proprio valore personale (Casale et al., 2018). I social network offrono un luogo dove gli utenti, in particolare i più giovani, possono continuamente tenersi al passo con cosa gli altri ragazzi stanno facendo, controllando che cosa si stanno perdendo (ad esempio eventi sociali, esperienze di vita, opportunità, ecc).
Gli adolescenti usano abbondantemente i dispositivi digitali e i social media, in maniera maggiore rispetto al resto della popolazione, e lo fanno per comunicare con i pari, per trascorrere il tempo libero (ascoltare la musica, guardare film o serie tv o giocar online) e per apprendere (Carlisle et al., 2016; Wu & Chen, 2015; Lenhart et al., 2015a).
Alcuni studi hanno mostrato una connessione positiva tra il cercare informazioni tramite internet e performance accademiche migliori negli studenti delle scuole secondarie (Chen et al., 2014). Tuttavia l’uso di internet può diventare problematico per quegli studenti che non sono in grado di controllare le proprie attività (Wąsiński and Tomczyk, 2015).
Internet fornisce ai ragazzi l’opportunità di restare continuamente connessi a costi accessibili, garantendo, se lo si desidera, l’anonimato. Avere la possibilità di comunicare con gli altri è una forte motivazione a navigare in rete. Nel 2015, Lenhart et al. (2015b) hanno dimostrato che l’80% degli adolescenti comunica con i propri amici quasi esclusivamente tramite messaggi. Sentirsi parte di un gruppo e socialmente accettati è molto gratificante per i ragazzi, ma allo stesso tempo queste caratteristiche di internet e dei social media inducono all’uso problematico di internet (van den Eijnden et al., 2010; Young, 1998). La combinazione tra adolescenza e le caratteristiche uniche del cyberspazio pongono i ragazzi a rischio di un uso problematico di internet. In adolescenza vi sono molti cambiamenti: maturazione puberale, sviluppo cerebrale, cambiamento nella relazione con i genitori e ambiente sociale in espansione. Tutto questo fa sì che aumenti vertiginosamente il rischio di intraprendere precocemente comportamenti di dipendenza (Chung, 2013).
Ovviamente, l’uso di internet non è di per sé problematico. Lo può diventare soltanto quando i ragazzi non riescono più a controllare le loro attività online. I ragazzi iniziano ad abbandonare le proprie attività quotidiane e spendono tutto il loro tempo online (Wąsiński and Tomczyk, 2015). Si parla, appunto, di Problematic Internet Use (PIU), vale a dire l’uso di internet che crea difficoltà psicologiche, sociali, lavorative o scolastiche nella vita della persona (Beard & Wolf, 2001). Studi hanno dimostrato la presenza di alta comorbidità tra la dipendenza da internet e disturbi psichiatrici, soprattutto disturbi dell’umore, inclusa la depressione, ansia generalizzata o ansia sociale e deficit di attenzione e iperattività (Chen et al., 2016). Gli adolescenti che presentano PIU spendono un’eccessiva quantità di tempo online e non riescono a gestire il proprio tempo in maniera efficace. Di conseguenza, questi ragazzi frequentano poco la scuola e non eseguono i proprio compiti, fino ad arrivare all’abbandono scolastico (Chen & Tzeng, 2010).
Negli ultimi anni alcuni studi hanno individuato, tra i precursori psicologici dell’uso problematico di internet, la “Fear of Missing Out” (FoMO) (Przybylski et al., 2013), che tradotto significa “paura di essere tagliato fuori”. Questo fenomeno è correlato con l’uso eccessivo dei social (Alt, 2015, 2016, 2017a, 2017b). La FoMO è caratterizzata dal desiderio di restare continuamente connessi con quello che gli altri stanno facendo (Przybylski et al., 2013). Più recentemente, Abel et al. (2016) hanno descritto la FoMO come un bisogno irrefrenabile di essere in due o più posti contemporaneamente, alimentato dal timore di essere tagliati fuori da qualcosa che può scalfire la propria felicità.
Per coloro che hanno questa nuova forma d’ansia, l’uso dei social media è particolarmente attrattivo. Piattaforme come Facebook, Twitter e Instagram sono disegnate per promettere alti livelli di coinvolgimento sociale (Ellison, Steinfield, & Lampe, 2007). Possiamo pensare a questi tipi di social come a dei mezzi per ridurre il prezzo da pagare per essere socialmente coinvolti. Mentre questi tipi di strumenti possono essere considerati come vantaggiosi per la popolazione generale, sono una sorta di manna dal cielo per coloro che se la devono vedere con la FoMO. Persone con alti livelli di FoMO utilizzano maggiormente i social così da restare sempre connessi con quanto stanno facendo gli altri.
La Self-determination theory (SDT; Deci & Ryan, 1985), una macroteoria riguardante la
motivazione, fornisce un’utile prospettiva per inquadrare la FoMO in una cornice teorica. Secondo questo modello, l’autoregolazione e la salute psicologica sono basate sulla soddisfazione di tre bisogni psicologici di base: la competenza (capacità di agire efficacemente nel mondo), l’autonomia (capacità di autodirezionarsi e di prendere iniziative personali) e l’affiliazione (vicinanza e connessione con gli altri). La soddisfazione di questi bisogni primari è associata con la regolazione comportamentale. Attraverso queste lenti teoriche, la FoMO può essere compresa come incertezza nell’autoregolazione che emerge da deficit situazionali o cronici di soddisfazione dei bisogni psicologici (Przybylski et al., 2013).
Sulla base di questo, bassi livelli nella soddisfazione dei bisogni primari possono portare alla FoMO e all’utilizzo dei social media in due modi. Direttamente: persone con bassi livelli di soddisfazione dei bisogni possono gravitare intorno ai social media perché percepiti come una risorsa per stare in contatto con gli altri, sviluppare competenze sociali e sviluppare legami sociali più profondi. Indirettamente: la FoMO può essere un mediatore che collega i deficit nei bisogni psicologici all’uso dei social (Przybylski et al., 2013).
Un’altra importante dimensione della FoMO riguarda il suo potenziale collegamento con la salute psicologica e il benessere.
La comunicazione mediata dalla tecnologia può avere effetti positivi e negativi (Turkle 2011). Il “sé-incatenato” che deriva dalla comunicazione tecnologica sempre in essere, può distrarre le persone da importanti esperienze sociali nel qui ed ora. Il desiderio di essere continuamente connessi è potenzialmente pericoloso dal momento che incoraggia le persone a controllare i propri account social anche quando sono alla guida dell’auto (Turkle, 2011). Wortham (2011) sostiene che la FoMO possa determinare umore negativo e depresso perché pone nella persona il dubbio di aver fatto le scelte sbagliate nella propria vita.
Studi incentrati sulle motivazioni interne hanno dimostrato che il desiderio di evitare stati emotivi negativi, come la solitudine (Burke et al., 2010) e la noia (Lampe et al., 2007), forzi l’uso di social come Facebook. Anche la scarsa soddisfazione per le proprie relazioni sociali può portare la persona ad utilizzare i social (Ellison et al., 2007).
Va da sé, quindi, che la FoMO giochi un ruolo importante nel collegare fattori individuali, quali bisogno di soddisfazione psicologica, umore e soddisfazione per la propria vita, all’uso dei social media (Przybylski et al., 2013).
Studi condotti da Przybylski et al. (2013) hanno sottolineato come siano soprattutto i giovani, ed in particolare i maschi, ad avere livelli più alti di FoMO. Per di più, i fattori motivazionali che sono risultati efficaci per spiegare i comportamenti umani nelle relazioni (Patrick et al., 2007), nell’uso dei videogame (Przybylski et al., 2009) e nell’ambito sportivo (Hagger & Chatzisarantis, 2007), sono importanti anche nella FoMO.
La FoMO, inoltre, è risultata essere correlata negativamente con l’umore e la soddisfazione per la propria vita. Tutti insieme, questi fattori (bassi livelli di soddisfazione dei propri bisogni primari, umore e soddisfazione per la propria vita) sono risultati correlati con l’uso dei social media soltanto nella misura in cui correlati con alti livelli di FoMO. In altre parole, la FoMO gioca un ruolo chiave nello spiegare l’uso dei social media anche al di là di altri fattori (Przybylski et al., 2013).
Inoltre gli studi condotti da Przybylski et al. (2013) hanno dimostrato che le persone con alta FoMO tendono ad usare Facebook spesso appena svegli, prima di andare a dormire e durante i pasti. Studenti con alti livelli di FoMO riportano sentimenti ambivalenti riguardo ai social e spesso usano Facebook durante le lezioni universitarie. Le persone con alti livelli di FoMO, infine, sono risultate avere maggiori probabilità di inviare messaggi, controllare social ed e-mail alla guida dell’auto.
Le persone possono utilizzare media differenti per gratificare bisogni differenti (Katz, 1959; Ajzen, 1991). Questo può spiegare le differenze nella popolarità di alcuni tipi di piattaforme social. Nel 2015, ad esempio, la popolarità di Twitter è stata superata da quella di Instagram. Questo probabilmente perché le immagini hanno più effetto rispetto alle parole nel raggiungere obiettivi di autopresentazione, che sono motivazioni centrali rispetto all’uso dei social (Lee et al., 2015). Sulla base di questo, possiamo ipotizzare che ogni piattaforma social ha delle proprie caratteristiche ed un proprio invito all’uso. Differenti social possono connettere gli utenti a persone differenti, e dare accesso a diversi tipi di informazioni rispetto ai quali gli utenti desiderano essere aggiornati.
La FoMO è un predittore nell’uso dei social quali Facebook (Beyens et al., 2016; Błachnio et al., 2018) e Instagram (Barry et al., 2018; Salim et al., 2017). Nel caso di quest’ultimo, ad esempio, la persona è motivata dal desiderio di tenersi in contatto con gli altri (Lee et al., 2015) e dal restare aggiornata rispetto a cosa gli altri stanno facendo (Sheldon et al., 2015).
Quando l’uso dei social media diventa eccessivo, può diventare un problema. Si parla, infatti, di uso problematico dei social media (Caplan, 2006; Chakraborty, 2010). Coloro che sperimentano la FoMO possono tentare di alleviare la propria ansia controllando gli altri tramite i social. Ironicamente, le persone che controllano i propri account social, hanno maggiori probabilità di trovare eventi ai quali non hanno preso parte. Usando i social per ridurre l’ansia possono quindi sperimentarne ancora più e, di conseguenza, maggiore FoMO. Questo circolo vizioso si autorinforza, finendo per trasformare l’uso dei social in un uso problematico (Franchina, 2018).
Le persone, e soprattutto i più giovani, preferiscono usare lo smartphone per navigare in rete. Questi, infatti, ci permettono di essere in contatto con gli altri ovunque ci troviamo. Questo fa ipotizzare che se le persone provano ansia, possono tentare di ridurla temporaneamente accedendo ai propri account social tramite lo smartphone (Kuss et al., 2018). Coloro che hanno alta FoMO ed usano i social per diminuire la propria ansia, possono usare in modo eccessivo i propri smartphone al punto da interferire con le proprie interazioni sociali faccia a faccia. Il phubbing, appunto (Franchina, 2018).
Essere consapevoli di quali sono le motivazioni che ci spingono a controllare ripetutamente le notifiche e le bacheche social, permette di realizzare forme di interventi preventivi, volti a migliorare il benessere delle persone e, in particolare dei ragazzi. Imparare ad utilizzare in modo adeguato i social consente di aumentare i livelli di soddisfazione per la propria vita e di avere una buona rete sociale.
Certo è vero, siamo l’esercito dei selfie, ma cerchiamo di non mancarci “in carne ed ossa”!