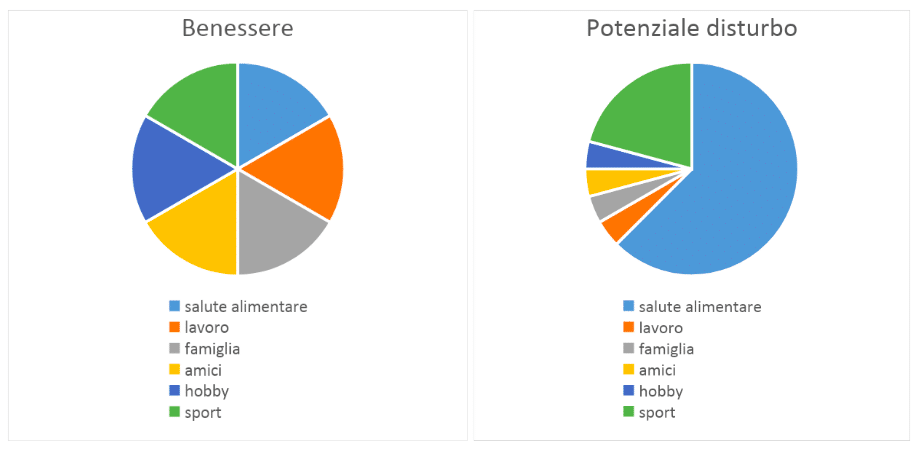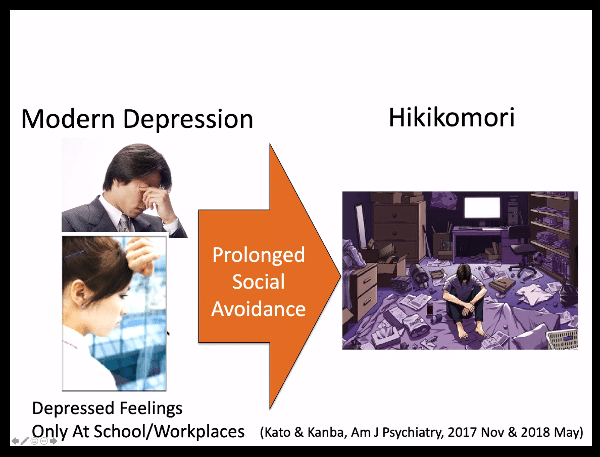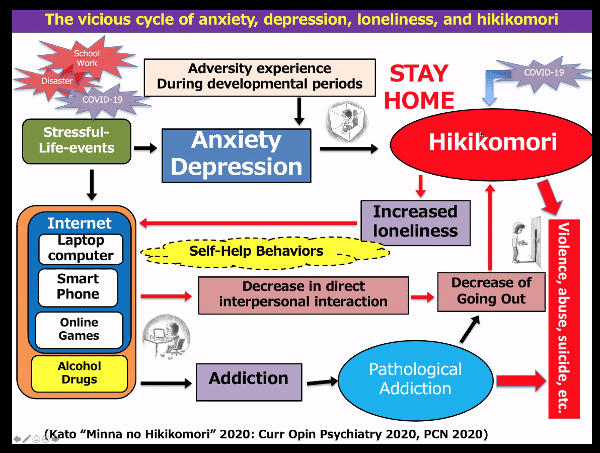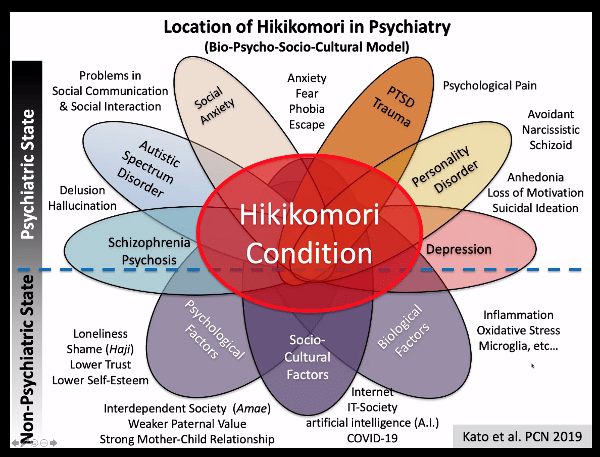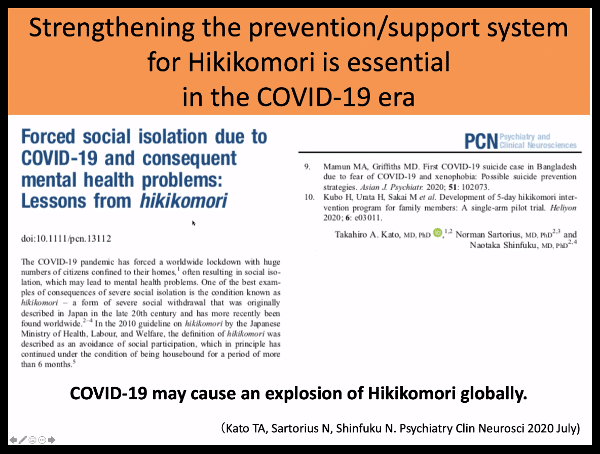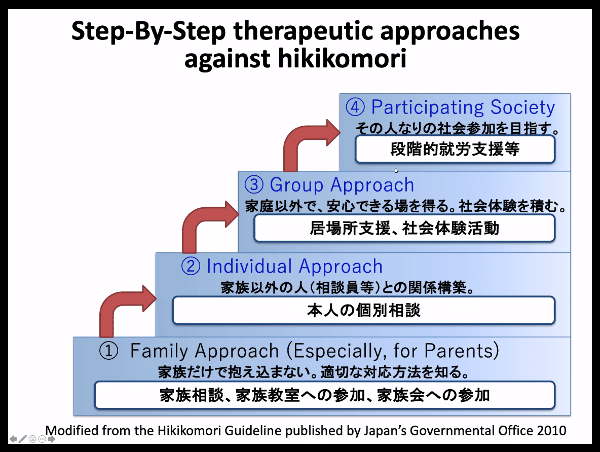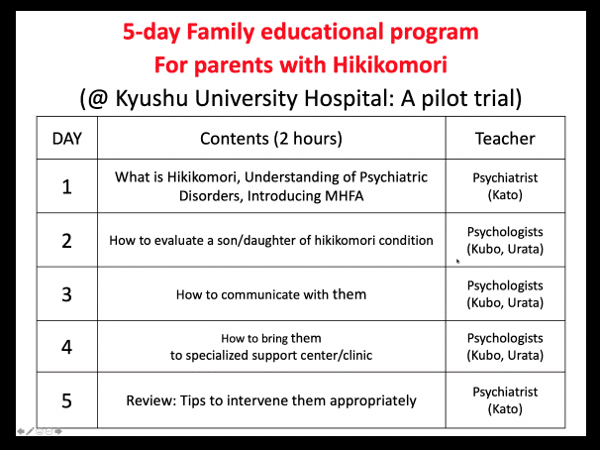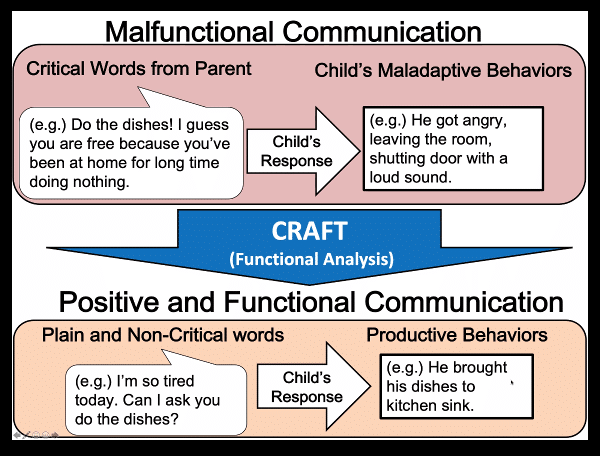Separazioni conflittuali. Conflitto, demonizzazione e paradossi nella coppia in fase di separazione – Intervista agli autori del libro
Renzo Marinello e Davide Sacchelli sono gli autori del volume Separazioni conflittuali. Conflitto, demonizzazione e paradossi nella coppia in fase di separazione, Edra Edizioni. L’intervista di Marco Schneider.
Renzo Marinello è psicologo e psicoterapeuta sistemico-relazionale ad indirizzo narrativo costruttivista, opera presso un Consultorio Familiare dell’azienda sociosanitaria territoriale Fatebenefratelli-Sacco. È stato Responsabile dei Centri di Terapia Familiare e dei Poli di Mediazione Familiare dell’ASL Città di Milano, e ha ricoperto l’incarico di Presidente della Società Italiana di Ricerca e Terapia Sistemica (SIRTS). È docente in Master di terapia di coppia e, con una collega, ha elaborato un modello di consultazione terapeutica sulla crisi di coppia integrando approccio sistemico e approccio psicodrammatico. È autore di diversi articoli apparsi su riviste specializzate, alcuni dei quali dedicati al fenomeno delle separazioni conflittuali.
Davide Sacchelli è psicologo e psicoterapeuta e specialista in Counseling psicologico, lavora da tempo nell’ambito dei servizi di Tutela Minorile della provincia di Milano come psicologo e come coordinatore di équipes psico-sociali. È presidente di ASP – Associazione italiana Psicologi. Si occupa di formazione in psicologia clinica, di terapia individuale, familiare e di coppia utilizzando un approccio sistemico ad indirizzo socio-costruzionista. E’ didatta presso il CMTF – Centro Milanese di Terapia Familiare. Da alcuni anni si dedica allo studio del fenomeno delle conflittualità post-separative e dell’alienazione parentale.
In fase di redazione dell’intervista, fondamentale è stato il contributo di Irene Colombo, psicologa in formazione presso l’Università Bicocca di Milano.
Schneider: Buongiorno Renzo, buongiorno Davide, sono molto felice di discutere con voi del tema delle separazioni, con particolare riferimento a quelle più conflittuali, sia per la vostra esperienza su questo tema che per la recente pubblicazione del vostro libro.
Inizio con il dire che parlare di famiglia oggigiorno significa sempre più parlare anche di separazioni coniugali, tanto che all’interno del ciclo di vita delle famiglie si è ormai pensato di inserire la “fase” della separazione. Oggi abbiamo percentuali di separazione coniugale che variano tra il 35 e il 40% in Italia mentre nei paesi del nord Europa la percentuale arriva addirittura all’80%, come ad esempio in Belgio. Alcuni studiosi dicono, secondo me a ragione, che esiste una correlazione positiva tra il livello di sviluppo industriale di un paese o di una società e le separazioni coniugali, nel senso che tanto più un paese è sviluppato industrialmente e culturalmente, tante maggiori sono le separazioni coniugali.
Ne consegue quindi che in un paese “avanzato” è più “normale” separarsi. Ma è anche più semplice farlo? Separarsi fa parte davvero secondo voi di un processo fisiologico normale nella società in cui siamo inseriti?
Marinello: Credo che se si vuole considerare la separazione come un processo normale, dobbiamo allora pensare al matrimonio come ad un contratto “a termine” mentre in realtà noi ci sposiamo con un progetto a lungo termine. Ciò spiega secondo me perché la separazione è molto spesso un processo difficile e doloroso. Le coppie oggi sono in qualche modo la sostituzione di quel sociale che manca (non c’è la comunità, non c’è la classe, non c’è la parentela) e quando si sfaldano è un problema importante.
Schneider: Separarsi è difficile in tutti i casi?
Sacchelli: No, non direi in tutti i casi. Ci sono situazioni nelle quali dopo la separazione alcune persone riescono a ri-raccontarsi dentro ad una storia nuova. Molte altre però non riescono e rimangono ancorate alla storia precedente. In tutto ciò un concetto fondamentale è quello di identità: la relazione definisce l’identità delle persone e quando la relazione si interrompe, soprattutto in modo traumatico ed improvviso, le persone rischiano di avere una crisi, una frammentazione della propria identità.
Certamente la separazione porta sempre con sé una dose di stress, alla quale ciascuno reagisce in modo particolare. Credo dunque che sia difficile generalizzare mentre è più opportuno guardare al caso singolo.
Schneider: E’ certamente vero che la separazione coniugale è un evento fortemente stressante: le varie scale di valutazione la collocano tra gli eventi più stressanti per una persona. Concordo poi quando dite che ogni separazione ha variabili proprie e sul fatto che l’elemento più favorevole per superare bene una separazione sia la capacità di raccontare una nuova storia, rispetto al restare ancorati a vecchie narrazioni di sé dentro a storie vecchie. L’identità si recupera nelle nuove configurazioni relazionali, il senso di sé non si perde se si riesce ad evolvere.
Sacchelli: Io parlerei proprio di “perdita di senso” nelle separazioni non elaborate e traumatiche. Quando si va incontro ad una perdita di senso si soffre e se non si riesce a ricostruire un nuovo senso si rischia di soccombere al dolore provato.
Aggiungo anche che una parte importante del senso che diamo alla nostra vita prima della separazione è legato ai figli; mai come oggi infatti le persone si riconoscono a livello identitario in qualità di genitori.
Marinello: Il legame con il figlio diventa l’ultimo legame assolutamente irrevocabile; il figlio è per sempre, e per questo è sempre più importante per l’identità.
Sacchelli: Teniamo conto che questo non vale solo per le donne: nasce l’idea dei “mammi”, padri che si occupano tanto dei figli ed instaurano un legame molto forte con loro. In alcuni casi, quando la concentrazione sul figlio diviene eccessiva, si arriva a vere e proprie situazioni di “schiavismo genitoriale”.
Schneider: Certo, i figli oggi sono per un verso sempre più centrali nella vita delle persone. Si dice che il figlio oggi debba “riuscire bene” perché questo rinforza l’autostima spesso fragile del genitore in tempi nei quali la famiglia come istituzione è in difficoltà.
Marinello: Oggi i figli sono desiderati e per tutta la vita dovranno fare i conti con questo desiderio che li ha generati.
Schneider: Il forte desiderio genera aspettative, e questo non sempre è un bene.
Chiedo a voi, tecnici con una specifica formazione sistemico-relazionale, di dirci qualcosa rispetto all’idea che la psicologia sistemica ha delle separazioni coniugali. Quali sono le variabili secondo voi fondamentali a cui dare importanza in ambito sistemico?
Sacchelli: La sistemica approccia queste situazioni con due idee: l’idea di circolarità e l’idea di contesto. Da una parte le cose succedono in maniera ricorsiva (circolarità) mentre dall’altra tutto ciò che accade nella coppia in separazione accade in un luogo (fisico e mentale) dentro al quale si muove una serie di attori i quali contribuiscono a co-determinarne gli esiti (il contesto). Ritengo che il pregio dell’approccio sistemico sia che non esiste un’idea di causalità ma che esista una connessione tra le varie parti di un fenomeno, mentre contemporaneamente si pensa alle persone come inserite in un contesto sempre ampliabile e definito da diversi autori.
Schneider: Molto interessante. Questo apre anche a possibilità differenti sia di lettura dei vari fenomeni che di intervento terapeutico; mi piacerebbe più tardi tornare su questo tema.
Noto invece che nel titolo del vostro libro è presente il tema della “demonizzazione”. Che cosa intendete esattamente?
Marinello: Il tema della circolarità viene rappresentato dalla demonizzazione: si tratta di un processo circolare ricorsivo nel quale l’altro da cui ci si è separati diventa sempre più odiato perchè sempre più temuto. In questo senso il tema della paura è molto importante: lo spavento rispetto all’altro. La demonizzazione fa ad un certo punto il suo esordio nel sistema della coppia separata: attraverso il conflitto che si crea in alcune coppie, la demonizzazione permette di recuperare un pezzo della coppia che è andato perso durante la separazione. Possiamo infatti vedere la separazione come la frantumazione di una narrazione condivisa, dell’assoluto di coppia. Si è in una deriva di senso e la demonizzazione va a sostituire quella coesione, quel senso di sé e della coppia che è stato perso. Consente di mantenere un legame tramite l’odio, dove la demonizzazione ne è il prodotto concreto. Quindi all’interno di una dinamica per la quale mi difendo dall’altro tramite azioni che vengono percepite dalla persona opposta come azioni di attacco, mantengo il legame.
Sacchelli: Nel libro si tratta anche il tema dell’incapacità umana di vedere la propria aggressività o violenza. Noi percepiamo quella altrui ma difficilmente facciamo riferimento a noi stessi. Non siamo capaci di auto-osservazione. Soprattutto quando siamo presi da un momento di rabbia vediamo solo la violenza dell’altro. Noi parliamo di demonizzazione incrociata perché si tratta di un fenomeno reciproco che si auto-alimenta: ciascuno dei due personaggi coinvolti si sente vittima e vede l’altro come “carnefice”.
Schneider: Dunque mi pare di capire che la paura da voi citata nasce dal fatto di vedersi come vittima dell’altra persona, che è vista come un carnefice?
Sacchelli: Si anche se ovviamente si parla di un “demone” mitizzato.
Schneider: La demonizzazione quindi è un aspetto individuale interpretativo del soggetto che a seguito di una rottura traumatica di una relazione arriva a coprire con esso una mancanza di senso e proietta la sua fragilità sull’altro vedendolo come un qualcuno di cui aver paura?
Sacchelli: Si. Si tratta però di un processo effettivamente molto pratico. Ad esempio le persone si sentono molto sole e questo le spinge a dipingere l’altra persona come un mostro. Inoltre devono affrontare tutta una serie di questioni quali la gestione dei figli, la separazione economica, ecc..
Schneider: Mi interessa molto la vostra idea per la quale vi sarebbe la volontà delle persone di mantenere il legame con l’ex partner tramite la demonizzazione. Ci aiutate a comprenderla meglio?
Sacchelli: Su questo aspetto abbiamo discusso durante la stesura del testo. Io non direi che c’è la voglia di mantenere un legame ma che il mantenimento del legame è semplicemente un effetto della demonizzazione. L’effetto di questa situazione, della demonizzazione, è infatti un effetto di mantenimento: le persone sono legate dai sentimenti e in questo caso rimangono legate non da un amore ma da un odio.
Schneider: Quindi il mantenimento del legame è un effetto secondario del circolo della demonizzazione?
Sacchelli: E’ un effetto secondario che fornisce senso, il senso di essere vittima.
Marinello: Vero, abbiamo discusso su questo punto. La mia idea iniziale in merito era che in qualche misura io vedevo queste coppie come aventi tra di loro una passione enorme (anche passione erotica). Credo quindi che la demonizzazione dia la possibilità certamente di sperimentare una nuova identità, la quale però resta molto collegata all’identità dell’altro, visto ora come il mio carnefice. Il legame dunque non viene perso.
Sacchelli: A proposito della demonizzazione voglio aggiungere un altro elemento, importante. Ciò che crea conflitto è la distanza. Il conflitto viene infatti alimentato dalla distanza: quando le persone si mantengono distanti tra loro non c’è bisogno di trovare una soluzione al conflitto. Quanto più si mantengono le distanze per cercare di evitare il conflitto, tanto più in realtà si evita che ci sia la risoluzione dello scontro e il conflitto può perdurare.
Schneider: Il conflitto in altre parole si mantiene in equilibrio e in vita anche grazie alla distanza tra le persone in lotta?
Marinello: Certo. Aggiungo anche che il contesto stesso ha una forte influenza sul mantenimento delle dinamiche interne alla coppia, e naturalmente anche quelle di conflitto. A questo proposito e allargando il campo di discussione dobbiamo dire che i sistemi clinici [della cura, ndr] tendono a separare le persone, a vederle separatamente e ciò in qualche misura implica l’idea che la distanza sia necessaria per evitare il conflitto, ma non è così. Anzi, ciò alimenta la paura.
Schneider: Davvero interessante. Ci avete dato un’idea da un punto di vista individuale di cosa succede durante le separazioni e di cosa sia la demonizzazione vista in un’ottica interattiva. Vorrei adesso riprendere quanto Renzo diceva prima sul contesto. Cosa ne pensate in particolare del ruolo del contesto familiare, dal punto di vista sistemico, nel mantenimento della demonizzazione?
Sacchelli: Le famiglie hanno un ruolo importante, spesso di amplificazione della demonizzazione. Spesso tendono a rinforzare il processo di vittimizzazione del proprio figlio anche se ci sono casi in cui la famiglia di origine vede la figlia/o come carnefice e sostiene questo ruolo.
In particolare però soprattutto nei casi di separazioni conflittuali la famiglia contribuisce a definire il senso degli eventi secondo una bipolarità (buono-cattivo, abusante-abusato, chi ha torto e chi ha ragione) e definisce una logica “bipolare” di funzionamento delle cose.
Marinello: Mentre la coppia si muove sulla bipolarità vittima-carnefice, il sistema giuridico e la famiglia si muovono sulla bipolarità colpevole-innocente. Si tratta di logiche in realtà molto simili che vanno ad amplificare la demonizzazione. Il modo in cui si muove la coppia è dunque omologo nella sostanza al sistema giuridico e a quello familiare. L’interazione di questi sistemi fornisce dunque un incremento e un mantenimento della demonizzazione.
Schneider: Considerando adesso i vari contesti che intervengono soprattutto nelle situazioni più conflittuali, vi faccio una domanda sull’aspetto terapeutico. Come clinici che cosa guadagnate e che cosa perdete con il vostro approccio?
Marinello: Abbiamo costruito un modello di intervento coerente con le premesse da cui siamo partiti. Nella prima fase si lavora con le famiglie di origine, con gli avvocati, introducendo eventualmente nel macrosistema anche dei conoscenti, degli amici che possono aiutare gli ex partner e facendo varie proposte alla coppia, in particolare quella di lavorare con il macrosistema.
Sempre importante è la comunicazione, e lo è ancora di più in questa fase. Considerando come abbiamo detto che la distanza mantiene il conflitto, può essere utile far comunicare le persone direttamente. Si propone alle persone un progetto dicendo loro che la comunicazione diretta aiuta, si cerca di fare in modo che il macrosistema da elemento amplificatore diventi un elemento di ostacolo, di blocco del conflitto.
Sacchelli: L’obiettivo è sia quello del depotenziamento del conflitto sia del riconoscimento; quando si è all’interno di una situazione conflittuale ci si riconosce come vittime e si pensa semplicemente a difendersi dal carnefice, non si riescono a riconoscere le proprie responsabilità nel conflitto. Una parte importante del processo terapeutico è quindi riuscire a fornire questa consapevolezza.
Sostengo che con questo approccio perdiamo “fin troppo poco”: questo approccio si occupa infatti della complessità. Stare in mezzo ad un conflitto è difficile ed essendo le situazioni molto complesse tendiamo a tenere in conto tutti i fattori.
Schneider: Vi chiedo come si liberano secondo voi le persone da questa posizione e da questo coinvolgimento nel conflitto, visto che spessissimo è un conflitto particolarmente accesso e le persone difficilmente riescono a decentrare il loro punto di vista.
Marinello: Parlando di esternalizzazione. Proviamo a vedere se c’è la possibilità di risignificare per le persone ciò che sta accadendo ponendo il conflitto come una parte terza, un ente dotato di vita e dimensione propria che va a schiacciare i due partner. In questo modo entrambi sono vittime di questo conflitto. Se questo passaggio avviene, si prosegue; esternalizzare è dunque il primo punto, il passaggio successivo consiste nell’assunzione di responsabilità nei confronti del conflitto.
Schneider: Mi pare di capire che secondo la vostra proposta per “curare” le persone da questo conflitto sia necessario in primo luogo unire la coppia “contro” il conflitto stesso, e in secondo luogo è necessario riconoscere le proprie responsabilità: bisogna insomma far capire la posizione di ciascuno rispetto a questo “organismo esterno” che è il conflitto, per modificarla.
Quanto è importante secondo voi focalizzarsi sul singolo e sulle sue responsabilità o all’opposto comprendere le logiche triadiche alla base del conflitto?
Sacchelli: Nelle separazioni conflittuali la relazione triadica esiste più tra i partner e i figli piuttosto che con la famiglia d’origine.
Schneider: Questo è interessante perché la letteratura ci dice che la grandissima parte delle coppie che si separa in maniera conflittuale è composta da coppie con figli: la percentuale di coppie che non ha figli e che ha una separazione conflittuale è infatti molto bassa. I figli sembrano quasi essere una condizione necessaria affinchè si sviluppi una separazione altamente conflittuale.
A tal proposito oggi una delle questioni più dibattute è il tema della sindrome da alienazione genitoriale. Ci aiutate a capire che cos’è? Come avviene? Cosa ne pensa la psicologia sistemica?
Sacchelli: La sistemica non si occupa molto della sindrome da alienazione genitoriale. Noi abbiamo cercato di trattarla nel libro.
Marinello: Noi la definiamo come una “condizione sistemica” della relazione familiare. I figli non hanno una narrazione condivisa sulla separazione, le narrazioni sono generalmente speculari e opposte; l’alienazione ha a che fare con queste narrazioni ed è scelta del figlio a quale narrazione aderire. L’alienazione in qualche modo è la forma più stabile di adattamento perchè consente di togliersi dal conflitto. Qualsiasi adattamento i figli mettano in atto diventa sempre un potenziatore del conflitto. La demonizzazione attraverso il processo di alienazione cresce sempre di più.
Schneider: Possiamo forse pensare all’alienazione come ad un modo da parte dei figli per sottrarsi ad una situazione insostenibile che è lo stare dentro a due narrazioni inconciliabili?
Marinello: L’alienazione riesce ad affrontare la marginalizzazione del figlio e riesce a porre un fine al conflitto di lealtà in quanto si ha un’alleanza forte con una parte.
Sacchelli: L’alienazione è sostanzialmente un rifiuto dell’altro genitore, del genitore non convivente. Noi pensiamo che i figli siano dei soggetti attivi nello scegliere di rifiutare l’altro genitore e pensiamo anche che condividano la relazione demonizzante del genitore convivente, in quanto questo serve per mantenere il legame.
Schneider: Molto interessante. Vi chiedo ora se secondo voi un genitore collocatario di un figlio alienante riesca meglio a staccarsi dal partner perchè ritrova il senso nel legame costruito con il figlio. L’alienazione consente quindi di “liberarsi” in modo più veloce ed efficace dell’ex partner?
Sacchelli: Nella nostra esperienza i genitori “se ne lavano le mani” e dicono al figlio di decidere. Una cosa che caratterizza il nostro approccio è la non intenzionalità; non si tratta di una manipolazione ma di assorbire anche da parte dei figli la paura verso l’altro genitore in quanto fanno parte della relazione demonizzante. Questo approccio ci permette dunque di non colpevolizzare i genitori. Tengo anche a dire che il genitore rifiutato ha anch’esso un ruolo attivo: vengono infatti da lui messi in atto una serie di comportamenti basati su paura, insicurezza e sulla vergogna che sono comportamenti di ritiro. Ad esempio il genitore non si fa sentire proprio per paura di essere rifiutato ma ciò viene percepito dal figlio come abbandono e va a rinforzare l’alienazione.
Importante è anche la questione dell’assenza di aspetti normativi; nell’alienazione il figlio rifiuta la normatività, le regole del genitore alienato, rifiuta il ruolo genitoriale del genitore non convivente.
Schneider: Quali sono le vostre linee terapeutiche rispetto all’alienazione?
Sacchelli: La linea terapeutica usata si propone un riavvicinamento all’altra persona. In questo senso fondamentale è ridurre la paura e arrivare ad un incontro tra le due parti. Durante l’incontro si cerca anche in questo caso di esternare il conflitto.
Schneider: Importantissimo quindi mi sembra per voi il lavorare sulla meta-comunicazione, sull’uscire dalla dimensione del contenuto per lavorare su una dimensione di più alto livello logico. Inoltre mi sembra che riteniate fondamentale disinnescare la paura dell’altro.
Sacchelli: Noi parliamo di intervento di “innesco della generatività”. La demonizzazione crea una situazione di impoverimento: vediamo l’altra persona solamente come un mostro, un demone e subiamo dunque un impoverimento della capacità creativa di sviluppare e inventare nuovi significati. Abbiamo un blocco della cosiddetta mentalizzazione. E’ utile aiutare le persone a sbloccarsi e a riuscire a trovare nuove narrazioni che non siano quelle della demonizzazione per spiegare quello che è successo e quello che succede in quanto ciò consente di ridurre la paura. Questo meccanismo aiuta a vedere le persone come essere umani e non più come demoni.
L’intervista è stata fatta nel mese di gennaio 2020.