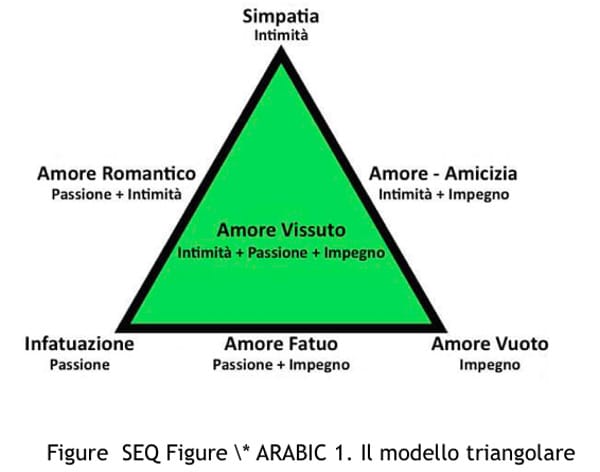Il militare e la sua famiglia: due facce della stessa medaglia
Madri, padri, mogli, mariti, figli più o meno grandi, fratelli…tutti i familiari, l’altra faccia della medaglia, vivono da casa la missione dei militari.
Mariasilvia Rossetti e Serena Pierantoni – OPEN SCHOOL Studi Cognitivi, San Benedetto del Tronto
“Mamma, papà, da grande voglio fare il
militare!”, più o meno è un mestiere che inizia così. A volte, perché in
famiglia vi è già qualcuno che ha percorso questa strada e, allora, quel bambino ha il desiderio di seguire le orme del proprio genitore o parente, altre perché è una passione che si sviluppa crescendo.
Questa scelta, però, coinvolge un po’ tutte le persone che ruotano intorno a chi sceglie di fare il militare, soprattutto quando arriva la notizia che non vorresti mai arrivasse: “Devo partire per andare in missione”.
Non puoi dire di no? Per quanto? Dove? È pericoloso? Quando torni? Sono solo alcune domande che, chi resta a casa, si pone ogni giorno, emotivamente impreparato a gestire tale situazione.
Madri, padri, mogli, mariti, figli più o meno grandi, fratelli…tutti i familiari, l’altra faccia della medaglia, vivono da casa la missione.
Cosa succede quando chi parte lascia a casa un bambino piccolo o che ancora deve nascere? Come impatta questo lavoro sulle dinamiche familiari? Quali sono i risvolti? Quali problematiche scaturiscono?
Lo stress inizia prima ancora della partenza per la missione e colpisce entrambi i membri della famiglia, nonché i figli: chi parte si prepara psicologicamente e fisicamente per quello che dovrà affrontare; chi resta deve prepararsi a gestire la famiglia da solo e vive con la preoccupazione circa la sicurezza del coniuge in missione (Lieberman & Van Horn, 2013).
Le famiglie di militari vivono in un clima di stress persistente, rispetto alle famiglie civili, in quanto sperimentano spesso la separazione a causa di posti di lavoro lontani da casa, addestramenti, esercitazioni e missioni, per periodi più o meno lunghi, vivono con la consapevolezza del rischio associato al servizio militare, sia esso danno fisico, psicologico o, nei casi più gravi, la morte. Questi fattori stressogeni associati alla vita militare portano ad un continuo sconvolgimento nelle dinamiche relazionali e familiari (Daigle, 2013). Pertanto, queste famiglie potrebbero costituire una popolazione altamente vulnerabile, rispetto alla popolazione generale, qualora i fattori stressogeni vengano gestiti in modo non funzionale, con ripercussioni sia a livello fisico, psicosociale che psicologico.
Tra i sintomi a livello fisico si riscontrano disturbi del sonno, affaticamento, stanchezza o poca energia, mal di testa, tachicardia, variazioni nell’appetito e cambiamenti di peso, i quali aumentano all’aumentare del livello di stress percepito (Padden& Posey, 2013; Burton, Farley & Rhea, 2009). Ovviamente, i sintomi e le problematiche, dipendono dalla lunghezza, dalla durata e dalla frequenza con cui un militare parte per la missione.
Gli effetti di una missione sulla famiglia dei militari
Una revisione sistematica condotta nel 2014 (Creech, Hardley& Borsari) ha analizzato circa 40 studi svolti per indagare gli effetti che una missione ha sui genitori, i bambini e gli adolescenti, mostrandone il suo impatto pervasivo e negativo. In particolare, hanno rilevato che i bambini che crescono in “famiglie militari” hanno significativamente più problemi di salute mentale, tra cui ansia, depressione, problemi comportamentali esternalizzanti, fino all’uso di sostanze e all’ideazione suicidaria, rispetto ai figli di “famiglie civili”. Pressley et al. (2012) hanno rilevato come i bambini più grandi, figli di famiglie militari, avevano maggiore probabilità di ricevere una diagnosi da parte del dipartimento di salute mentale e di essere ricoverati in ospedale per tentativi di suicidio.
Una ricerca volta a determinare gli effetti causati da un parente militare che parte per una missione sul numero di visite mediche ambulatoriali che coinvolgono i figli, di età compresa tra i 3 e gli 8 anni, ha rilevato che aumentano dell’11% il numero di visite volte a valutare la salute mentale e le problematiche comportamentali; aumentano del 19% i disturbi del comportamento e del 18% i disturbi legati allo stress (Gorman, Eide& Hisle-Gorman, 2010). Tale ricerca ha, inoltre, evidenziato l’interazione tra la missione e il genere del genitore militare: quando è l’uomo ad essere militare i tassi di visite ambulatoriali aumentano, rispetto a quando ad essere militare è la donna. Questi risultati suggeriscono che nel primo caso vi sono un maggiore riconoscimento dei problemi del bambino da parte dell’adulto e della capacità di portare questi problemi all’attenzione di un professionista. Le visite ambulatoriali aumentano anche nella condizione in cui i figli sono più grandi e i genitori coniugati.
Il senso di sicurezza e di protezione che un bambino piccolo sviluppa, soprattutto nei primi anni di vita, dipende totalmente dalla disponibilità fisica ed emotiva che viene mostrata dai suoi genitori. È facile, quindi, comprendere quanto possa essere difficile per un bambino piccolo la lunga assenza di un suo genitore. Nel caso in cui il genitore parta per una missione quando il piccolo è ancora in grembo o nei suoi primi mesi di vita, mesi in cui si creano, si formano le basi e stabiliscono le relazioni di attaccamento, al ritorno potrebbe riunirsi con un bambino che, non solo è molto diverso e cresciuto rispetto a quello che hanno lasciato, ma che non ha alcun ricordo del genitore, sia esso il padre o la madre; inoltre, non ha nessuna relazione consolidata dalla quale attingere (Mutter, 2004).
Infatti, mentre i bambini più piccoli potrebbero non comprendere appieno il motivo per cui un genitore deve andarsene e potrebbero reagire con rabbia, i bambini più grandi e gli adolescenti devono affrontare la lontananza del genitore durante una fase critica e rapida dello sviluppo sociale ed emotivo, che è già impegnativo di suo, in quanto caratterizzato da scelte scolastiche da effettuare, modificazioni corporee, nonché la costruzione dell’identità.
A partire dagli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001 a New York, sono aumentati i periodi di permanenza in missione e questo ha comportato un aumento dei disturbi di salute mentale, incluso il
disturbo da stress post-traumatico (PTSD). Le ricerche, inoltre, mostrano che più è lunga la durata della missione, maggiori sono le difficoltà a cui la famiglia e i figli vanno incontro. Oltre al già citato PTSD, aumentano i rischi per la depressione, i disturbi del sonno, lo stress coniugale e i
divorzi (Negrusa, Negrusa & Hosek, 2014; Tanielian, Tanielian& Jycox, 2008). Le reazioni dei coniugi alla partenza per una missione riguardano irritazione, tensione, incredulità, aumento della distanza emotiva, sintomi somatici, shock, sentimenti di rabbia verso chi parte.
Ciò che influenza queste problematiche non è la missione militare in sé, ma lo stress che questo evento provoca e l’eventuale presenza di problematiche psicopatologiche nel genitore che resta a casa. I fattori di rischio e i fattori di resilienza interagiscono tra loro e vanno ad influenzare le relazioni psicosociali tra il genitore che resta a casa e il bambino, le quali, a loro volta, producono conseguenze dirette sul bambino (Palmer, 2008). L’aumento dello stress nel genitore che resta a casa e l’assenza del genitore militare, impattano negativamente sulla qualità delle interazioni genitore-figli: probabilmente i bambini ricevono meno contatti fisici ed emotivi, rispondono allo stress dei genitori e apprendono la loro stessa modalità di rispondere allo stress. I bambini, siano essi neonati o in età prescolare, sono abili nel leggere le espressioni facciali, nell’interpretare il tono della voce del genitore, percepiscono che qualcosa è cambiato. Sentono lo stress provato dal genitore e potrebbero rispondere con maggiore irritabilità che, a sua volta, fa scaturire reazioni di rabbia e impazienza nell’adulto, che poi si sente in colpa per non essere emotivamente, né fisicamente, disponibile per il bambino (Lieberman & Van Horn, 2013).
Gli effetti del pendolarismo dei militari sulla famiglia
Oltre alla missione, che prevede la permanenza all’estero di vari mesi, un altro fenomeno importante, che impatta sul contesto familiare, è quello del pendolarismo (Ferri, 2021). Sembra una soluzione che garantisce l’unità della famiglia, ma solo a prima vista, in quanto oltre a sopportare le ore del viaggio, il militare pendolare trascorre dentro la propria casa un numero ristretto di ore. Questo comporta una limitazione nel dialogo e nell’interazione con i propri cari che potrebbe portare a stanchezza, irritabilità e difficoltà di comunicazione, che, se gestite in modo non funzionale e scorretto, potrebbero condurre a problematiche correlate allo stress, quali depressione, traumi e disturbi di vario genere.
Tuttavia però, non sempre è così. Nel caso di un adolescente, l’assenza di un genitore potrebbe anche avere risvolti non negativi e portare ad uno sviluppo maggiore dell’autonomia e del senso di responsabilità, che andrebbero a costituire un terreno molto fertile per la resilienza, cioè la capacità di affrontare un evento stressante o traumatico e di saper riorganizzare positivamente la propria vita di fronte alle difficoltà. Inoltre, i bambini i cui genitori sono in grado di rispondere in modo più sensibile ai loro bisogni emotivi e hanno una relazione forte come coppia probabilmente avranno capacità più sane per la regolazione delle emozioni e per lo sviluppo psicosociale generale (Paris, DeVoe, Ross, & Acker, 2010).
Il ricongiungimento tra militari e famiglia
Missione, trasferimento e il ricongiungimento, tanto atteso, sono tre fenomeni che causano stress sulla famiglia militare (Drummet, Coleman & Cable, 2003).
Anche il momento del ricongiungimento tra il militare che rientra dalla missione e la sua famiglia è caratterizzato da un alto livello di stress, seppur un momento tanto atteso, in quanto include la paura del rifiuto, sentimenti di esclusione, fino alla depressione. Dopo il ricongiungimento potrebbero aumentare i conflitti e le difficoltà coniugali, nonché i tassi di divorzio, in quanto la comunicazione tra adulti risulta essere alterata, l’intimità è diminuita a causa del periodo passato distanti e, spesso, si trovano in disaccordo sulla disciplina e l’educazione dei figli o su scelte che sono state prese durante il periodo trascorso separati. La famiglia deve di nuovo riorganizzarsi.
La salute mentale dei bambini figli di militari
Vi sono poi altri fattori che influenzano la salute mentale dei bambini che crescono in famiglie militari.
Come già accennato, uno dei più importanti è la salute mentale dei genitori, sia di quello militare che di quello che resta a casa e si occupa della prole. Questo aspetto non si discosta molto dalle dinamiche che si creerebbero anche in una famiglia civile, dove uno dei due genitori ha problematiche psicopatologiche, ma se si vanno ad aggiungere ai fattori stressogeni dovuti alla missione, espongono la famiglia ad un maggior rischio di vulnerabilità. Se, ad esempio, la madre mette in atto una risposta di tipo depressivo, anche i figli potrebbero rispondere rispecchiando tali sintomi. Altro fattore che potrebbe pesare sulla salute mentale del bambino è la differenza individuale tra ogni bambino, nonché lo stile di personalità (Cramm et al., 2019).
Le ricerche mostrano che a fare la differenza è anche il ramo dell’esercito in cui il genitore presta servizio e il grado che occupa, in quanto, questo ultimo aspetto è indicatore sia della responsabilità, che dello stato socio economico della famiglia. Altro aspetto a volte sottovalutato, riguarda le notizie mediatiche che, spesso, risultano essere distorte o incomplete e, pertanto, vanno ad incrementare il livello di stress di chi resta a casa.
Una revisione sistematica della letteratura ha evidenziato come le strategie di coping di un bambino dipendono dalla sua età e dallo sviluppo raggiunto, dalla salute mentale e la capacità di coping del genitore che resta a casa, dalla salute mentale di entrambi i genitori, dalle vulnerabilità preesistenti, dalla capacità di resilienza e dalle risorse presenti (Bello‐Utu & DeSocio, 2015). Un altro studio del 2016 (Lester et al.,), condotto per esaminare l’associazione tra esposizione al combattimento, l’adattamento piscologico dei genitori, la genitorialità, il funzionamento familiare e l’eventuale instabilità, ha messo in relazione salute-comportamento dei genitori, stile della genitorialità e adattamento sociale ed emotivo del bambino (di età compresa tra 0 e 10 anni) durante il periodo in cui un genitore era schierato. I risultati mostrano che all’aumentare del periodo di esposizione alla missione, aumentano le difficoltà di comunicazione che diventa meno sana, si riduce il coinvolgimento affettivo e la modalità di risoluzione dei problemi risulta essere meno efficace. Questi processi familiari, a loro volta, aumentano lo stress percepito, influenzano negativamente la capacità di resilienza familiare e il benessere del bambino. In conclusione, la maggiore sensibilità dei genitori e un buono stile comunicativo sono associate a un migliore adattamento del bambino.
Alla luce di quanto detto, è necessario che entrambe facce della stessa medaglia, vengano supportate psicologicamente, sia a livello di prevenzione, che durante i periodi di maggiore stress, attraverso la psicoeducazione, gruppi di sostegno per militari e civili e, se necessari, percorsi di psicoterapia.