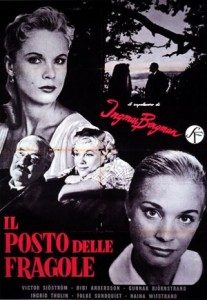Dalla psicopatologia cantata alla Psicantria della vita quotidiana
In sintonia con la moda holliwoodiana dei sequel delle opere prime, anche noi “psicantrici” abbiamo sentito l’esigenza di dare un seguito a “La Psicantria: manuale di psicopatologia cantata”, uscito nel 2011 per questo stesso editore, con un nuovo libro-CD intitolato “La Psicantria della vita quotidiana”.
Il titolo ha un chiaro riferimento alla celeberrima opera di Freud (1901), in quanto questa volta la nostra attenzione si è concentrata sugli scenari psicopatologici che si possono incontrare nel nostro vivere quotidiano, anche al di fuori dei luoghi di cura. L’aggressività all’interno dei gruppi, l’influenza delle tecnologie sul nostro modo di relazionarci all’altro, la difficoltà a costruirsi un’identità stabile sono alcuni dei temi che trattiamo in queste canzoni, nate dalle nostre osservazioni effettuate in contesti clinici e, più largamente, sociali.
Ma facciamo un passo indietro.
La Psicantria è andata oltre i confini della pubblicazione, diventando un progetto educativo e culturale, che ci ha dato la possibilità, attraverso le canzoni e i concerti di presentazione, di entrare in contatto con tantissime persone vicine e lontane dallo psicomondo. I contesti nei quali abbiamo presentato lo spettacolo di psicopatologia cantata sono stati molteplici: biblioteche, scuole superiori, teatri, università, congressi scientifici, festival legati salute mentale, eventi organizzati da associazioni di volontariato e cooperative sociali, centri di salute mentale.
Al nostro psicotour è stato riconosciuto nel 2012, con grandissima soddisfazione, il premio “Nessuno mi può giudicare” contro lo stigma in psichiatria, promosso dall’ASL di Lucca. Questo riconoscimento ci ha riempito di orgoglio in quanto crediamo fermamente che lo stigma nei confronti delle persone affette da disturbi psichiatrici sia ancora molto presente nella nostra società, con grandi ripercussioni sull’accesso alle cure e sulla riabilitazione. Più che le scoperte di nuovi recettori neuronali da parte dei neuroscienziati o di innovative tecniche psicoterapiche, siamo convinti che un atteggiamento più accogliente e meno giudicante nei confronti di coloro che vivono le difficoltà quotidiane della malattia mentale, sia il primo passo da fare per migliorare concretamente la loro qualità di vita, con ripercussioni positive sul disturbo stesso.
Ci sono tanti aneddoti di questi tre anni che ricordiamo con piacere e un po’ di incredulità. Non ci saremmo mai aspettati, ad esempio, di ascoltare una versione punk di Jessica l’anoressica, eseguita da una band di liceali di Belluno, di intervenire con la chitarra a congressi nazionali di psicoterapia e musicoterapia, di cantare un grande successo di Caterina Caselli con una psychiatric band a Capannori (LU), di esibirci al premio Lunezia 2012 insieme a Bobo Rondelli e Paolo Jannacci, di essere recensiti positivamente dall’ostico critico musicale Mario Luzzatto Fegiz, o di ritrovarci autori di una canzone nell’ultimo disco di Francesco Guccini.
Abbiamo avuto l’onore di suonare in diverse università italiane per il Segretariato Italiano Studenti in Medicina e uno studente di Ferrara, fino a quel momento avviato verso un futuro da anestesista, dopo aver assistito al concerto ha deciso di scegliere psichiatria. Che responsabilità! La cosa divertente è stata che a un successiva presentazione a Venezia si è presentato il padre dello studente che evidentemente voleva capire meglio il cambio di rotta del figlio. Per fortuna non sembrava arrabbiato!
L’aggettivo psicantrico è ormai entrato nello slang dei nostri social network, identificando un’attitudine alla sdrammatizzazione e all’uso dell’ autoironia come registro comunicativo per entrare in sintonia con l’altro.
L’obiettivo divulgativo e psicoeducativo di Psicantria è stato raggiunto pienamente, grazie soprattutto al potere dello strumento canzone, in grado di stimolare l’identificazione e la condivisione emotiva dei vissuti dei protagonisti dei brani.
In molti ci hanno chiesto se le canzoni psicantriche possano essere utilizzate come terapia. Fino ad oggi non le abbiamo mai sperimentate in prima persona perché non ci sembra opportuno presentarci ai pazienti nella doppia veste di cantautori e terapeuti, con il rischio di creare confusione. Abbiamo invece
diverse testimonianze di colleghi che hanno utilizzato le nostre canzoni sia in percorsi terapeutici individuali, sia in gruppi di psicoeducazione con buoni risultati.
I feedback che abbiamo ricevuto sono positivi e le canzoni vengono generalmente apprezzate dalla gran parte dei pazienti che, riuscendo a riconoscersi nelle storie che cantiamo, possono trovare l’occasione di distanziarsi dalla propria esperienza dolorosa, rileggendola da un’altra prospettiva. Ci sono stati pure riportati casi di pazienti con profili caratteriali di tipo paranoide per cui può essere sconsigliato l’uso dei brani, soprattutto quelli che trattano i temi in modo ironico. Riteniamo comunque che le potenzialità dell’utilizzo dei nostri brani in ambito clinico debbano essere ancora approfondite e meritino ulteriori sperimentazioni in diversi contesti terapeutici. A questo riguardo abbiamo iniziato a raccogliere materiale sull’uso della canzone come strumento di cura e speriamo in futuro di produrre una pubblicazione su questo argomento.
Crediamo sia importante segnalare che le canzoni della psicantria sono state molto apprezzate anche dagli operatori dello psicomondo (medici, psicologi, infermieri, educatori, tecnici della riabilitazione psichiatrica…), che forse si sono identificati con il messaggio di sdrammatizzazione contenuto in alcuni nostri brani. Un operatore di Cremona ci ha confidato che ogni mattina, recandosi al lavoro, si “caricava” ascoltando il nostro CD in auto. Che soddisfazione!
Lavorare quotidianamente con la sofferenza psichica può essere davvero usurante, ma rappresentare il disagio in una prospettiva diversa e che stimoli la nostra curiosità ci salva dalla cosiddetta “cronificazione”, cioè il pensare che le malattie psichiatriche siano entità statiche e inguaribili. D’altra parte come scrive Saraceno (1995)
“la Salute Mentale è l’insieme delle azioni di promozione, prevenzione e cura riferite al miglioramento o al mantenimento o alla restituzione della Salute Mentale”.
Le canzoni, come altre forme artistiche, possono giocare un ruolo importante nella promozione e nella prevenzione, come potente veicolo di psicoeducazione. In certi contesti come la scuola, la canzone può avere più effetto di tanti discorsi e ce ne siamo resi conto di persona durante l’attività di prevenzione al disagio psichico negli istituti modenesi. Quando imbracciavamo la chitarra calava il silenzio sulla sala, quando iniziavamo a parlare ripartiva il brusio. Del resto per tanti ragazzi la canzone è ancora il principale mezzo di trasmissione culturale (Greenfield et al., 1987), molto più dei libri e dei film. Si pensi ad esempio alla diffusione tra gli adolescenti della musica rap, che in qualche modo rappresenta, per i contenuti di impegno e critica sociale, una forma attualizzata di musica cantautorale.
Nelle nuove canzoni, come accennato in precedenza, il nostro telescopio psicantrico è stato puntato sulle nuove famiglie, sul mondo della scuola, sul disagio giovanile. I temi sono un po’ cambiati rispetto al primo CD, ma l’uso dell’ironia e la modalità di comporre le canzoni a quattro mani sono rimaste le stesse. Per i contributi del libro ci siamo rivolti a bravissimi colleghi psicologi e psichiatri, opinion leaders a livello nazionale negli argomenti trattati, molti dei quali conosciuti proprio attraverso i concerti psicantrici, a cui abbiamo chiesto di produrre riflessioni partendo dai testi delle nostre canzoni. Per rendere il libro ancora più polifonico, per il brano La felicità abbiamo avuto l’onore di includere il commento di un monaco buddista, che visto l’argomento della canzone, ci sembrava il più esperto a riguardo. Buon ascolto e buona lettura!
ARGOMENTI CORRELATI:
MUSICA – MUSICOTERAPIA – NEUROMUSICOLOGIA
ARTICOLO CONSIGLIATO:
BIBLIOGRAFIA:
Palmieri G., Grassilli C. (2014). Psicantria della vita quotidiana. Edizioni La Meridiana. Libro più CD audio. SFOGLIA l’ANTEPRIMA – ACQUISTA ADESSO – ACQUISTA ALBUM MP3
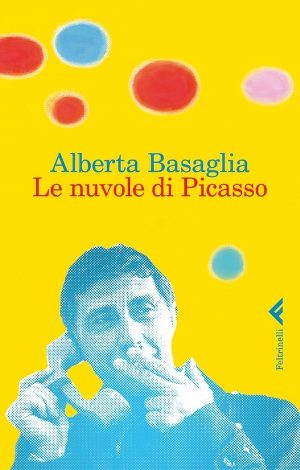 Alberta Basaglia ci riporta agli anni di Gorizia dalla prospettiva di una bimba che, con l’alibi dell’ingenuità e della purezza tipici di quell’età, ci fa scoprire quel mondo di fermento rivoluzionario, di bizzarri personaggi con i quali si ritrovava a condividere la propria quotidianità anticonformista fatta di musica, disegni e un papà freneticamente appassionato del proprio lavoro e instancabilmente impegnato, quasi per una corsa contro il tempo, a raggiungere un traguardo importante che riesce a mettere a segno quasi al 90° minuto.
Alberta Basaglia ci riporta agli anni di Gorizia dalla prospettiva di una bimba che, con l’alibi dell’ingenuità e della purezza tipici di quell’età, ci fa scoprire quel mondo di fermento rivoluzionario, di bizzarri personaggi con i quali si ritrovava a condividere la propria quotidianità anticonformista fatta di musica, disegni e un papà freneticamente appassionato del proprio lavoro e instancabilmente impegnato, quasi per una corsa contro il tempo, a raggiungere un traguardo importante che riesce a mettere a segno quasi al 90° minuto.



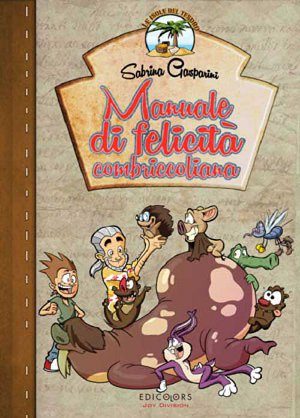 Per gli adulti non sempre si rivela facile parlare di emozioni con i più piccoli e talvolta comprendere il loro mondo interno non sembra essere cosa da poco.
Per gli adulti non sempre si rivela facile parlare di emozioni con i più piccoli e talvolta comprendere il loro mondo interno non sembra essere cosa da poco.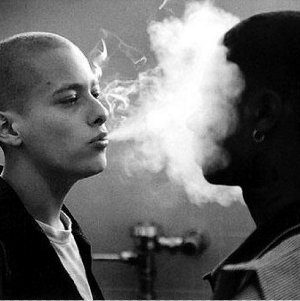 Il pregiudizio rappresenta un fenomeno complesso, a cavallo tra la dimensione sociale e quella individuale, spesso foriero di problemi e tensioni che si ripercuotono pesantemente sulle società multietniche dell’inizio del XXII° secolo.
Il pregiudizio rappresenta un fenomeno complesso, a cavallo tra la dimensione sociale e quella individuale, spesso foriero di problemi e tensioni che si ripercuotono pesantemente sulle società multietniche dell’inizio del XXII° secolo.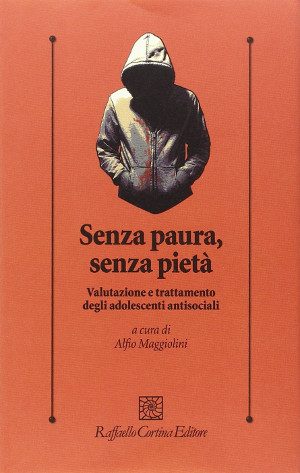 Il testo, a cura di Alfio Maggiolini e del gruppo di studio de Il Minotauro, si pone come una lettura completa ed esaustiva per la presa in carico, diagnosi e trattamento degli adolescenti che commettono reati o che hanno una condotta cosiddetta “deviante”.
Il testo, a cura di Alfio Maggiolini e del gruppo di studio de Il Minotauro, si pone come una lettura completa ed esaustiva per la presa in carico, diagnosi e trattamento degli adolescenti che commettono reati o che hanno una condotta cosiddetta “deviante”. Risulta sempre più importante accompagnare gli adolescenti a riconoscere che internet è come un oceano immenso da esplorare portando con sé consapevolezza, responsabilità e un atteggiamento di autotutela e protezione; se, infatti, la rete è un mondo di comunicazione piuttosto libero, onesto e di condivisione paritaria è anche un contesto in cui la protezione della propria privacy e della propria riservatezza è messa duramente alla prova.
Risulta sempre più importante accompagnare gli adolescenti a riconoscere che internet è come un oceano immenso da esplorare portando con sé consapevolezza, responsabilità e un atteggiamento di autotutela e protezione; se, infatti, la rete è un mondo di comunicazione piuttosto libero, onesto e di condivisione paritaria è anche un contesto in cui la protezione della propria privacy e della propria riservatezza è messa duramente alla prova. I ragazzi imparano da noi. E se non proponiamo loro benessere e soddisfazioni da un mondo vivace e partecipato, loro si arrangiano come possono.
I ragazzi imparano da noi. E se non proponiamo loro benessere e soddisfazioni da un mondo vivace e partecipato, loro si arrangiano come possono.

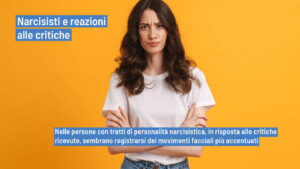










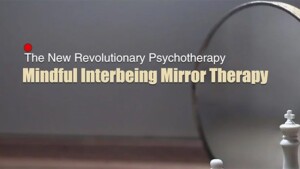





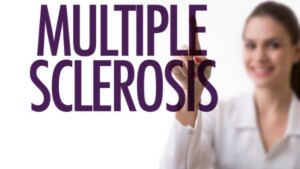

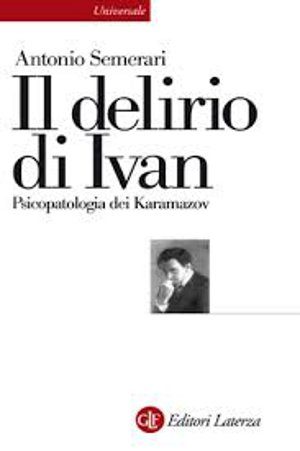 È un lavoro stimolante, curioso e gonfio di amore per la psicologia e anche per la letteratura d’autore. Incoraggerà chi già aveva incontrato i fratelli Karamazòv a volgere uno sguardo clinico verso di loro, magari aprendo spazio ad una diversa comprensione delle azioni degli stessi; sicuramente invoglierà chi non li ha ancora incontrati, ad andar a bussare alla loro porta.
È un lavoro stimolante, curioso e gonfio di amore per la psicologia e anche per la letteratura d’autore. Incoraggerà chi già aveva incontrato i fratelli Karamazòv a volgere uno sguardo clinico verso di loro, magari aprendo spazio ad una diversa comprensione delle azioni degli stessi; sicuramente invoglierà chi non li ha ancora incontrati, ad andar a bussare alla loro porta. Un film di Darren Aronofsky, con Mickey Rourke, Marisa Tomei, Evan Rachel Wood, Mark Margolis, Todd Barry. Drammatico. Francia-USA 2009.
Un film di Darren Aronofsky, con Mickey Rourke, Marisa Tomei, Evan Rachel Wood, Mark Margolis, Todd Barry. Drammatico. Francia-USA 2009.