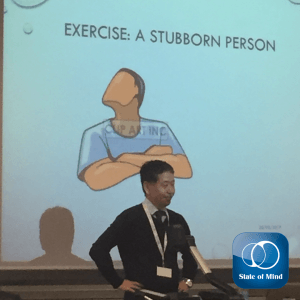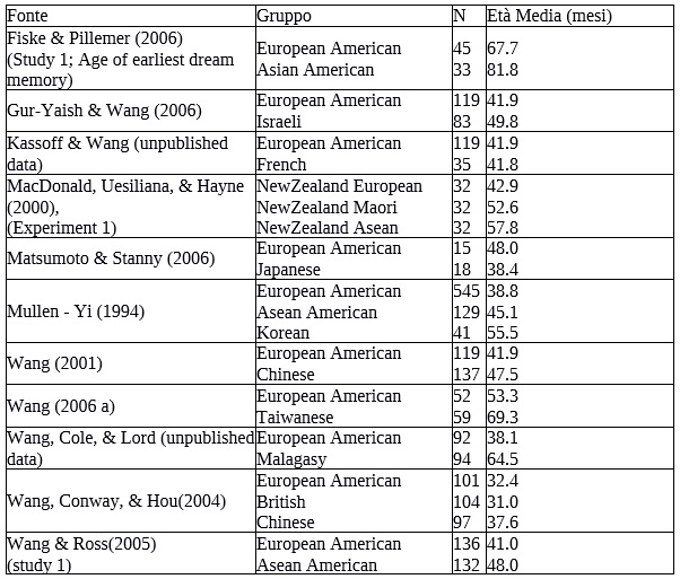Il benessere psicologico di chi si sottopone ad un trapianto di cuore
Sopravvivere ad eventi cardiaci gravi, quale può essere considerato un trapianto di cuore, influenza fortemente il benessere psicologico e le condizioni di salute della persona che ne è vittima (Razzini, C., et al. 2008; Kubzansky, L.D., et al. 2006; Shemesh, E., et al. 2004); generalmente la grave patologia cronica porta con sè vissuti di tipo ansioso-depressivo (Davidson, K.W., et al. 2010), ma anche una sintomatologia tipica del disturbo post traumatico da stress ( Mavros, N., et al. 2011): secondo i dati in letteratura va incontro a un PTSD 11% -16% dei pazienti che hanno subito un trapianto (Dew, M. A., et al. 1996,1999, 2000, 2001).
Laura Grigis, OPEN SCHOOL Studi Cognitivi Milano
Trapianto di cuore: le fasi da percorrere e l’importanza del supporto psicologico
Il trapianto di organi è un intervento chirurgico che consiste nella sostituzione di un organo malato e quindi non più funzionante, con uno sano dello stesso tipo proveniente da un altro individuo che viene chiamato donatore. Si tratta di un intervento invasivo e molto delicato, non solo a livello medico ma anche per gli importanti risvolti psicologici.
Quanto più l’organo è investito di un significato simbolico, tante più fantasie psicologicamente rilevanti esso porta con sé, con ricadute sulla prognosi. Il cuore, fin dall’antichità, è stato così descritto: «il battito che da esso proviene, che ciascuno può percepire, segna l’inizio e la fine della vita, ne ha fatto il centro vitale dell’essere umano, ancora prima che al cuore venisse riconosciuto il ruolo di assicurare la circolazione del sangue» (Politi, P.L. 2002).
In Italia dal 2010 al 2015 sono stati eseguiti 1474 trapianti di cuore. Di tutti i pazienti in lista d’attesa, quelli per trapianto di cuore sono il 7.8% : il tempo medio in lista è di 2.8 anni, con una mortalità in lista del 7.2.
Perché un paziente cardiopatico venga inserito in lista d’attesa serve un’accurata valutazione della gravità della patologia, del rischio di vita e della non funzionalità di un diverso trattamento (farmacologico e/o chirurgico): la cardiomiopatia ischemica e la cardiomiopatia dilatativa costituiscono, attualmente, le più comuni indicazioni al trapianto. Il protocollo di inserimento in lista d’attesa prevede anche una valutazione psichiatrica con l’obiettivo di escludere l’esistenza di patologie psichiatriche che possano in qualche modo pregiudicare la collaborazione del paziente alle complesse e impegnative procedure post operatorie (Barale, F., Magnani, G., Politi, P.L. 1988).
Generalmente, vengono considerate controindicazioni assolute al trapianto: attuale dipendenza/abuso di droghe e alcol, schizofrenia in fase attiva, storia di numerosi tentativi di suicidio, attuale ideazione suicidaria e demenze (Skotzko, C.E., Stowe, J.A., Wright, C., et al. 2001). In queste situazioni emerge la complessità di aspetti psicologici, relazionali e sociali, aspetti tutti che nella condizione di vulnerabilità di malattia si evidenziano essenzialmente come bisogni (Lovera, G., et al. 2000). La sola considerazione dei bisogni fisiologici fondamentali e la salvaguardia della sopravvivenza biologica non sono più sufficienti: è questa, tipicamente, la condizione dei pazienti giunti ad una insufficienza terminale di organi vitali e sottoposti a trapianto d’organo, che vanno ad aumentare la categoria di quelli che la medicina ha definito survivors (Burke, C.M., et al. 1986) cioè dei pazienti che hanno ricevuto un intervento “salvifico” per la sopravvivenza organica e si trovano così a dover affrontare lo stress di insolite condizioni di vita.
Sopravvivere ad eventi cardiaci gravi, quale può essere considerato un trapianto di cuore, influenza fortemente il benessere psicologico e le condizioni di salute della persona che ne è vittima (Razzini, C., et al. 2008; Kubzansky, L.D., et al. 2006; Shemesh, E., et al. 2004); generalmente la grave patologia cronica porta con sè vissuti di tipo ansioso-depressivo (Davidson, K.W., et al. 2010), ma anche una sintomatologia tipica del disturbo post traumatico da stress ( Mavros, N., et al. 2011): secondo i dati in letteratura va incontro a un PTSD 11% -16% dei pazienti che hanno subito un trapianto (Dew, M. A., et al. 1996,1999, 2000, 2001).
Non intervenire adeguatamente su questi aspetti psicologici ed emotivi può compromettere le possibilità di recupero sia psicologico che fisico del paziente (Shemesh, E. et al. 2004; Frasure-Smith, N., Lespérance. F. 2008).
E’ possibile suddividere in più fasi il percorso che porta al trapianto di cuore: la prima fase è quella “pre-trapianto”, cioè il momento in cui viene comunicata la diagnosi al paziente e inizia l’attesa dell’organo; la seconda fase è quella “post-trapianto” a breve termine; la terza fase è relativa all’adattamento nel lungo periodo alle nuove condizioni di vita.
La fase pre – trapianto di cuore
Nel periodo pre-trapianto le difficoltà maggiori sono legate ai disturbi fisici della malattia cardiologica ingravescente, oltre al senso di incertezza e di minaccia per la vita, cambiamenti forzati nel lavoro e nell’ambito familiare e sociale. Questa condizione è complicata dalla permanenza in lista di attesa, con la duplice prospettiva di morte e di vita, e con l’ansia che l’organo non arrivi in tempo: questo viene descritto da molti pazienti come il periodo più stressante mai sperimentato (Christopherson, L.K. 1987). Inoltre l’attesa di un organo ed il desiderio di sopravvivenza causano spesso sentimenti di colpa, vissuti con sofferenza morale (Rupolo, G., Poznanski, C. 1999). Nei pazienti candidati al trapianto cardiaco il 53% presenta disturbi di ansia e il 34% sintomi depressivi (Jones, B.M., et al. 1988): l’ansia si manifesta con insonnia, preoccupazioni ipocondriache, manifestazioni di tipo fobico-ossessivo; la presenza, invece, di depressione, si traduce spesso con difficoltà cognitivo-affettive e generale restrizione dell’attività e/o con l’abbandono dei progetti da parte della persona, nei casi limite si arriva anche a manifestazioni deliranti e sindromi psicotiche (Ciurluini, P., Di Fonzo, C., Rongoni, S., Amicarelli, M. 2010).
In questa fase si sviluppano nel paziente sentimenti di sfiducia e sospetto, disperazione e rassegnazione; la prospettiva del trapianto viene vissuta con grande ambivalenza: se da un lato può suscitare sentimenti di speranza, dall’altro suscita sentimenti di profondo sconforto, se non di terrore, e tali momenti vengono spesso affrontati all’inizio con incredulità e con tentativi di negare la gravità della situazione. La precarietà e la fragilità delle condizioni cliniche impongono un notevole sforzo di adattamento e minano l’autostima e l’autonomia; il vissuto predominante è “la paura di non farcela in tempo” da cui scaturiscono ansia e paura. Non raramente inoltre in questa fase compaiono i primi sentimenti di colpa nei confronti del possibile donatore, cioè la consapevolezza che il reperimento di un organo compatibile richiede la morte di un’altra persona.
In un’ottica di prevenzione, considerato che numerosi studi hanno riconosciuto significative correlazioni tra aspetti psichici e psicosociali ed esiti post-trapianto (ansia, depressione, fattori psicosociali di rischio sono correlati con il numero di rigetti, di infezioni e di ricoveri e con una peggior qualità di vita nel post- trapianto di cuore) (Paris, W., et al. 1994) è necessaria in fase iniziale una valutazione psichiatrica (Chacko, R.C., et al. 1996) e un accurato assessment psicologico, ai quali seguirà uno specifico percorso di sostegno psicologico. Gli obiettivi di una assistenza psicologica nella fase pre-trapianto di cuore si fondano sul comune principio che una buona riabilitazione inizia prima dell’intervento chirurgico, non dopo.
E’ proprio per fronteggiare emozioni così forti in modo funzionale che si pone come necessario un intervento di sostegno psicologico e/o di psicoterapia in fase pre- trapianto: quando, dai colloqui e dall’esame psichiatrico, appaiono evidenti sintomi di ansia o depressione o turbe psicopatologiche, l’assistenza si orienta verso più decisi interventi terapeutici, di ordine sia psicoterapico (a livello individuale e/o familiare) sia psicofarmacologico.
Affiancano questo lavoro di preparazione psicologica gli interventi che hanno lo scopo di aumentare il grado di informazione e di consapevolezza del paziente (e dei familiari) sulla realtà clinica del trapianto di cuore, sulla sua portata e sul programma terapeutico successivo, e di accertarne le motivazioni, sia a livello cognitivo che emotivo.
La fase post-trapianto di cuore a breve termine
Nella fase post – trapianto di cuore a breve termine il paziente si trova ancora ricoverato in terapia intensiva, in condizione di precarietà fisica: la facile incidenza di momenti critici di scompenso psichico in questa fase richiede una pronta disponibilità di interventi di valutazione psichiatrica e di terapia psicofarmacologica, che sono di molto agevolati da una precedente conoscenza con il paziente.
La degenza in unità di terapia intensiva (UTI) con i postumi dello shock biologico e dello stress dell’intervento, il dolore, le condizioni di regressione e fragilità psichica, la perdita dei ritmi fisiologici, l’isolamento e la deprivazione sensoriale, rappresenta un periodo di forte sofferenza.
Dal 2°-3° giorno post-operatorio con notevole frequenza i pazienti soffrono di fenomeni psicopatologici, che possono esprimersi in quadri di ansia, irrequietezza, disorientamento, o più conclamati di delirium: stato confusionale, agitazione psicomotoria, allucinazioni, confabulazioni deliranti, affettività alterata. La frequenza di queste psicosi confusionali è indicata in percentuali molto variabili, che mediamente si collocano intorno al 20-40% (Mai, F.M. 1993; Speidel, H., Dahme, B., Flemming, B., et al. 1983; Craven, J.L., et al. 1990): vi contribuiscono non solo cause biologiche (metaboliche, chirurgiche, farmacologiche) ma anche aspetti psichici di fragilità personologica dei pazienti.
Generalmente, se non si presentano complicazioni post-operatorie, dopo circa una settimana il paziente trapiantato esce dall’UTI per essere seguito nel reparto di cardiologia; in questa fase l’assistenza psicologica assume una più incisiva azione psicoterapeutica:
– favorire la ripresa dell’autonomia e delle funzioni vitali (per esempio del sonno notturno)
– concedere spazio all’espressione delle emozioni e dei vissuti post-trapianto
– sostenere il paziente a livello emotivo e cognitivo durante le possibili complicazioni
– favorire comportamenti di accettazione e di compliance e più in generale stili di coping di tipo adattivo da parte del paziente, operando anche con interventi di mediazione tra medici e paziente (o familiari) per sostenere la comprensione reciproca e individuando strategie relazionali da concordare con i curanti (Lovera, G., et al. 2000).
In ogni caso, anche nelle degenze di più felice e rapido decorso, si considera importante un colloquio psicologico prima della dimissione con il paziente per valutarne l’equilibrio psichico e le capacità di riadattamento all’ambiente esterno e con i familiari perché siano sufficientemente preparati ad accoglierlo.
Nella fase immediatamente successiva all’intervento in alcuni pazienti si ha quella che alcuni autori definiscono “luna di miele” (Barale, F., Magnani, G., Politi, P.L. 1988), una sensazione transitoria di rinascita che può assumere le caratteristiche di uno stato di ipomaniacalità reattiva alla condizione di grave angoscia provata prima dell’intervento (Livi, U., Thiene, G., Casarotto, D. 1988); sentimenti di liberazione, di emotività intensa, talora di vera euforia, per essere sopravvissuti, fanno percepire l’evento del trapianto come una rinascita.
La fase della “luna di miele” non è però libera da cognizioni negative e sintomi disfunzionali al benessere psicologico del paziente: la paura del rigetto, delle complicazioni, del futuro, creano una condizione di incertezza esistenziale. Inoltre in questa fase sono particolarmente attivi pensieri e fantasie sulla persona del donatore, con sentimenti compositi di gratitudine e di colpa. Sono inoltre diffusamente presenti, nelle prime settimane del post-intervento, sintomi organici cerebrali, con deterioramento cognitivo (attenzione, concentrazione, memoria) che possono permanere, sfumati, anche a lungo (Mai, F.M. 1993; Craven, J.L., et al. 1990).
A distanza di un anno dal trapianto i dati rivelano un aumento significativo delle funzioni fisiche: l’83% dei sopravvissuti non ha alcuna limitazione funzionale, mentre il 10% dei pazienti afferma di aver bisogno di assistenza nelle attività quotidiane (Catania, C.G., et al. 2013).
La diagnosi di disturbi ansiosi e depressivi è più frequente durante il primo anno dopo il trapianto rispetto agli anni successivi, ed è più frequente rispetto al resto della popolazione e rispetto a un campione di soggetti affetti da altre patologie croniche; inoltre ansia e depressione (associate a fattori psicosociali di rischio) sono correlati con il numero di rigetti, di infezioni e di ricoveri e con una peggior qualità di vita nel post-trapianto (Paris, W., et al. 1994); il disturbo post-traumatico da stress correlato al trapianto, sebbene meno comune, è stato osservato nel 15% dei pazienti (Coffman, K.L., Crone, C. 2002); disturbi psichici e psicosociali risultano essere predittivi di scompensi psichici, di non compliance e di cattivo adattamento nel post-trapianto (Phip, L. 1997); la valutazione psichiatrica e la misura delle modalità di coping e del sostegno sociale sono fattori predittivi della mortalità nel post-trapianto (Chacko, R.C., et al. 1996) perciò diventa importante una assistenza psicologica in questa fase, non solo per l’aiuto attuale ai pazienti, ma anche per riconoscere fattori di rischio su cui operare preventivamente.
La fase post dimissioni dopo il trapianto di cuore
Nella fase che segue la dimissione, inizia la vera e propria riabilitazione del paziente alla vita familiare, sociale e lavorativa. L’assistenza psicologica può essere di diverse tipologie: interventi nelle situazioni di crisi, su richiesta dei medici curanti, o del paziente e dei familiari; terapia di gruppo (Hyler, B.I., Corley, M.C., MC Mahon, D. 1985)
La crescente consapevolezza della durata e complessità dei processi di adattamento che seguono al trapianto di cuore e delle difficoltà di reinserimento familiare e sociale, insieme con la necessità di capire meglio le conseguenze a lunga distanza del trapianto sulla qualità della vita dei pazienti, consigliano di preferire valutazioni dello stato di salute psicologica programmati, in genere a distanza di 3-6 mesi e poi di un anno (Lovera, G., et al. 2000), a cui far seguire se necessario interventi di sostegno e/o psicoterapia; la valutazione riguarderà la compliance alle cure, il funzionamento dal punto di vista emotivo, familiare, sociale e la percezione della qualità della vita.
Un importante studio tedesco del 1999 (Schlitt, H.J., et al. 1999) ha dimostrato che, diversamente dalle aspettative comuni, il trapianto d’organo sembra essere ben accettato psicologicamente dai pazienti: il 99% di loro consideravano infatti il nuovo organo come parte integrante del loro corpo, anche se con un’eterogeneità di atteggiamenti che oscillavano dalla totale alla parziale ma possibile integrazione. La completa integrazione del trapianto era associata ad un miglior stato di salute e un buon equilibrio mentale: difficile capire se l’atteggiamento mentale positivo abbia favorito le condizioni mediche, oppure se al contrario la gravità non eccessiva della patologia e dei sintomi organici abbia permesso l’utilizzo di strategie di “coping” efficaci nell’affrontare il trapianto; da questo studio (Schlitt, H.J., et al. 1999) emerge però una differenza significativa di migliore integrazione dell’organo tra le pazienti donne; inoltre, si è visto che la maggior parte dei pazienti si poneva domande riguardo l’organo estraneo soprattutto nella fase immediatamente postoperatoria, mentre pochissimi facevano riflessioni sul trapianto a lungo termine.
Con la dimissione i pazienti affrontano il ritorno al loro contesto familiare e sociale ed un periodo di adattamento alla vita di “trapiantato”, che generalmente si svolge nell’arco di sei mesi-un anno. Nonostante il miglioramento delle condizioni fisiche, rimane in letteratura la fondata evidenza di un malessere psicopatologico e psicosociale (Grady, K.L., Jalowiec, A., White-Williams, C. 1996). Con la dimissione i pazienti si sentono privati della protezione dell’ospedale e sperimentano sentimenti di abbandono e di insicurezza, mentre sono esposti all’ansia di un riadattamento al mondo esterno. Inoltre i pazienti trapiantati, dopo la dimissione e nell’incontro con la realtà successiva, sperimentano delusioni nelle aspettative di “guarigione”, che trasformano l’euforia del periodo post-operatorio in crisi emotive di ansia e di depressione, con la progressiva consapevolezza della propria incertezza esistenziale e della permanenza nella condizione “di malato”.
L’esperienza del trapianto costituisce una crisi psicosomatica (Chiesa, S. 1989) che impegna le risorse bio-psico-sociali dei pazienti, e dei familiari, nel processo di adattamento all’organo trapiantato. Ciononostante medici e familiari sollecitano, ed i pazienti fantasticano, il ritorno alla normalità. Per i medici l’obiettivo finale è l’immagine di un paziente in discreto equilibrio fisico-psichico e con buona compliance a terapie e controlli; per i familiari è spesso il desiderio di un ritorno alla vita “di prima”, cioè senza la presenza della malattia.
I pazienti invece incontrano numerosi fattori di ostacolo ad una normalizzazione dell’esistenza Lovera, G., et al. (2000) ad esempio:
– i postumi dello stress chirurgico (6 mesi-1 anno) che possono lasciare disturbi cognitivi e della cenestesi, insonnia e turbe emotive quali ansia e depressione, fino allo strutturarsi in un vero e proprio Disturbo post-traumatico;
– gli effetti collaterali delle terapie antirigetto (ciclosporine e cortisone);
– modificazioni dell’immagine corporea;
– ansia per i controlli periodici;
– paura, rabbia, angoscia e depressione legate alle possibili complicanze e agli episodi di rigetto;
– modificazioni nella quotidianità legate alle attenzioni specifiche che la persona trapiantata deve prestare a se stessa e al suo ambiente (nutrizione, infezioni, protocolli terapeutici).
A risentire della nuova condizione di vita, per quanto spesso migliore della precedente, sono anche la relazione di coppia (Bunzel, B., Laederach-Hofmann, K., Schubert, M.T. 1999) e la definizione dei ruoli all’interno della famiglia; la letteratura segnala un ritorno al lavoro a tempo pieno in percentuali medie intorno al 45% (Mai, F.M. 1993; Craven, J.L., et al. 1990; Notova, P., et al. 1997) che sono ben inferiori ai valori medi di recupero delle funzioni fisiche.
Un importante studio condotto, Padova (con la collaborazione di Dipartimento Trapianti e Clinica Psichiatrica Universitaria) tra il 1997 e il 1999 ha studiato la qualità della vita di 467 pazienti trapiantati (Lovera, G., et al. 2000). Con la definizione di qualità della vita (quality of life: QoL) si intende, secondo le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità “la percezione soggettiva che un individuo ha della propria posizione nella vita, nel contesto di una cultura e di un insieme di valori nei quali egli vive, anche in relazione ai propri obiettivi, aspettative, preoccupazioni”.
Questo studio conferma che il trapianto migliora la qualità della vita dei pazienti, ma con le seguenti precisazioni: nell’immediato post-trapianto il giudizio espresso è entusiastico non solo per il benessere riacquistato, ma soprattutto per il superamento del rischio di morte che, nell’esperienza del paziente, si traduce in un vissuto di “rinascita” e “liberazione”. La consapevolezza realistica del trapianto si verifica una volta trascorso il primo anno, all’emergere di complicanze e di difficoltà di adattamento alla vita quotidiana. Se il primo anno corrisponde dunque alla fase più critica da un punto di vista organico, il periodo successivo è il tempo della elaborazione psicologica e della crisi psico-somatica.
Nel post- trapianto di cuore, l’insorgenza di disturbi ansioso-depressivi potrebbe giocare un ruolo importante. È stata infatti dimostrata una correlazione tra sintomatologia depressiva e bassa percezione della QoL (Buendia, F., Almenar, L., Martinez- Dolz, L., et al. 2011). Il tasso di prevalenza dei disturbi depressivi nelle malattie cardiovascolari va da un 15% a un 25%. In più, il 30-45% dei pazienti affetti da patologie cardiovascolari soffre di sintomatologia depressiva che però non rientra nei criteri diagnostici del disturbo depressivo maggiore. Tali sintomi possono essere difficili da diagnosticare e si presentano con caratteristiche atipiche, come irritabilità, presenza di disturbi cognitivi, sentimenti di frustrazione, mal di testa, disturbi gastrointestinali, astenia, disturbi del sonno, riduzione dell’appetito e vaghi sintomi somatici (Catania, C.G., et al. 2013).
La depressione è un fattore di rischio per la morbilità e la mortalità in pazienti con malattie cardiovascolari. Poichè un umore depresso predice la QoL, e QoL e benessere psicologico sono correlati alla morbidità e mortalità dopo un trapianto, un trattamento effettivo della depressione potrebbe potenzialmente migliorare la QoL e prolungare la sopravvivenza dei pazienti sottoposti al trapianto di cuore.
L’intervento psicologico sui pazienti che sono stati sottoposti al trapianto si sviluppa quindi su due direzioni, seguendo un po’ quella che è la divisione delle fasi “di vita” pre e post intervento: in ottica preventiva, è importante l’assessment psicologico e l’intervento psicoterapeutico precedente all’intervento; in ottica di miglioramento della qualità della vita e di prevenzione di complicazioni post-trapianto sono importanti interventi di sostegno psicologico (anche alla famiglia) e di psicoterapia, volti alla risoluzione di sintomi e disturbi ansiosi, depressivi e alla gestione della reazione allo stress traumatico.
La sintomatologia ansiosa, depressiva e post-traumatica possono essere efficacemente gestite attraverso l’utilizzo della Psicoterapia Cognitivo Comportamentale; in particolare la metodologia EMDR si è rivelata di successo sui pazienti sopravvissuti ad eventi cardiaci gravi (Arabia, E., Manca, M. L., Solomon, R. M. 2011) come il trapianto; inoltre i pazienti possono essere guidati in un processo di consapevolezza degli stati interni attraverso il biofeedback e l’analisi delle variabili fisiologiche fino all’acquisizione della capacità di autoregolazione delle stesse.