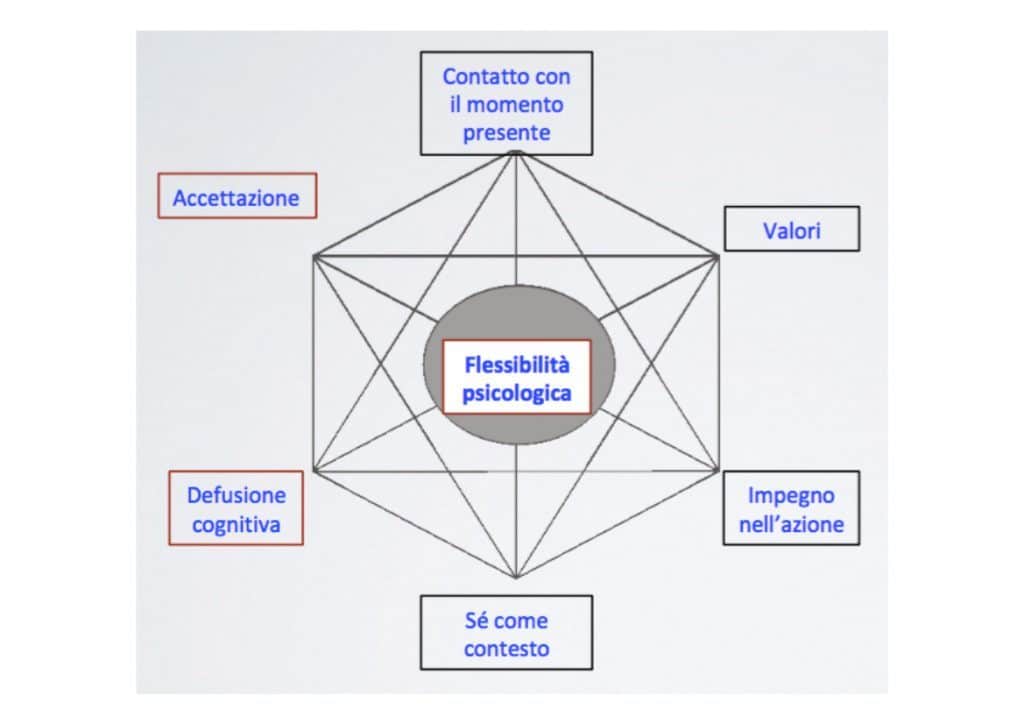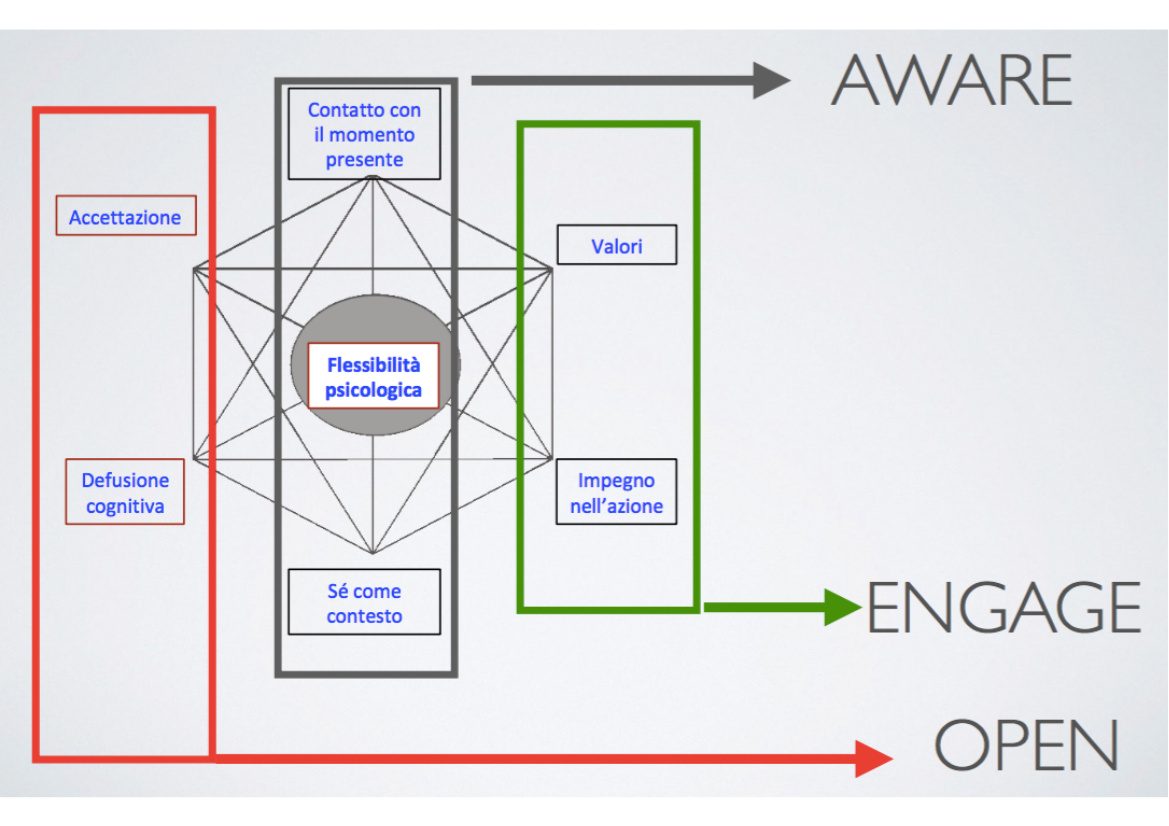La scienza e la vita ordinaria. Dall’emergenza covid all’etica dell’intervento psicologico
La scienza è risultata uno fra i tanti fattori nel gioco di una realtà multidimensionale, accanto a quello politico, sociale, economico.
E’ ormai chiaro a tutti: la scienza ha mostrato i suoi confini e la sua natura post-positivista. Eravamo nel ‘post’ già da tanto tempo, ora è apparso evidente ai più. Non si tratta di sterili e inessenziali – alla vita ordinaria – questioni epistemologiche sul concetto di scienza e sui suoi procedimenti, sul rigore logico dei suoi metodi, ma di ricollocare il suo tassello nella casella appropriata, ricordare che essa non è solo materia da laboratorio sperimentale ma fattore fondamentale a governo della nostra vita concreta.
L’esperienza drammatica del covid-19 lo ha imposto brutalmente, ce lo ha messo davanti agli occhi come una allucinazione che non può essere negata, più reale di qualsiasi realtà avremmo potuto ‘allucinare’. Ma nessuno scandalo. Quando si afferma o si sente dire: “Lo dice la scienza”, “Lo dimostra la scienza”, innanzitutto, non si può dimenticare che essa non è un monolite, e, in secondo luogo, che il concetto stesso di scienza è andato evolvendosi continuamente nel corso della storia. Dalla concezione dimostrativa, di tradizione aristotelica a quella descrittiva di Bacone e Newton dell’osservazione empiristica dei fatti, a quella popperiana di autocoreggibilità e via proseguendo. Attraverso un itinerario lungo e tortuoso, oggi la scienza vera sa che non può arrogarsi una pretesa di garanzia assoluta e, quando lo fa, può raggiungere vette grottesche e schernevoli; sa che i passi che fa sono sempre provvisori e smentibili.
Quello che ci ha insegnato la pandemia è che la scienza è una continua ricerca, produzione di fonti, ipotesi da vagliare. E ha mostrato quanto sia faticoso questo percorso. La creatività e l’operosità scientifica rappresentano il volano della ricerca e della tensione a scoprire nuove vie e vincenti soluzioni. Questo suo essere stata catapultata dall’empireo della certezza assoluta alla quotidianità sempre mutevole del dibattito pubblico ha prodotto una certa confusione, non solo di ruoli, ma anche dei limiti del sapere scientifico stesso, della sua apparente inadeguatezza a risposte univoche e immediate, spesso tra interessi in collisione e litigiosi.
La scienza è risultata uno fra i tanti fattori nel gioco di una realtà multidimensionale, accanto a quello politico, sociale, economico. Ovvero, di dimensioni umane. Il centro del dibattito deve ritornare prepotentemente a porre l’accento sull’uomo, cui tutte queste discipline sono funzionali. E’ quello che con termine ‘tecnico’ si usa chiamare etica, il riconoscimento del valore della persona nelle sue caratteristiche intrinseche ed essenziali. Il concetto di ‘etica’ si riferisce al comportamento umano nelle fattispecie concrete degli eventi che accadono e che ‘impongono’ la scelta di una azione deontologica. In questo senso il concetto di scienza si incontra con quello di etica, nella misura in cui il sapere – costruito per tentativi ed errori – può essere messo al servizio del bene comune. La figura dello psicologo, nella sua natura più essenziale, rappresenta colui che si rende umanamente disponibile a mettere al servizio della salute delle persone il proprio sapere, fatto di teorie e strategie tese al sostegno psicologico delle medesime. Diventa sempre più evidente, soprattutto in questa fase successiva alla crisi pandemica, che l’aiuto dello psicologo può risultare fondamentale: ‘può’ non nel senso di una validità probabile del supporto prestato, quanto al riconoscimento della sua efficacia ed accettazione della sua necessità (in situazioni emergenziali come quella che stiamo vivendo) da parte delle persone cui si propone l’aiuto. Questo passaggio dell’accettazione si fonda sulla considerazione mai data per scontata che il lavoro psicologico è un lavoro (percorso) eminentemente personale: la sua validità è oggettiva in sé, ma ha bisogno della consapevolezza della persona circa la sua pertinenza ed utilità alle sue problematiche. E’ il principio della libertà, cui sempre deve essere ricondotta la scelta di iniziare un percorso terapeutico. Iniziarlo è il risultato di una decisione, innanzitutto intima, strettamente connessa alla motivazione personale, fondamentale per il cambiamento. Si tratta del principio cardine di qualsiasi lavoro basato sulla libertà dell’individuo. Troppo spesso il terapeuta si ritrova investito di una responsabilità che appartiene al paziente: sulla durata della terapia, sui suoi costi, sulla sua efficacia, sulla guarigione pretesa. Non si deve invece dimenticare che un percorso psicologico si riferisce ad una conoscenza che non è quella delle scienze matematiche o mediche: prendo un farmaco perché ho mal di testa e il farmaco, senza il mio coinvolgimento, mi fa cessare il dolore (e in verità non sempre); non si riferisce alla misurazione di una funzione tra due variabili.
E’ una conoscenza di un dinamismo dinamico che è la persona, che si riferisce non tanto e non solo ad un aspetto specifico e particolare del mio corpo (anche se spesso l’entry point per un percorso psicologico è il sintomo) ma all’intera mia persona, che soffre e si ammala non solo fisicamente, ma anche nella espressione di una emotività e affettività che provocano uno squilibrio dell’intero organismo.
Una situazione drammatica come quella della pandemia ha mostrato in tutta la sua evidenza quanto ciò che emerge nel mondo reale ci determina, ci ‘costringe’ a certi comportamenti, ci muove inconsciamente in certe direzioni anche nella nostra vita onirica, mostrandoci una angoscia pervasiva, nonostante i nostri sforzi di sedarla. Molte ricerche e studi in questo periodo (quella del King’s College di Londra – sulla correlazione tra eventi stressanti e disturbi del sonno, o quella dell’Università di Harvard – sulla frequenza di incubi e sogni fobici durante la pandemia) hanno messo in evidenza le conseguenze inconsapevoli della percezione di non libertà e di costrizione relative alla nuova situazione di isolamento vissuto durante la fase del lockdown, le cui conseguenze non svaniscono con la semplice riapertura dei confini dei nostri spazi. Anzi, forse proprio tale apertura può far emergere i limiti che noi stessi percepiamo ancora dentro di noi: i confini oggettivi sono eliminati, ma quelli soggettivi rimangono in piedi, forse rafforzati dalle nostre dinamiche antiche.
Allora qual è il lavoro ‘etico’ che necessita in questa situazione? Come porvi rimedio? Certamente non eludendo il problema, non avendo timore di chiedere aiuto, partendo dalla consapevolezza che quello che abbiamo vissuto è un momento unico, non ci saremmo mai immaginati di viverlo, ma soprattutto è un evento comune, siamo tutti coinvolti. Questo rende meno ‘autoreferenziale’ il malessere soggettivo, meno ‘paranoico’ il riferimento delle circostanze come inevitabilità per la mia persona.
Soprattutto ora che vi è l’inizio di un ritorno alla normalità, anche lavorativa, è importante non sottovalutare lo stress legato alle dimensioni connesse alla ripresa delle attività. La psicologia è in grado di dare una risposta adeguata alle nuove angosce legate al vissuto esperito in queste nuove situazioni. Quando si parla della professione dello psicologo/psicoterapeuta ci si riferisce inevitabilmente a due dimensioni: a quella umana, la sensibilità e disponibilità del professionista come persona, e a quella tecnica, ossia l’insieme di strumenti e tecniche messe in campo dal professionista per porre e proporre il suo aiuto a favore dell’intera dimensione del benessere della persona. Non si dimentichi che il concetto stesso di salute è definito dall’OMS come quello stato di benessere psico-fisico e sociale, non esaurendosi semplicisticamente nella assenza di malattia o infermità di sorta. C’è inoltre un aspetto legato alla sensazione di perdere il controllo, da molti vissuto drammaticamente, come sta emergendo spesso dalla pratica clinica. Le certezze messe in discussione durante la pandemia, anche quelle scientifiche circa la natura del virus, possono aver precipitato l’individuo in un deserto di sabbie mobili dove le verità controllate e date per assodate sono state percepite improvvisamente come destabilizzanti il consueto equilibrio.
Ecco perché è importante affrontare un lavoro di consapevolezza, perché anche nelle situazioni meno controllabili si possa imparare quella resilienza tanto citata: il poter riemergere attraverso e grazie alle risorse personali, il cui primo passo è una conoscenza delle proprie dinamiche, dei significati dei propri vissuti e delle angosce correlate.
Tutto questo non può essere un lavoro che la persona fa da sola, almeno non sempre. E’ fondamentale la consapevolezza circa il fatto che, come professionista, lo psicologo può dare supporto attuando strategie pensate appositamente per la singola persona (perché il virus è uno ma il modo di vivere le paure ad esso connesse sono del tutto soggettive) e ricorrendo ad una profilassi adeguata alle situazioni concrete. Le strategie e le tecniche proposte dal professionista sono realmente in grado di contenere l’ansia, di lavorare sui sintomi cercando di svelarne i contenuti di significato che spesso possono affiorare e svelare alla persona stessa i suoi pattern ripetitivi di comportamento disfunzionale. Si possono sfruttare, infine, gli aspetti positivi che sono stati messi in evidenza durante il lockdown, come la possibilità di una diffusione di strumenti di aiuto a distanza, che consentono a tutti di scegliere un professionista anche non fisicamente vicino, creandosi una opportunità (restando nel proprio spazio, conosciuto e confortevole) che forse in tempi normali non avrebbe pensato di sfruttare. Ci possono essere (come dimostra la pratica clinica) dei vantaggi anche nella terapia online, con un setting terapeutico del tutto personalizzato e portato al paziente, che può fare emergere dinamiche diversamente nascoste.