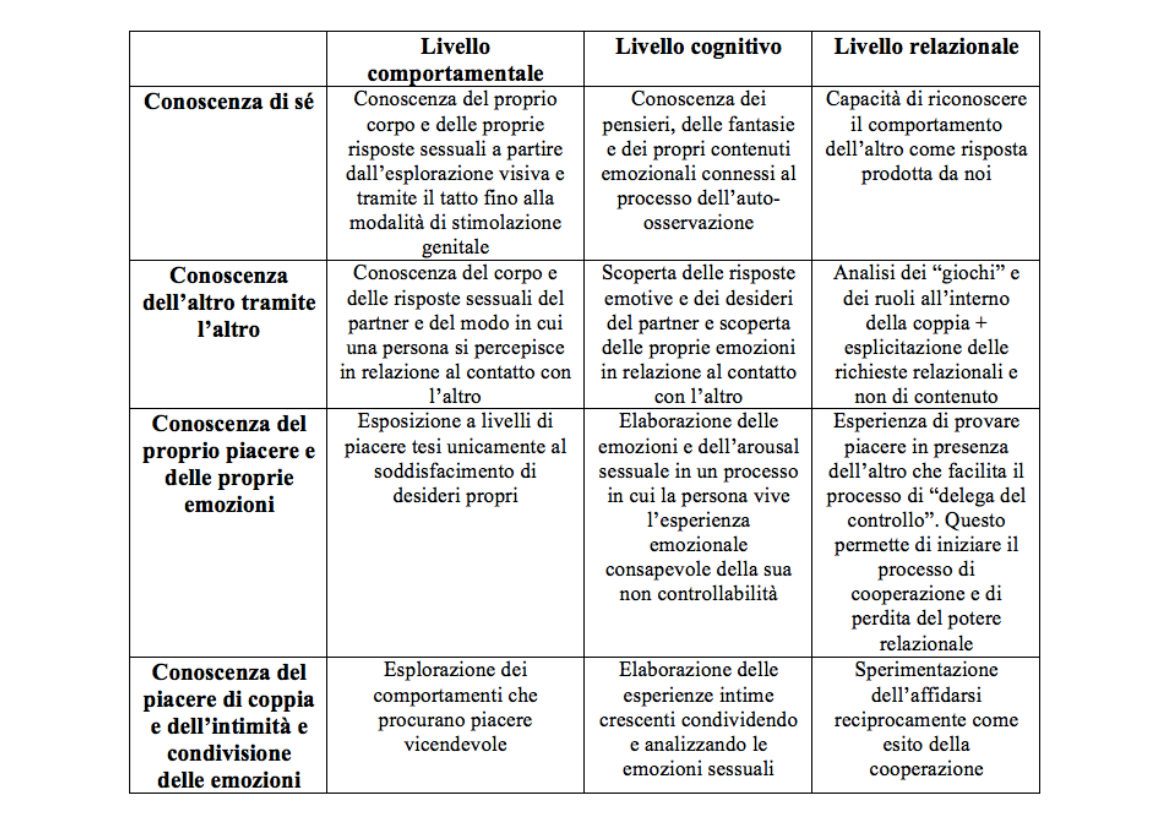Psicoterapia in Pandemia: come cambia la dimensione relazionale?
Introdotta per la prima volta nel 1127, la quarantena è la principale misura di contrasto adottata durante tutte le pandemie di malattie infettive e contagiose. Già in passato, la letteratura ha posto l’accento sui disagi psicologici correlati alle pandemie come l’aumento dei livelli di ansia, di panico e di distress nella popolazione o la modificazione della percezione del rischio e delle modalità di trasmissione.
Introduzione
Il Corona Virus Diseases 19 (
COVID-19) è una malattia respiratoria causata dal virus SARS CoV-2. Emersa in Cina nel dicembre 2019, si è diffusa rapidamente in tutti i continenti, inducendo l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) a dichiarare, inizialmente, lo stato di emergenza di sanità pubblica internazionale e, a marzo 2020, lo stato di pandemia. Quest’ultima è caratterizzata dalla presenza di un nuovo virus con un’accertata trasmissione interumana, da una suscettibilità universale, ovvero assenza di anticorpi negli organismi, da un impatto sanitario grave e da una diffusione a livello mondiale con rischio significativo di restrizioni al commercio e al traffico internazionale. La modalità di trasmissione è per via respiratoria o per contatto relativamente ravvicinato. Al momento, sono assenti vaccini e protocolli terapeutici consolidati.
Le malattie contagiose sono parte integrante della storia dell’umanità, da quando gli uomini hanno iniziato ad organizzarsi in società, creando nuclei di persone che si relazionano e convivono nello stesso spazio (Panè, 2020). Dalla Peste Nera del 1300 ad oggi, sono state registrate numerose pandemie, quelle più rilevanti dell’ultimo secolo sono l’influenza Spagnola nel 1918, l’influenza asiatica H2N2 nel 1957 e l’influenza suina A/H1N1 nel 2010.
Introdotta per la prima volta nel 1127, durante l’epidemia di peste a Venezia, la quarantena è la principale misura di contrasto adottata durante tutte le pandemie di malattie infettive e contagiose (Brooks, 2020). Nonostante il progredire medico scientifico, il distanziamento sociale, caratterizzato dal confinamento e dalla limitazione dei rapporti sociali, è ancora oggi la principale risposta in presenza di nuove epidemie (es. SARS nel 2003, Ebola nel 2014).
Già in passato, la letteratura ha posto l’accento sui disagi psicologici correlati alle pandemie come l’aumento dei livelli di ansia, di panico e di distress nella popolazione (Wong, 2010) o la modificazione della percezione del rischio e delle modalità di trasmissione. Inoltre, ulteriori effetti psicologici negativi, registrati nelle misure restrittive delle passate quarantene, sono stati: aumento dei suicidi (Barbisch, 2015), aumento di manifestazioni di rabbia o di cause legali, presenza nella popolazione di sintomi depressivi e sintomi da disturbo da stress post-traumatico acuto (Brooks, 2020), comportamenti da evitamento (verso persone con sintomi o luoghi pubblici) e/o comportamenti iperprotettivi. Tali cambiamenti si sono mantenuti per molto tempo anche a pandemia terminata (Lau, 2010), più lungo è stato il periodo di quarantena, maggiori sono stati gli effetti psicologici negativi (Brooks, 2020).
L’attuale situazione pandemica, caratterizzata da un costante percepito pericolo di vita, l’incertezza di poter essere curato in ospedale, la paura dell’altro potenzialmente infetto, la riduzione della libertà di movimento, la privazione del processo di lutto, la separazione fisica dai propri cari, lo svuotamento dei magazzini e la difficoltà di reperire dispositivi medici di sicurezza, l’improvvisa crisi economica, l’incertezza con cui le istituzioni e le nazioni si muovono, può produrre effetti drammatici sulla salute e si configura come una situazione peri-traumatica che può avere un forte impatto sul sistema nervoso centrale.
Impatto del distanziamento sociale sul sistema neurobiologico
Porges definisce la neurocezione come
il modo in cui i circuiti neurali distinguono fra una situazione o una persona sicura ed una pericolosa o che rappresenta una minaccia per la vita. (Porges, 2004)
La percezione del pericolo tende ad attivare reazioni di difesa più antiche, come la mobilizzazione o l’immobilizzazione, riconducibili al cervello “rettiliano”, o più evolute, come la tendenza all’ingaggio sociale, collegate al cervello “limbico”, fino allo sviluppo di una socialità e moralità condivisa (Churchland, 2012 ).
Durante una pandemia ci si ritrova in una condizione di minaccia per la vita che è condivisa dalla comunità, ma è vissuta dagli individui o dai nuclei familiari in sostanziale isolamento sociale, come una condizione che porta a una inevitabile limitazione della co-regolazione. In un contesto di distanziamento sociale, l’attivazione del reaching out (strategia di ricerca dell’altro relativa alla difesa “mammifera” del pianto di attaccamento), ci spinge a mantenere almeno le connessioni virtuali con i nostri simili, l’utilizzo di una video chiamata ci permette infatti di percepire la voce e l’espressione facciale dell’interlocutore.
Tuttavia tale attivazione può non rivelarsi sufficiente alla co-regolazione e può far inoltre saltare il “patto sociale”, ovvero le norme, le regole e le aspettative alla base del nostro quotidiano vivere e del nostro senso di sicurezza.
Ciò potrebbe avere un impatto sul sistema nervoso in allarme che, non avendo la possibilità concreta di attivare il coinvolgimento sociale, tenderebbe a presentare un’iperattivazione dei sistemi di difesa animale più antichi.
Nei nostri pazienti, ma anche in tutti noi, infatti, possiamo notare tendenze comportamentali alla fuga (es. uscite fuori dalle regole) o all’attacco (rabbia intensa verso le istituzioni o verso i conspecifici che si avvicinano) o anche fenomeni di immobilizzazione riconducibili a difese animali come il congelamento (paralisi, insonnia, attacchi di panico) o il collasso (ipersonnia, ipoattivazione, stanchezza, mancanza di motivazione all’azione). Naturalmente ogni persona reagirà in base alla propria storia di vita e al proprio modello operativo interno (Bowlby,1973).
Il tentativo, come psicoterapeuti, è quello di regolare i sistemi nervosi dei nostri pazienti, in modo da trasformare la situazione peritraumatica in un’occasione di espansione sia della consapevolezza sia della capacità di gestire i propri stati interni e il senso di impotenza esperito.
L’intervento psicologico in ambito emergenziale possiede, infatti, caratteristiche peculiari che lo differenziano da quello ordinario, per cui l’applicazione delle competenze psicologiche e psicoterapeutiche, proprie del setting clinico, necessita di essere adattata ed integrata con le conoscenze delle prassi emergenziali e delle prestazioni online (CNOP, 2020).
In presenza di una pandemia, con l’emergente bisogno psicologico da un lato e le limitazioni nel poter esercitare la professione con le modalità tradizionali dall’altro, quali sono gli aspetti che contraddistinguono l’intervento psicologico e la relazione terapeutica?
Psicoterapia online ai tempi del Covid-19
Setting e self-disclosure
Il diffondersi del Covid-19 ha inevitabilmente indotto un cambiamento del setting terapeutico, l’introduzione di software per videochiamate, attraverso cui svolgere colloqui clinici, ha infatti trasformato la seduta in presenza in un’esperienza di e-therapy. Questo fenomeno, per alcuni psicoterapeuti, non è stato del tutto nuovo, alla luce di una già precedente diffusione di mezzi informatici, sincroni (videochiamate) e non sincroni (messaggi e e-mail).
Tale rapido cambiamento operativo è stato motivato dalla situazione di potenziale pericolo, dalla necessità di tutela e protezione reciproca ed è stato volto, in prevalenza, alla prosecuzione dei lavori terapeutici già impostati precedentemente (CNOP, 2013), con particolari cautele rispetto ai soggetti con difficoltà nell’esame di realtà, ideazioni suicidarie o gravi stati dissociativi.
Questa importante rivoluzione nel setting terapeutico, porta a numerose riflessioni cliniche.
In primo luogo, la pandemia pone, forse per la prima volta nella storia della psicoterapia, paziente e terapeuta nella medesima situazione peritraumatica, condizione questa che genera un senso di impotenza e vulnerabilità condivisi e favorisce allo stesso tempo empatia e compassione. Attraverso la psicoterapia online, emerge l’opportunità di condividere, nel qui ed ora, la propria esperienza umana. Le nostre case si aprono reciprocamente, facendoci accedere, attraverso lo schermo, ai luoghi quotidiani dell’altro. Gli spazi d’intimità visibili favoriscono, paradossalmente, maggior vicinanza rispetto alla presenza fisica nel setting abituale. In tale contesto clinico, risultano ancora più importanti la consapevolezza e l’attenzione del terapeuta alla propria self-disclosure e la responsabilità verso il proprio benessere. Il terapeuta tende ad assumere atteggiamenti di cura del sé, di resilienza, di compassione e gentilezza verso le proprie fragilità, orientato alla co-regolazione emotiva con il paziente, alla normalizzazione dei vissuti, all’acquisizione di consapevolezza dei processi cognitivi e relazionali e alla ricerca di risorse.
La psicoterapia online richiede inoltre al terapeuta una maggiore attenzione alla comunicazione non verbale, che avviene prevalentemente attraverso il proprio volto e quello del paziente, da monitorare costantemente, in un processo parallelo, con continui aggiustamenti (luce, distanza dallo schermo, direzione degli sguardi, ecc.).
Una reciproca comunicazione efficace e l’orientamento dell’attenzione del paziente ai propri segnali corporei promuovono il rinforzo del Sé adulto e l’integrazione mente-corpo.
La perdita di parte della prossemica rimane un’esperienza incarnata di impoverimento nel processo relazionale; tuttavia la possibilità di osservare il proprio volto in interazione con l’altro attiva i neuroni specchio e facilita una riflessione sui propri stati emotivi e mentali, aprendo interessanti punti di contatto con la Self Mirroring Therapy (Vergatillo, 2020).
Un ulteriore elemento da tenere in considerazione nel contesto online è l’eventuale instabilità della connessione Internet: il verificarsi di rotture e riparazioni della sintonizzazione comunicativa, che avviene attraverso la rete, può essere considerata come “l’oggettivazione” di ciò che accade quotidianamente all’interno della comunicazione umana e nella relazione di attaccamento. L’autentico impegno reciproco e l’esperienza di ripetute riparazioni alla perdita di sincronizzazione comunicativa favoriscono la capacità di regolazione emotiva e regalano un interessante parallelismo con un’esperienza di attaccamento sicuro: madri che alla rottura fanno seguire una riparazione efficace, hanno bambini più capaci di regolarsi (Tronick, 2008).
Possiamo inoltre considerare l’“effetto di disinibizione online” (Suler, 2004), che evidenzia la tendenza degli individui ad esprimersi e agire con maggior impulsività ed intensità emotiva sul web, piuttosto che di persona. Lo schermo tra l’individuo e il mondo online crea una barriera che può essere vissuta come una protezione.
In tal caso, la psicoterapia via web potrebbe anche facilitare l’espressione emotiva del paziente, promuovendo l’accesso ad emozioni più intense nella relazione terapeutica. Si rileva infatti una maggiore disponibilità e apertura dei pazienti all’identificazione e condivisione, nel dialogo terapeutico, dei propri nuclei di sofferenza più profondi.
Ipotizziamo quindi, considerando la clinica dell’attaccamento disorganizzato, che l’attivazione del sistema di attaccamento possa essere vissuta come meno “pericolosa”, data la distanza fisica e il potenziale maggior controllo da parte del paziente nella relazione con il terapeuta (es. la persona potrebbe facilmente scegliere di interrompere la comunicazione), e quindi favorire la regolazione della fobia dell’attaccamento. Allo stesso tempo, la possibilità di mantenere la relazione attraverso il web, nonostante la situazione comune di pandemia, potrebbe invece favorire la regolazione della fobia della perdita dell’attaccamento. La relazione terapeutica diventa infatti lo spazio di cura che si può conservare, ma ad una distanza fisica potenzialmente meno “minacciosa”. Tale ipotesi potrebbe arricchire la lettura clinica rispetto al lavoro con le parti del Sé, che su molteplici aspetti, appare facilitato e più efficace nella psicoterapia online. La danza diadica (Schore, 2008) della coppia terapeutica rispetto alla relazione di attaccamento, sembra essere a tratti più fluida, facilitando così anche il rapporto del paziente adulto con la propria esperienza interna. Questo conferma come la psicoterapia possa essere considerata una “esperienza relazionale correttiva”.
Le fobie delle parti del sé
Quando in clinica si lavora con i sistemi interni, seguendo le linee guida della Terapia degli Stati dell’Io (Shapiro, 2017) e/o della Teoria e dell’intervento con la Dissociazione Strutturale (Van der Hart et. al., 2006), si procede all’identificazione delle “parti del sé”, che possono essere più o meno dissociate, in modo da aumentarne la consapevolezza e quindi anche la regolazione e la gestione nella vita quotidiana.
In ottica clinica, tali “parti” possono essere riconducibili a circuiti neurali che conservano esperienze di vita, ricordi, memorie e sono portatrici di emozioni, sensazioni intense, e pensieri ricorsivi. Il sistema nervoso tende a proteggersi da tale intensità, sviluppando “difese” che mantengono la separazione e la frammentazione interna. Tali difese possono essere definite “fobie”, termine che può includere un senso di rifiuto, di paura, di spinta ad escludere e/o eliminare tali aspetti del sé dalla propria esperienza quotidiana.
Il meccanismo di sopravvivenza, che salva il cervello nelle situazioni acute, si mantiene attivo anche dopo che il pericolo è passato, continuando ad escludere dalla coscienza (emotiva, somatica e/o cognitiva) alcune parti del sé, che intensificano ulteriormente la loro esperienza implicita, entrando a forza nel vissuto del paziente, che è costretto a ri-sperimentare tali ricordi, benché sia impegnato ad escluderli dalla coscienza (Baita, 2018).
In psicoterapia abbiamo appreso a lavorare con le fobie, in altre parole le difese psichiche che proteggono il funzionamento quotidiano del paziente, attraverso l’approccio progressivo con l’EMDR (Gonzalez e Mosquera, 2016), includendo anche le preziose indicazioni cliniche di Janina Fisher (2017) e di Robin Shapiro (2017). Le strategie più efficaci possono essere riassunte nel promuovere la dis-identificazione della persona da ciò che sente, proponendo di considerare tale esperienza intensa come una parte di sé. Questo si fa provando a rappresentarla con un oggetto, un disegno o un’immagine mentale, per poi poter lavorare sulla relazione della persona adulta con tale parte del proprio sistema interno. L’obiettivo sarà promuovere il riconoscimento, la curiosità, la consapevolezza, la comprensione, l’empatia, la compassione verso quell’aspetto del sé, in modo da favorirne la regolazione e l’inclusione nell’esperienza cosciente, in vista di un processo integrativo.
Notiamo come la modalità online non solo mantenga l’efficacia di questi strumenti terapeutici, ma tenda ad incrementarne l’effetto. Ipotizziamo infatti che la distanza fisica, ed in particolare l’esclusione di alcuni sensi, come il tatto e l’olfatto, possa far sperimentare alle persone un senso di safety maggiore anche rispetto al terapeuta in quanto altro “mammifero” potenzialmente pericoloso, soprattutto per chi ha attraversato storie di
traumi complessi. Sembra che questo possa facilitare la regolazione adulta (associata clinicamente all’attivazione della corteccia prefrontale) e in qualche modo ridurre l’intensità delle fobie verso gli stati interni, cosa che permette un lavoro più immediato, rapido ed efficace.
Inoltre, il ricorso all’immagine del paziente stesso, che si ha a disposizione sui vari strumenti di videochiamata, può anche essere utilizzato come risorsa per il recupero del Sé Adulto e la presentificazione delle parti del sé, proponendo al paziente di guardarsi e di riconoscersi nella propria immagine presente.
L’utilizzo di oggetti appartenenti alla casa dei pazienti, e quindi più familiari a loro, sembra favorire la connessione empatica con l’esperienza interna; la possibilità di proporre una sperimentazione rispetto alla distanza da quell’oggetto sembra promuovere una gestione attiva e autonoma dell’oggetto stesso, che potrebbe dar luce ad un senso più profondo di empowerment nella gestione quotidiana delle sensazioni e emozioni intense o dei pensieri ricorrenti. Sembra che i pazienti si trovino a fare più lavoro per mantenersi adulti, pur portando il terapeuta nelle loro case e quindi più vicino, ma in una condizione di completo controllo del mezzo di comunicazione, come già evidenziato.
Inoltre, la possibilità di sperimentare la psicoterapia direttamente negli spazi della quotidianità del paziente, potrebbe facilitargli il consolidamento delle esperienze relazionali terapeutiche funzionali (es. adeguatezza, padronanza, protezione, regolazione), che non restano così confinate ad uno spazio “altro” rispetto alla vita di tutti i giorni, come può essere lo studio del terapeuta.
Non sappiamo esattamente quali siano i fattori in gioco, che sicuramente variano da situazione a situazione, ma in generale notiamo come questo tipo di lavoro di distinzione e collegamento dia spesso risultati di regolazione emotiva e somatica più efficaci rispetto al lavoro abituale delle sedute in vivo. Le persone riportano frequentemente di sentirsi più integrate, di gestire meglio la loro vita quotidiana, e di accedere con meno difficoltà a nuclei centrali di sofferenza. Come terapeuti abbiamo più facilmente una visione d’insieme del sistema interno dei nostri pazienti. Naturalmente questo non vale per tutte le situazioni cliniche, ma in generale possiamo spingerci ad ipotizzare che il lavoro di psicoterapia online con gli stati dell’io e le parti del sé abbia vantaggi imprevisti, da approfondire, continuare ad esplorare, mantenere ed eventualmente integrare al lavoro di psicoterapia tradizionale.
La mindfullness
La pandemia, esponendoci alla mancanza di sicurezza fisica ed economica, all’isolamento forzato e all’allontanamento sociale, alla paura e allo stress legati all’incertezza del futuro sollecita, come già evidenziato, in continuazione il nostro sistema di allarme e, in alcuni casi, tale situazione può riattivare e far riaprire vecchi dolori, aumentando il rischio di disorganizzazione emotiva.
Risulta dunque importante contrastare il senso di impotenza che si riscontra negli stati di peritraumatizzazione, la sensazione di essere trascinati dentro una situazione, coinvolti in uno stato che stimola la messa in atto di automatismi difensivi per avere la possibilità di sperimentare un senso di padronanza derivante dal sentire che stiamo partecipando in maniera attiva a una grande esperienza condivisa (Van der Kolk, 2020).
Estremamente utili le parole di Jon Kabat-Zinn, biologo molecolare che ha contribuito al diffondersi della mindfulness nella cultura occidentale, per orientarci in questo momento storico, quando definisce il dolore come
La realtà di ciò che sta succedendo, un gradiente naturale delle esperienze della vita
mentre la sofferenza come
Uno stato mentale ed emotivo determinato dal rapporto con quella realtà
e quindi una delle possibili risposte al dolore fisico ed emotivo (Kabat Zinn, 1990).
La mindfulness è una pratica di auto-osservazione che conduce ad una graduale maggiore consapevolezza di sé e della realtà in cui viviamo; è un modo di stare in interconnessione, relazione con sé stessi, con gli altri e con il mondo, con atteggiamento di curiosità, amicizia, accoglienza, apertura, lasciando risuonare quello che c’è, in modo non giudicante. Tale pratica si sviluppa partendo da una costante cura dedicata a qualità umane universali, innate intenzioni transpersonali quali la gentilezza verso sé stessi e gli altri, la compassione, la capacità di gioire con e per gli altri e l’equanimità, cioè la disponibilità e capacità di andare incontro a tutti i momenti della vita con eguale rispetto e sensibilità.
La coltivazione della mindfulness sia formale sia informale, individuale e di gruppo o inserita all’interno di un percorso terapeutico, si è rivelata, anche durante la pandemia, una pratica preziosa, un importante strumento di elaborazione della sofferenza. Essa favorisce infatti il processo di integrazione alla base del benessere psicofisico, a diversi livelli: intrapsichico, interpersonale, sociale e di connessione con il mondo.
Le pratiche meditative possono aiutare a:
- sperimentare una sensazione di radicamento al tempo presente che dà stabilità e permette di volgere lo sguardo al futuro in termini progettuali e non ansiosi;
- avere consapevolezza del corpo e del corpo in movimento per sentire di poter incanalare quella normale attivazione fisiologica presente in occasione di eventi stressanti;
- calmare il corpo e trovare uno spazio interiore di tranquillità dal quale è possibile ascoltare e regolare le emozioni, i pensieri e i comportamenti;
- favorire il decentramento e la disidentificazione con pensieri ed emozioni, migliorare la regolazione attentiva ed emotiva, riducendo ruminazione depressiva (Nolen-Hoeksema & Morrow, 1991) e ruminazione ansiosa (Roemer & Borkovec, 1993);
- contrastare l’ottundimento emotivo, ovvero una risposta fisiologica normale in situazioni di emergenza che porta a distaccarsi dalla realtà al fine di evitare le emozioni che creano sofferenza. Entrare in contatto con le emozioni e i pensieri, osservandoli attraversare la nostra esperienza senza farsi travolgere da essi, permette di coglierne la natura transitoria e di scegliere di agire in modo non reattivo ma intenzionale;
- proteggerci dal ricorrere all’utilizzo di strategie di autoregolazione disfunzionali (alcool, cibo, sostanze);
- favorire lo sviluppo di un’embodied mind: la sollecitazione della corteccia prefrontale mediale sinistra, attivata dalla mindfulness, è alla base di un sistema mente-corpo integrato;
- coltivare l’empatia e la compassione, assumere un atteggiamento di apertura, accoglienza e accettazione nei confronti delle proprie e altrui fragilità e di quelle parti più soggette al giudizio, migliorando la resilienza alla situazione;
- mantenere attiva la naturale tendenza dell’essere umano alla connessione, sia con sé stessi sia con gli altri, anche se a grossa distanza, e indirizzare l’azione al mantenimento di questa connessione con i mezzi elettronici disponibili;
- sentire un senso di appartenenza ad un gruppo con il quale condividere dei momenti di pratica a distanza; la crescita della consapevolezza, intesa come fenomeno che avviene attraverso la connessione tra sé, gli altri e il mondo, insieme alla compassione si sono rivelate un potente regolatore della facoltà morale che ci ha permesso di co-evolvere come specie.
Anche in tempo di pandemia partire da quello che è il nostro presente, ancorati ad un senso di sicurezza interno, è importante per mantenere la possibilità di scegliere e di agire in direzione del futuro.
Conclusioni
Questo articolo nasce dal confronto fra psicoterapeuti che hanno vissuto, per la prima volta nella storia umana, l’esperienza del proprio lavoro in un contesto di pandemia.
A fronte di un impoverimento dato dall’impossibilità di una relazione in presenza, la nostra flessibilità e capacità di adattamento come esseri umani hanno permesso alla relazione terapeutica di andare oltre il distanziamento sociale.
La condivisione di riflessioni cliniche ha fatto emergere vantaggi inaspettati e sorprendenti, ci ha spinto a conformare e co-costruire nuove modalità e strumenti terapeutici, ma richiede ulteriori approfondimenti e sviluppi di ricerca sull’efficacia a medio e lungo termine.