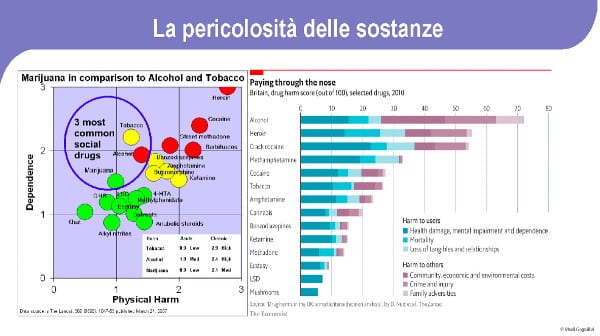La ‘ricerca’ del lavoro passa da se stessi
Il contesto lavorativo odierno è sempre più complesso, risulta quindi sempre più vantaggioso individuare le variabili personali coinvolte nelle varie fasi dell’esperienza di lavoro. Infatti, oggi più che mai, occorre fare affidamento sulle qualità e potenzialità di ciascuno, cercando di sviluppare le capacità resilienti laddove sono carenti.
Introduzione
Com’è noto il lavoro ha una funzione fondamentale nella vita delle persone e generalmente non è finalizzato soltanto al guadagno. Alla domanda su cosa farebbero se vincessero alla lotteria una somma sufficiente per vivere (lottery question), due persone su tre hanno risposto che continuerebbero a lavorare (Sarchelli G. e Fraccaroli F. 2010).
Alcuni autori parlano di un ‘Sé professionale’ per spiegare come l’attività lavorativa svolga un ruolo centrale nella vita dell’individuo e contribuisca a una maggiore definizione dal punto di vista sociale e personale (Fabbri e Rossi, 2001).
Tuttavia, seppure il lavoro ha la centralità descritta, ormai sempre più spesso può essere anche fonte di preoccupazione e stress. Per molte persone, infatti, il lavoro rappresenta qualcosa di incerto, di provvisorio, di discontinuo; anche quando è presente può terminare da un momento all’altro sia per il tipo di contratto, sia per le possibili crisi o cambiamenti che possono investire le organizzazioni dove si lavora. Inoltre, tutte le forme atipiche e flessibili di lavoro possono influire sullo stato emotivo del lavoratore creando instabilità e incertezza per il futuro, difficoltà a fare progetti di vita (per esempio matrimonio, figli, investimenti nell’acquisto della casa).
In relazione al quadro descritto possiamo dire che nella nostra Società è diventato sempre più difficile costruire un’identità professionale abbastanza stabile; infatti di frequente è richiesto alle persone di essere ‘flessibili’ per potersi adattare a ruoli e mansioni che vengono ‘imposte’ dalle logiche economiche del mercato del lavoro. A ulteriore conferma del nesso tra lavoro e aspetti emotivi, diversi studi hanno messo in luce come l’insicurezza lavorativa influisce negativamente sulla salute psicologica e fisica, pesando sul livello di soddisfazione e sul coinvolgimento lavorativo (Cheng e Chan, 2008).
A tutte le criticità citate va necessariamente aggiunto un richiamo all’emergenza coronavirus che ha generato allarme non solo a livello sanitario ma anche economico e sociale; la pandemia inevitabilmente sta avendo un forte impatto sul mercato del lavoro e complica ulteriormente il quadro già da tempo in grande crisi, specialmente in alcuni settori.
Considerando la complessità del contesto del lavoro si ritiene possa risultare vantaggioso individuare le variabili personali coinvolte nelle varie fasi dell’esperienza lavorativa. Infatti, oggi più che mai, occorre fare affidamento sulle qualità e potenzialità di ciascuno, cercando di sviluppare le capacità resilienti laddove sono carenti.
Nel presente articolo, come evidenzia già il titolo, viene messo al centro l’individuo. Per farlo si cercherà di parlare di alcuni aspetti che possono facilitare o ostacolare la messa in campo delle risorse personali. La parola ricerca nel titolo fa riferimento a varie accezioni: ricerca di crescita professionale, ricerca di un inserimento del mondo del lavoro e/o di una ricollocazione, o riqualificazione. Ma principalmente si farà riferimento a una ricerca che parte da sé, dalla possibilità di riflettere sul proprio modo di affrontare la ‘questione lavorativa’, anche a livello emotivo.
Attribuzione interna e esterna
É osservazione comune che non tutti reagiscono allo stesso modo nelle situazioni critiche. C’è chi tende più facilmente a scoraggiarsi e a temere il fallimento e chi invece, pur consapevole delle difficoltà, riesce a mantenere un impegno costante e proattivo senza farsi fermare quando le cose non vanno bene. È evidente che questi due stili descritti nascono da modi diversi di sentire e valutare le situazioni e portano a modi di agire differenti.
Il Locus of control (Rotter, 1996) fa riferimento al diverso grado di controllo che i soggetti sentono di avere sulle situazioni. Quindi potremmo dire che nel locus of control esterno le motivazioni identificate per spiegare la mancanza del lavoro, o una situazione lavorativa insoddisfacente, sono molto orientate all’individuazione di fattori ostacolanti esterni: ingiustizie, la fortuna o il caso, mancanza di offerte, crisi economica, eccetera; mentre nel locus of control interno l’attenzione è prima di tutto orientata a capire quali azioni si potrebbero mettere in atto per far fronte alle difficoltà incontrate. Nel primo caso, pertanto, il soggetto potrà più facilmente farsi l’idea che la soluzione deve venire dall’esterno; e questa convinzione può portare a un atteggiamento più orientato in modo passivo. Mentre nel secondo caso, senza necessariamente escludere il peso dei fattori esterni, è come se il soggetto si sentisse in grado di poter modificare la situazione, come se la soluzione dipendesse anche da lui, da quello che fa o non fa. E questo atteggiamento, generalmente, permette alla persona di sentirsi più attiva, di percepire un maggior controllo, appunto, sulla situazione.
Mindset statico e mindset dinamico
Per articolare la riflessione sull’argomento può essere di aiuto la teoria sul mindset statico e dinamico elaborata da Carol Dweck, docente di psicologia presso la Stanford University.
Per la Dweck le credenze che adottiamo riguardo a noi stessi influenzano profondamente il modo in cui gestiamo la nostra vita. Da queste dipende la possibilità di diventare la persona che si vorrebbe essere e di ottenere le cose a cui si attribuisce importanza. Non è solo questione di DNA e di predisposizioni individuali perché grazie alla forma mentis è possibile influire sulle proprie capacità attuali e future.
Questa posizione non vuol dire che tutti possono realizzare tutto, e che chiunque impegnandosi possa diventare Einstein o Beethoven, ma, spiega la studiosa:
[…] sono convinta che il vero potenziale di una persona sia sconosciuto (e non conoscibile), che sia impossibile prevedere quali potranno essere i risultati ottenibili con anni di passione, fatica e formazione. (Dweck, 2017)
Le osservazioni della ricercatrice hanno portato a rilevare come coloro che sono caratterizzati dal mindset statico più facilmente cercheranno nelle diverse situazioni la conferma delle proprie capacità ponendosi domande del tipo: ce la farò o fallirò? Farò la figura di quello intelligente o del mediocre? Verrò accettato o rifiutato? Pertanto, l’attenzione è molto focalizzata sull’importanza di dimostrare di essere capaci e apprezzabili e dal timore di non riuscire nell’intento; in sostanza possiamo dire che questi soggetti sentono di dover dimostrare sempre qualcosa e che qualora non avessero successo temono di andare incontro a un giudizio negativo da parte degli altri o di se stessi.
Il mindset dinamico si fonda invece sulla convinzione che le qualità di base possano essere coltivate ed accresciute con l’impegno. Un punto importante che caratterizza chi ha l’atteggiamento descritto è la ricerca di nuove strategie quando quelle utilizzate non si rivelano adeguate. Chi possiede questa forma mentis è meno preoccupato di dimostrare di essere capace ed è maggiormente orientato ad apprendere. Più facilmente, se anche non riesce in un’attività, penserà di poter migliorare impegnandosi di più.
I soggetti che hanno un mindset dinamico riescono ad affrontare meglio le sfide e riconoscono la gradualità del processo di apprendimento; questo diverso atteggiamento permette di non entrare in ansia se non si riesce a risolvere con facilità un compito e di non sentire un eventuale errore come una minaccia alla propria autostima.
Mentre chi possiede una forma mentis statica si aspetta che le capacità verranno fuori da sole, prima che abbia luogo un vero processo di apprendimento e questo accade proprio perché in qualche modo queste vengono considerate come innate e non come un potenziale da sviluppare.
La studiosa racconta come lei stessa fosse stata educata al mindset statico fin dall’infanzia e come già da bambina cercasse sempre di dimostrare di essere brillante. In un secondo momento anche una sua insegnante contribuì a rinforzare la modalità appresa; in effetti i docenti possono favorire tale atteggiamento se sollecitano gli studenti a mostrarsi intelligenti e capaci piuttosto che a provare piacere nell’apprendere.
Un ruolo ugualmente importante, per la Dweck, viene svolto dall’atteggiamento dei genitori che attraverso il modo con cui incoraggiano i bambini finiscono per influire sullo sviluppo del tipo di forma mentis. Per esempio, rassicurare i bambini sulla loro intelligenza e sul loro talento può essere controproducente perché non mette l’attenzione sul processo di apprendimento ma sul risultato. Quando vengono lodati spesso i figli possono entrare in ansia, in occasione di esami o altre prove, perché temono la valutazione e sono preoccupati di dover mantenere un livello alto nei voi e giudizi; inoltre se si sentono ripetere di frequente che sono bravi e capaci, possono aver paura di deludere le aspettative dei familiari (Dweck, 2008).
Per la studiosa
Sebbene le persone differiscano tra loro in mille modi – talenti e attitudini iniziali, interessi, temperamento – ognuna di esse ha la possibilità di cambiare e di crescere attraverso l’applicazione e l’esperienza. (Dweck, 2017)
Per dimostrare come insuccessi nella carriera non siano necessariamente indicativi di mancanza di talento e non vadano considerati predittivi per il proprio futuro cita alcuni noti personaggi appartenenti a diversi ambiti: Ben Hagan noto golfista, che da bambino era totalmente scoordinato, la fotografa Cindy Sherman, che era stata bocciata al suo primo corso di fotografia e l’attrice Geraldine Page, a cui fu sconsigliato di intraprendere la carriera cinematografica perché non aveva la stoffa.
Molte delle ricerche sull’argomento sono state condotte a partire dall’osservazione del modo diverso in cui gli studenti reagiscono a compiti difficili. È stato inoltre notato che il mindset statico e dinamico si formano fin da piccoli e tendono a perdurare se non intervengono fattori nuovi in grado di modificare la convinzione maturata. Secondo la Dweck i mindset possono influenzare non solo il percorso scolastico, ma anche gli altri ambiti della vita come quello professionale, sociale e anche affettivo.
In merito a quanto detto è importante segnalare che i soggetti che hanno un mindset statico tenderebbero a scoraggiarsi in particolare quando non riescono in qualche attività, se per esempio vanno incontro a un fallimento o a un insuccesso; mentre possono sentirsi stimabili e apprezzati, mostrando quindi una buona autostima, quando ottengono dei successi. La differenza con coloro che hanno un mindset dinamico si manifesta proprio quando si incontrano degli ostacoli perché più facilmente questi saranno in grado, nonostante tutto, di impegnarsi nell’affrontare i problemi incontrati senza avere importanti ripercussioni sull’autostima; riescono, pertanto, a mantenere una fiducia nella possibilità di riuscire a risolvere le difficoltà che di volta in volta si presentano.
Mindset e lavoro
Un breve esempio può essere utile ad esemplificare: un manager cinquantenne con una brillante carriera, fino a quando vengono concordate le sue dimissioni perché l’azienda deve mettere in atto una riorganizzazione. Inizialmente l’uscita dall’azienda viene vissuta bene perché rappresenta un’opportunità di cambiamento. Ma quando incontra difficoltà nel trovare una ricollocazione, sembrano emergere atteggiamenti e sentimenti riconducibili al mindset di tipo statico. Nonostante il curriculum ricco di esperienze significative comincia a prendere forma un senso di vergogna e sfiducia che porta il manager a ridurre il suo impegno nella ricerca.
L’intervento focalizzato sul problema lavorativo ha permesso al dirigente di comprendere come la sua lettura dell’esperienza non gli aveva creato problemi finché era andato tutto bene e aveva ricevuto apprezzamenti circa le sue capacità; invece, nel momento in cui le conferme a cui era abituato sono venute a mancare, e anzi bisognava fare i conti con la delusione prodotta dalle risposte negative alla sua candidatura, o addirittura dall’effetto che gli faceva non ricevere nessuna risposta, il suo senso di sé ne ha risentito portandolo a un atteggiamento di ‘ritiro’ e di tipo depressivo. In pratica il manager non riusciva a fare una valutazione obiettiva delle sue esperienze professionali e quindi del valore che avrebbero potuto avere ancora per le Aziende; la sua valutazione ormai era influenzata dal suo stato emotivo. Si trattava quindi di cambiare prospettiva sia su di sé che sul contesto aziendale. Una volta messo a fuoco come si sentiva nella nuova fase della sua vita, il manager è riuscito a riprendere la ricerca di un’attività con maggiore fiducia, senza leggere ogni contrarietà come prova dell’impossibilità di ricollocarsi.
Un altro esempio altrettanto utile ad esemplificare può essere rappresentato da una giovane insegnante della scuola primaria che non sentendosi in grado di lavorare ha dovuto prendere lunghi periodi di malattia. La ragazza aveva uno stile di personalità per cui già in altre occasioni stressanti aveva reagito con una flessione dell’umore; ma in questo frangente è stato possibile ricostruire gli eventi che le avevano creato il forte disagio, con conseguente demotivazione: le era stata assegnata una classe frequentata da diversi alunni impegnativi dal punto di vista relazionale e lei non si sentiva assolutamente in grado di gestirla. Inoltre, l’insegnante si aspettava che le sarebbero state assegnate delle classi più tranquille, e quindi ha vissuto l’incarico come una mancanza di considerazione e rispetto nei suoi confronti. Una volta messi a fuoco i diversi passaggi la ragazza ha capito che insegnare in una classe più impegnativa poteva rivelarsi una sfida interessante e che tutto sommato si sentiva in grado di affrontare la sfida. Inoltre, la decisione della direttrice che inizialmente era stata percepita come una mancanza di considerazione, come se questa avesse voluto favorire altri colleghi, in un secondo momento è stata letta come possibile espressione di un atto di fiducia. Anche in questo esempio sembrano emergere delle convinzioni riconducibili al mindset statico, che possono aver contribuito a uno stato di scoraggiamento e sfiducia.
Poiché il focus è posto sul modo con cui ciascuno si spiega le difficoltà che incontra a vario titolo nell’interfacciarsi con il contesto lavorativo, e non sulle criticità che presenta quest’ultimo, tale approccio può essere vantaggioso in qualsiasi settore del lavoro. L’intento, infatti, è quello di individuare il ruolo svolto dalle variabili emotive.
E tuttavia, le diverse sfaccettature della personalità di un individuo sono un tema molto complesso e difficilmente riconducibile alla teoria del mindset. Ma quest’ultima può essere utile per individuare in modo abbastanza rapido i meccanismi che portano a risposte di sfiducia e scoraggiamento nel contesto lavorativo.
Infatti, possiamo immaginare che coloro che hanno una concezione riconducibile a un mindset statico potrebbero sentirsi più facilmente preoccupati trovandosi nella necessità di cercare lavoro, in particolare se questo dovesse accadere in seguito a un licenziamento. Ma anche chi si trovasse alla prima esperienza lavorativa potrebbe scoraggiarsi nel dover affrontare le frequenti delusioni che si verificano nella fase di ricerca delle offerte. I soggetti con un mindset statico, quando si verifica una situazione percepita come fallimento, possono avere maggiori ripercussioni a livello dell’autostima e più facilmente possono andare incontro a stati depressivi.
La Dweck precisa che le persone con una forma mentis statica non hanno necessariamente poca fiducia in se stessi,
[…] almeno prima dell’irrompere di un determinato evento nella loro vita. (Dweck, 2017)
Tuttavia, la loro fiducia di fronte a delle sconfitte è più fragile e in seguito riescono più difficilmente a mettere in campo l’impegno necessario per raggiungere un obiettivo.
La studiosa cita una ricerca svolta da Joseph Martocchio che riguarda i dipendenti di un’azienda che dovevano seguire un corso di formazione di informatica per il quale era stato spiegato che si trattava di apprendere alcune abilità con il computer che si sarebbero potute sviluppare ulteriormente con la pratica.
Alcuni degli impiegati presentavano un mindset statico e altri dinamico, ma tutti avevano analoghe competenze dal punto di vista informatico.
I partecipanti con mindset dinamico mostravano tuttavia di credere sempre più nelle proprie capacità via via che imparavano, malgrado i numerosi errori che inevitabilmente commettevano. Al contrario, proprio a causa di quegli errori, coloro che avevano un mindset statico di fatto perdevano fiducia nelle proprie capacità via via che imparavano! (Dweck, 2017)
La diversa risposta al corso di formazione esemplifica bene come alcune credenze su come andrebbe affrontato un compito nuovo, per esempio imparando subito, possano condizionare il comportamento e influire sul modo in cui si cerca di raggiungere un obiettivo.
Rimane però aperta la domanda circa le condizioni che portano a sviluppare un mindset piuttosto che l’altro e che incidono sulle eventuali modifiche successive.
Stili di attaccamento e mindset
Un contributo per comprendere quali esperienze possono condurre a sviluppare un determinato mindset potrebbe fornirlo la teoria dell’attaccamento nella sua concettualizzazione classica di Bowlby e Ainsworth e il successivo contributo fornito dall’inquadramento postrazionalista elaborato da Vittorio F. Guidano. Per quest’ultimo le dimensioni sicuro/insicuro sono trasversali ai diversi stili di attaccamento che si articolano lungo un continuum che va dall’attaccamento sicuro al disorganizzato e pertanto non costituiscono una categoria a sé (Guidano 2007).
Alla luce di questa teoria potremmo ipotizzare che coloro che hanno sviluppato uno stile di attaccamento sul versante sicuro, avranno maggiori possibilità di sviluppare un mindset dinamico. Infatti i bambini che fanno l’esperienza di una base sicura sentono di poter esplorare l’ambiente con maggiore tranquillità e di conseguenza faranno una gamma di esperienze più ricca. Connesso alle presenza di una base sicura l’acquisizione di un’adeguata capacità di riconoscere le emozioni e di regolare gli stati emotivi. Aspetti che sembrano correlabili alle caratteristiche descritte dalla Dweeck per il mindset dinamico.
Plausibilmente le caratteristiche descritte, se saranno confermate nelle successive fasi della crescita, una volta adulti permetteranno di muoversi in modo sicuro anche nel contesto lavorativo, e di poter affrontare i momenti critici che di volta dovessero presentarsi, con una maggiore fiducia nella possibilità di superarli.
Com’è noto lo stile di attaccamento può essere suscettibile di una sorta di riorganizzazione nel corso delle diverse fasi della vita, grazie a sollecitazioni prodotte da nuove relazioni e da nuove esperienze.
Poiché il lavoro ricopre un ruolo di rilievo nell’equilibrio personale, anche gli eventi che si verificano in questo ambito potrebbero in qualche modo contribuire a modificare alcune componenti dello stile di attaccamento e viceversa.
Cambiamenti importanti nell’esperienza immediata e nella coerenza del significato personale si susseguono […]. Nessun momento specifico del ciclo di vita individuale può, pertanto, essere identificato come quello in cui si sia acquisita una comprensione ultima ed esaustiva, così come non è possibile individuare […] l’esistenza di un equilibrio “giusto” o “ottimale”, o di qualsiasi altra cosa che possa suggerire il raggiungimento di uno stadio definitivo di “maturità. (Guidano 1992)
L’individuo quindi è potenzialmente in grado di andare incontro ad evoluzioni dinamiche e a trasformazioni. Ma talvolta se un grave contrattempo (come per esempio la perdita del lavoro) viene vissuto come espressione di una propria carenza, può portare a una sorta di blocco e demotivazione. Tanto più il soggetto sentirà che le difficoltà sono dovute, per esempio, a una sua inadeguatezza e tanto più se ne potrebbe sentire condizionato a causa dei vissuti emotivi negativi che ne derivano. In questa evenienza si può creare un sovraccarico di stress, determinato da preoccupazioni economiche, difficoltà a cercare lavoro e sfiducia. L’insieme di questi elementi può portare a un malessere psicologico e rischia di generare un circolo vizioso che, se non interrotto, può anche portare a stati depressivi.
Sia la teoria del mindset della Dweck, che la teoria dell’attaccamento possono aiutare a individuare delle modalità per supportare processi di evoluzione e crescita delle persone, pur operando a un livello diverso. Considerare lo stile di attaccamento implicherebbe agire anche sulle esperienze emotive che portano a determinate spiegazioni su di sé, mentre intervenendo sul mindset si agirebbe a livello delle credenze per cercare di modificarle.
Conclusioni
In un momento di grave difficoltà come quello attuale, con la pandemia che ha inevitabili e gravi ripercussioni sul contesto lavorativo, diventa ancora più importante provare ad investire al massimo sulle potenzialità e risorse delle persone. Talvolta un atteggiamento demoralizzato, sebbene assolutamente comprensibile e giustificato, non aiuta a intravedere possibili opportunità e scenari alternativi che eppure potrebbero esserci.
Pertanto spiegazioni prevalentemente orientate a evidenziare le criticità esterne, tra cui quelle del mondo del lavoro, non sempre aiutano a trovare nuove strategie e soluzioni. Mentre focalizzare l’attenzione sul soggetto può aprire la possibilità di trovare soluzioni e idee nuove e creative.