Martin Kolbe e il suo tour bipolare (Bipolar Roadshow) – Intervista
La storia di Martin è drammatica e affascinante allo stesso tempo, fatta di salite e discese, un po’ come il disturbo bipolare. A metà degli anni ottanta Martin deve arrendersi al disturbo bipolare, che lo terrà lontano dal palco per quasi vent’anni, onde poi tornare con un nuovo bellissimo disco dal titolo emblematico Songs from the Inside.
Sono venuto a conoscenza dell’esistenza del chitarrista e cantante tedesco Martin Kolbe attraverso l’International Bipolar Foundation, un’attivissima associazione americana che da anni svolge un’opera di sensibilizzazione e psicoeducazione sul disturbo affettivo bipolare, della quale fanno parte tantissime persone affette da tale disturbo e i loro familiari, provenienti da ogni parte del mondo.
La storia di Martin è drammatica e affascinante allo stesso tempo, fatta di salite e discese, un po’ come il disturbo bipolare. Martin alla fine degli anni Settanta è un chitarrista di successo, in duo acustico con il chitarrista Ralf Illenberger, con il quale in dieci anni ha registrato sei dischi e si è esibito in più di mille concerti in quaranta paesi. Esistono tanti video su Youtube delle performance del duo, tratti da trasmissioni televisive dell’epoca, dove colpisce il virtuosismo chitarristico della coppia, che spazia dal fingerpicking più classico fino alla creazione di atmosfere new age (di cui successivamente Illenberger diventerà interprete e compositore acclamato).
A metà degli anni ottanta Martin deve arrendersi al disturbo bipolare, che lo terrà lontano dal palco per quasi vent’anni, onde poi tornare con un nuovo bellissimo disco dal titolo emblematico, Songs from the Inside, contenente canzoni ispirate alla sua esperienza di paziente e al percorso di cure dalla malattia. Un disco catartico che Martin presenta al pubblico con il tour Bipolar Roadshow, che lo porta ad esibirsi anche a congressi di psichiatria e luoghi di cura, riaccendendo la speranza in tante persone.
Le canzoni del disco sono caratterizzate da arrangiamenti folk abbastanza essenziali ma molto efficaci, che valorizzano la voce profonda di Martin e la sua raffinata tecnica chitarristica. I testi sono poetici, ma anche molto interessanti dal punto di vista psichiatrico.
Il brano Come water ad esempio parla di un ragazzo affetto da disturbo ossessivo compulsivo che Martin ha incontrato in clinica e che aveva la compulsione al lavaggio, Prayer arriva diretta come un pugno nello stomaco in quanto ritrae una sorta di mantra suicidiario, che risuona nella testa della persona depressa mentre prende in rassegna le diverse modalità per togliersi la vita: A needle in my heart/ Poison on my tongue/ Fire on my skin/ Water in my lungs… (Un agone nel mio cuore, veleno sulla mia lingua, fuoco sulla mia pelle, acqua nei miei polmoni). Il testo si sposa perfettamente a un accompagnamento musicale ripetitivo e solenne, su tonalità minori, che da la sensazione all’ascoltatore di sprofondare sempre più verso il basso. Family descrive un episodio maniacale e quella particolare sensazione di fratellanza universale che può provare la persona in fase di euforia camminando per strada e pensando che tutti gli sconosciuti che incontra siano come fratelli. Something holding you, scritta insieme a un amico, rappresenta invece l’esperienza depressiva, l’altra faccia della medaglia in tutta la sua tragicità: You wait for sunrise and a crystal sky/ That’s just a dream, better say good-bye (Aspetti il tramonto e un cielo cristallino /Quello è solo un sogno, meglio dire addio) e ancora You say you’ve changed but it won’t last for long/ Nobody else is gonna make you strong (Dice di essere cambiato ma non durerà a lungo/ Nessuno altro ti renderà più forte). Con delle canzoni di questo tipo non potevamo non volerne sapere di più.
La tua storia di alti e bassi è drammaticamente affascinante e credo molto interessante per le persone che combattono ogni giorno contro i disturbi psichiatrici. Da musicista professionista in duo con Ralf Illenberger, agli anni della malattia e delle cure e poi il ritorno alla musica con questo nuovo progetto in cui è come se avessi rielaborato questa esperienza dolorosa. Te la senti di raccontarci come sono andate le cose?
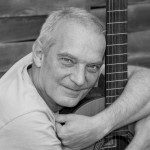 Sono stato attratto dalla musica molto precocemente. I miei genitori mi hanno raccontato che già a cinque anni amavo cantare nel sottoscala di casa perché il suono era fantastico e c’era una specie di riverbero naturale. Quando avevo circa dieci anni ho scoperto una vecchia chitarra acustica che mia madre suonava occasionalmente. Nello stesso periodo ho scoperto la musica fantastica dei Beatles tramite mio fratello e mia sorella e ne sono rimasto affascinato. Così la prima canzone che ho cercato di strimpellare con la chitarra è stata I need you di George Harrison, con l’aiuto del fidanzato di mia sorella che mi mostrò qualche accordo. Negli anni successivi ho esplorato sempre di più lo strumento, amando scoprire nuovi accordi, accordature e tecniche in modo autonomo, liberamente (es. mettendo un microfono dentro la cassa e attaccandolo al registratore di mio fratello). A tredici anni ho iniziato a suonare la batteria in diverse band rock-blues locali fino all’età di diciotto anni.
Sono stato attratto dalla musica molto precocemente. I miei genitori mi hanno raccontato che già a cinque anni amavo cantare nel sottoscala di casa perché il suono era fantastico e c’era una specie di riverbero naturale. Quando avevo circa dieci anni ho scoperto una vecchia chitarra acustica che mia madre suonava occasionalmente. Nello stesso periodo ho scoperto la musica fantastica dei Beatles tramite mio fratello e mia sorella e ne sono rimasto affascinato. Così la prima canzone che ho cercato di strimpellare con la chitarra è stata I need you di George Harrison, con l’aiuto del fidanzato di mia sorella che mi mostrò qualche accordo. Negli anni successivi ho esplorato sempre di più lo strumento, amando scoprire nuovi accordi, accordature e tecniche in modo autonomo, liberamente (es. mettendo un microfono dentro la cassa e attaccandolo al registratore di mio fratello). A tredici anni ho iniziato a suonare la batteria in diverse band rock-blues locali fino all’età di diciotto anni.
Quando avevo diciassette anni un mio amico mi registrò mentre suonavo e cantavo e decise di produrmi un disco. La radio locale iniziò a trasmettere uno dei brani del disco quotidianamente (un riadattamento strumentale del brano Mrs Robinson di Paul Simon). Da quel punto in avanti le cose si sono sviluppate in modo abbastanza rapido e naturale. Durante le scuole superiori ho registrato altri due dischi solisti e ho iniziato a suonare in locali e festivals durante i weekend o durante le ferie scolastiche.
Nel 1977 ho incontrato Ralf Illenberger, un chiatarrista che viveva nella città vicino alla mia. Scoprimmo da subito una grande affinità artistica e ci fu una sorta di innamoramento musicale. Dopo questo incontro il suonare da soli era diventato così noioso e entrambi concordammo sul fatto che non ci restava che dare vita a un duo chitarristico. Il nostro primo disco insieme è stato un successo immediato ed è succeduto a dieci anni di attività live e di studio, comprese diverse esibizioni televisive e radiofoniche.
Dopo il primo anno di collaborazione con Ralf ho avuto il primo episodio bipolare. E’iniziato con una fase depressiva (oggi si chiamerebbe forse Sindrome da bornout), seguita da una vero episodio maniacale, che sfociò rapidamente in una psicosi. Non riuscivo davvero a rendermi conto cosa stesse succedendo dentro di me. Il conseguente ricovero in clinica mi ha riportato sulla
terra con l’aiuto delle medicine e i medici si riferirono all’accaduto come a una crisi adolescenziale.
Dopo quattro anni di benessere ebbi un secondo episodio depressivo nel 1983, non così grave, che si risolse spontaneamente senza la necessità di ricovero o cure farmacologiche. Nel 1987 ebbi un’altra ricaduta molto pesante, che mi portò a separarmi da Ralf, quasi a separarmi anche da mia moglie e i bambini e che ha rovinato la mia carriera musicale per molti anni. A questo punto mi venne fatta la diagnosi di disturbo bipolare. E’ stato un lento processo di presa di coscienza durato venticinque anni, dall’insorgenza dei primi sintomi, la diagnosi fatta otto anni dopo, una prima negazione del problema, fino a una progressiva accettazione che mi ha portato a stare attento all’insorgenza dei sintomi precoci e, la cosa più importante, ad attivarmi subito in caso di instabilità, per prevenire tutte le conseguenze negative della mania.
Essere un musicista famoso è stato per certi versi un ostacolo alle cure del tuo disturbo?
Beh…in realtà non ero proprio così famoso, non ero una rockstar. Avevamo i nostri fans che ci seguivano, ma la nostra musica era un po’ di nicchia, troppo particolare per raggiungere la vetta delle classifiche. Per questo motivo l’essere musicista non ha influenzato le cure.
Ci racconti qualcosa di più del tuo percorso di cure?
Il mio primo episodio maniacale è stato trattato con Aloperdolo, che è stato molto efficace, ma che mi ha causato terribili effetti collaterali, come crampi muscolari dolorosissimi. Successivamente, durante un ricovero mi hanno prescritto Benperidolo, che è stato anche peggio. Durante il mio terzo e ultimo ricovero, nel 1993 non mi hanno dato farmaci perché non avevo sintomi maniacali (mi ha fatto ricoverare la mia ex moglie che pensava fossi in fase maniacale). Successivamente alla diagnosi di disturbo bipolare mi è stato prescritto il Litio, che ho continuato per circa sei mesi. Ho deciso di smetterlo perché la mia vita emotiva si era molto appiattita e, cosa ancora peggiore, la mia creatività era svanita. In questi anni ho sentito tante storie di persone in terapia con Litio, a cui questa medicina non ha ostacolato la creatività, ma a me faceva questo effetto. Tutti i medici che ho incontrato dopo la diagnosi di disturbo bipolare non mi hanno consigliato un uso continuativo di stabilizzatori dell’umore in quanto tra gli episodi critici passava un lasso di tempo di almeno quattro anni. L’idea era invece di intervenire a livello farmacologico in fase acuta in caso di instabilità. Questa strategia è stata usata fino al 2003, quando ho avuto l’ultimo e più estremo episodio maniacale. Successivamente mi sembra di aver trovato un modo autonomo per gestire i miei sbalzi di umore ed energia.
Non ho mai provato la psicoterapia. Dopo il primo ricovero era stata consigliata dal medico della clinica. Allora ho avuto un colloquio con due psicoterapeuti. La prima era una sessantenne con atteggiamento tipicamente freudiano. La prima domanda è stata infatti Com’era tua madre? e non mi ha fatto sentire nel posto giusto. Il secondo era uno psicologo più giovane che mi ha chiesto se era mia o del medico l’idea di iniziare una terapia. Visto che l’idea non era mia ho deciso di non andarci più.
Dove ti esibisci di solito con il Bipolar Roadshow? Come reagisce il pubblico?
La reazione del pubblico ha superato le aspettative. Sembra proprio che la nostra modalità di diffondere informazioni sul disturbo bipolare funzioni perfettamente. In questo senso non misuro il successo con la forza e la lunghezza degli applausi o con il numero di bis richiesti. Il successo qui è vedere come gli spettatori siano toccati e commossi e le loro reazioni personali molto intense dopo i concerti ci dimostrano quanto siano stati coinvolti.
Ci racconti qualcosa del tuo disco Songs from Inside? La sua realizzazione ha avuto per te un effetto catartico o terapeutico? Come sono nati i testi?
Mah, non credo di usare il pubblico come terapeuta o di cercare di risolvere i miei problemi personali raccontandoli nelle canzoni. Le canzoni del CD sono state scritte subito dopo che si sono verificate le situazioni di cui trattano. Il mio obiettivo è stato quello di condividere le mie esperienze e le mie emozioni con gli altri, anche per far sentire alle persone con esperienze simili che non sono sole e che si possono superare eventi di vita traumatici. Un altro obiettivo è stato quello di raccontare qualcosa della psichiatria nei suoi vari aspetti ai cosiddetti normali.
Credo che i testi non abbiano bisogno di particolari commenti o spiegazioni in quanto sono piuttosto realistici e diretti. Ad esempio Keys parla del trovarsi nel reparto chiuso di un ospedale psichiatrico, Cage Birds racconta di altri pazienti che ho incontrato là, Holes è la storia di un compagno di stanza disperato e Prayer non è altro che il ripetitivo mantra suicidiario che gira e rigira nella tua testa quando sei molto depresso.
Esistono diversi studi sul rapporto tra la creatività e il disturbo bipolare, soprattutto nei grandi compositori (Beethoven, Schumann, etc.). Nella tua esperienza cosa ci puoi dire della relazione tra umore e creatività?
Non è così facile da dire in realtà. Credo che il disturbo bipolare possa portarti ad essere più sensibile e vulnerabile rispetto alle altre persone. Questo può essere un aiuto rispetto alla creatività. Durante un episodio maniacale diventi iper-creativo e può essere davvero stressante cercare di realizzare tutte le idee brillanti che nascono in continuazione. In ogni caso ho scoperto successivamente che la maggior parte di ciò che ho scritto, composto e suonato durante tali episodi non era così meritorio, in quanto tendeva ad essere super-espressivo e difficile da ascoltare in uno stato mentale equilibrato. Dall’altra parte nella fase depressiva non succede nulla, non c’è creatività in nessun aspetto, la vita stessa e tutti i tipi di suoni musicali diventano più una tortura che un’esperienza piacevole.
Cosa ne pensi dell’influenza degli eventi di vita sul disturbo bipolare?
Chiaramente non ho prove scientifiche a riguardo ma penso che ci sia una relazione tra alcuni miei problemi e impedimenti personali che si sono verificati nella mia vita e la comparsa del disturbo. Il punto potrebbe essere il non essere stato in grado di accettare di essere omosessuale e di non essere stato abbastanza coraggioso per vivere di conseguenza. Un’infanzia vissuta negli anni Sessanta in un piccolo villaggio del Sud della Germania come figlio di un pastore protestante potrebbe non essere stato il punto di partenza ideale per una vita felice e libera da gay. Sono convinto che si reprime una parte così importante di sé per un periodo così lungo sia molto probabile sviluppare un qualche tipo di disturbo, compreso il disturbo bipolare.
E dei percorsi psicoeducativi e psicoterapici per il disturbo bipolare che opinione hai?
Conosco un sacco di persone affette da disturbo bipolare che hanno beneficiato di trattamenti psicoterapici, benchè io non li abbia mai sperimentati. Da tutto quello che ho sentito sono arrivato alla conclusione che la terapia cognitivo comportamentale possa rappresentare un aiuto maggiore della terapia psicanalitica freudiana classica. In ogni caso ne so troppo poco per esprimere una reale opinione in merito. Credo fermamente che la psicoeducazione sia un aspetto molto importante nell’affrontare il disturbo bipolare: più cose sai sui sintomi precoci e su come gestirli, più riesci a prevenire gli esiti peggiori.
Ci racconti qualcosa sulla tua collaborazione con l’International Bipolar Foundation?
Muffy Walker, co-fondatrice dell’International Bipolar Foundation (IBPF) si mise in contatto un paio d’anni fa con la German Society for Bipolar Disorders (DGBS). Da lì è nata la nostra collaborazione. Ho conosciuto Muffy lo scorso inverno e sono rimasto impressionato dalla sua forza di volontà e dedizione. Nella primavera del 2014 abbiamo partecipato a un simposio sulle attività di sostegno ed autoaiuto durante il congresso a Seul dell’International Society for Bipolar Disorder (ISBD). Ho anche tenuto un webinar sul mio Bipolar Roadshow, trasmesso lo scorso agosto.
Ci dici qualcosa sulla situazione dello stigma nei confronti dei malati psichiatrici in Germania e se l’attitudine è cambiata negli ultimi anni?
Credo, o almeno spero, che lo stigma stia lentamente ma inesorabilmente diminuendo. Se tutti remiamo dalla stessa parte! Nel mio caso ho avuto più un’auto-stigmatizzazione che una critica dall’esterno. Dopo il primo ricovero volevo che nessuno lo sapesse e ho cercato di tenere la cosa segreta al pubblico. C’erano sicuramente delle situazioni e delle osservazioni che facevano male. Per esempio una dele mie sorelle mi disse Sarebbe stato meglio che avessi fatto un incidente in auto e fossi morto, che questo. Oggi ho cambiato completamente la mia attitudine parlando in modo assolutamente aperto del problema a chiunque sia interessato. Cerco di attirare l’attenzione dei media e sono felice che molti giornalisti chiedano di intervistarmi per giornali, programmi televisivi o radiofonici. Sono sicuro che il modo migliore per combattere lo stigma sia parlare apertamente del fatto di essere matto, così che l’altra gente veda che non c’è motivo per avere paura di noi o si vergogni per la propria condizione. Non l’abbiamo scelto! Un giorno forse sarà naturale e normale parlare della malattia mentale come lo è adesso discutere di prolemi di diabete o di pressione. C’è ancora molta strada da fare ma ci stiamo lavorando.
In che modi credi cha la musica possa promuovere la salute mentale?
Non te lo posso ancora dire perchè il mio progetto è ancora troppo giovane. Le cose sembrano promettere bene in ogni caso. Recentemente ho conosciuto una cantante inglese, Emily Maguire, che soffre di disturbo bipolare che ha appena prodotto un disco con canzoni che parlano della sua condizione e delle sue battaglie. E’ un CD molto ben arrangiato, interpretato e prodotto e spero abbia tanto successo. Spero che possa partecipare al Bipolar Roadshow 2015! Il tentativo di promuovere le questioni legate alla malattia mentale attraverso le arti e specialmente la musica è per me molto stuzzicante, con il fatto che puoi colpire il pubblico su un livello emotivo che ha un effetto più forte e duraturo rispetto all’ascolto di un discorso scientifico.
Ho l’impressione che la diagnosi di disturbo bipolare stia diventando sempre più popolare anche sui media negli ultimi anni. Molte rockstar, attori e personaggi pubblici hanno iniziato a fare coming out su tale disturbo (a volte anche per giustificare comportamenti problematici che non hanno niente a che vedere con la psichiatria). Cosa ne pensi?
Beh per molte celebrità il distubo bipolare viene ancora rivelato dopo la morte (es. Curt Kobain o Amy Winehouse) o si tratta di una sventura come per Catherine Zeta-Jones, per la quale l’informazione riguardante la sua malattia fu venduta ai media da un paziente della clinica dove era ricoverata. Gente come Sinead O’Connor, Jean-Claude van Damme e Stephen Fry sono ancora delle eccezioni.
Sto attendendo il giorno in cui un famoso sportivo o un politico faccia coming out di disturbo bipolare, facendo capire che non c’è niente di cui vergognarsi. Questo aiuterebbe enormemente la lotta allo stigma e aiuterebbe a capire. Nel frattempo noi dobbiamo andare avanti con la nostra pacifica crociata verso un futuro più luminoso, aperto e umano.
ARTICOLO CONSIGLIATO:
Martin Kolbe and his Bipolar Roadshow – Interview



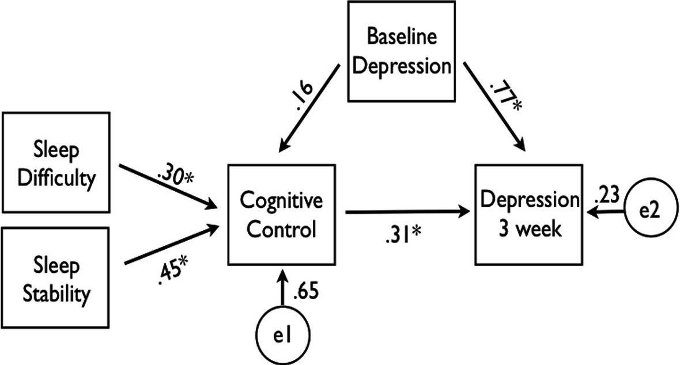
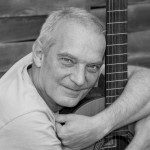 I was drawn to music quite early in my life. My parents told me later that as a young kid of five or so I loved to sing in the large staircase of our house because it sounded really good there with all the natural reverberation. When I was about 10 years old I discovered an old acoustic guitar which had been played by my mother occasionally in former years. At the time I discovered it the Beatles were the big thing and my brothers and sisters brought this music to our house – I was immediately fascinated by it. So the first song I tried on this guitar was “I Need You” by George Harrison. My sister’s boyfriend showed me some chords. During the following years I explored this instrument more and more, not being tought at all, loving it to discover new chords and techniques myself and experimenting quite freely, e.g. throwing a microphone into the soundhole and playing through my brother’s tape recorder or trying out different tunings. At the age of 13 I started playing drums in various local Rock and Blues bands until I was 18.
I was drawn to music quite early in my life. My parents told me later that as a young kid of five or so I loved to sing in the large staircase of our house because it sounded really good there with all the natural reverberation. When I was about 10 years old I discovered an old acoustic guitar which had been played by my mother occasionally in former years. At the time I discovered it the Beatles were the big thing and my brothers and sisters brought this music to our house – I was immediately fascinated by it. So the first song I tried on this guitar was “I Need You” by George Harrison. My sister’s boyfriend showed me some chords. During the following years I explored this instrument more and more, not being tought at all, loving it to discover new chords and techniques myself and experimenting quite freely, e.g. throwing a microphone into the soundhole and playing through my brother’s tape recorder or trying out different tunings. At the age of 13 I started playing drums in various local Rock and Blues bands until I was 18.