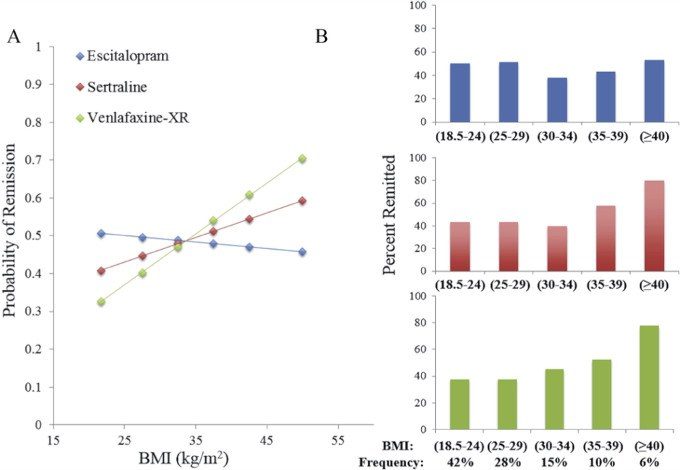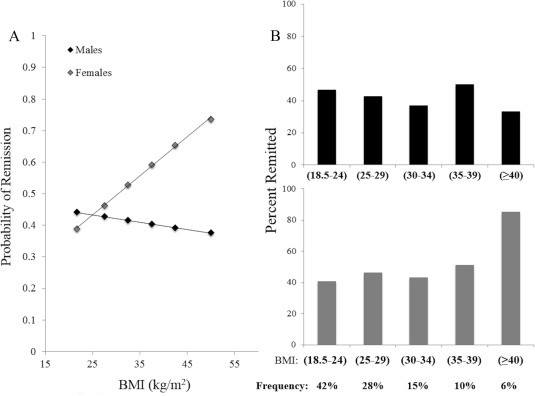Digital Detox: nudging e uso consapevole dello smartphone
L’incremento nell’utilizzo dello smartphone appare una reazione fisiologica al progresso tecnologico ma al contempo sembra comportare un peggioramento della nostra salute, talvolta compromettendo anche gli equilibri biologici del nostro organismo.
La scelta è chiara: o non facciamo nulla e permettiamo che un futuro deprimente e probabilmente catastrofico abbia il sopravvento su di noi, o utilizziamo la nostra conoscenza sul comportamento umano per creare un ambiente sociale nel quale vivere una vita produttiva e creativa e dobbiamo farlo senza mettere in pericolo le opportunità di coloro che ci seguiranno di poter fare lo stesso (B.F Skinner)
Se dovessimo chiedere ad adolescenti, ragazzi universitari o adulti quanto tempo dedicano quotidianamente a utilizzare i loro dispositivi digitali (smartphone, tablet o pc) risponderebbero: “poco, abbastanza, molto” senza avere una reale percezione del tempo effettivamente trascorso. Un analista del comportamento potrebbe consigliar loro di conteggiare il tempo di utilizzo di tali dispositivi, per scoprire che su sedici ore di veglia almeno sei sono mediamente dedicate al mondo digitale. Se le moltiplichiamo per tutti i giorni di una settimana, diventa facile farsi un’idea della rilevanza del fenomeno e di quanto la tematica delle dipendenze digitali sia degna di attenzione.
Secondo le indagini condotte da Flurry (USA), società impegnata nelle ricerche di mercato globale, in media ciascun utente utilizza lo smartphone 2 ore e 38 minuti ogni giorno per controllare messaggi, partecipare alle attività dei social network o giochi online. Gli utenti che utilizzano lo smartphone, in media, appaiono online più di 80 volte al giorno, questo vuol dire che essi utilizzano il proprio dispositivo mobile circa ogni 12 minuti.
Prendendo in considerazione le informazioni riportate dal sito “we are social”, il quale si occupa di raccogliere i dati relativi all’utilizzo dei canali social, dei dispositivi mobili e di tutto ciò che riguarda il mondo digitale a livello globale e dei singoli mercati, è possibile osservare un incremento di più del 10% nell’utilizzo dei dispositivi digitali nell’ultimo anno in Italia. I dati mostrano molto chiaramente, come si tenda per altro a usare sempre meno il pc, e sempre di più lo smartphone per visitare le pagine web. Facebook risulta essere il canale social più utilizzato (più di 1.5 miliardo di utenti attivi nel mondo), ma è in enorme crescita l’utilizzo di servizi di messaggistica istantanea quali Whatsapp Facebook Messanger, Snapchat, ecc.
Tale tendenza a essere sempre più “social” ci porta a riflettere sugli effetti positivi e negativi che il digitale ha apportato nella vita quotidiana. Come afferma il ricercatore della Microsoft, Nancy Baym, se da un lato gli smartphone hanno reso la comunicazione più veloce, avvicinato le persone ai loro amici e ridotto l’impiego di energie precedentemente investite dall’uomo nel processo di comunicazione, dall’altro, studi recenti fanno riflettere notevolmente sulle ripercussioni negative che essi hanno introdotto a livello biologico e psicologico. Gli smartphone hanno portato l’uomo gradualmente a sentirsi intrappolato, come al guinzaglio, con il costante obbligo di essere sempre disponibile e comunicare il proprio status, ovunque egli sia (Choliz, 2010).
Osservando i criteri del Manuale Diagnostico e statistico dei disturbi mentali, attualmente più che di crescita digitale, è possibile parlare di disturbo da abuso della rete telematica, l’Internet Addiction Disorder (IAD). Si può parlare di dipendenza quando la maggior parte del tempo e delle energie vengono spesi nell’utilizzo della rete, con importanti ripercussioni sulle principali aree esistenziali, come quella personale, relazionale, scolastica, familiare, affettiva (DSM V, APA 2014).
I classici sintomi di dipendenza digitale sono: preoccupazione elevata verso il dispositivo in termini di localizzazione e di notizie presenti su di esso, uso eccessivo con conseguente perdita di controllo, utilizzo del mobile in situazioni socialmente inappropriate ed effetti negativi sulle relazioni, ansia di stato se i social non sono funzionanti o non si ottiene risposta dal ricevente, emissione di comportamenti ripetuti e compulsivi nel toccare il touch screen (Guades E.,2016). La società di ricerca di mercato Braun Research, nello studio condotto per la Bank of America (2016) attraverso un sondaggio telefonico su 1004 persone di almeno 18 anni di età, ha riscontrato che il 59% dei consumatori possiede uno smartphone. Le persone controllano compulsivamente i loro dispositivi mobili per paura di perdere un “aggiornamento sociale” o come fonte di autosoddisfazione e tale comportamento non è circoscritto a un contesto specifico.
L’utilizzo dello smartphone è presente in attività quali mangiare, partecipare alle riunioni, attraversare la strada, guidare, dormire, ecc. Il 70% della popolazione controlla il proprio cellulare prima di andare a letto e al risveglio. Il 32%, ammette di controllare il proprio dispositivo se si sveglia durante la notte. Il 61% lo usa anche in bagno e il 9% di loro riferisce di averlo fatto cadere almeno una volta nella toilette. I dati riportati dal sito B2C mostrano che il 35% della popolazione statunitense utilizza lo smartphone mentre gioca con i propri figli, il 36% mentre usufruisce dei trasporti pubblici, il 37% mentre è a una festa e il 36% mentre è al ristorante o durante momenti di aggregazione.
Secondo l’ISTAT (2013), nel contesto italiano 81 persone su 100 della popolazione comprese tra i 16 ed i 24 anni utilizzano internet tutti i giorni, o quasi tutti i giorni. Di questa fascia: l’84,9% partecipa ai social network, il 76,1% invia messaggi su chat, blog, forum e altri siti affini, il 74,2% spedisce o riceve email e il 70,5% consulta wiki. Mentre, le restanti attività, come telefonate in rete, videochiamate, partecipazione a siti politici sensibili a temi sociali o altro analogo, e partecipazione a votazioni o consultazioni hanno invece una minor frequenza percentuale (ISTAT, 2013).
L’incremento nell’utilizzo dello smartphone appare una reazione fisiologica al progresso tecnologico ma al contempo sembra comportare un peggioramento della nostra salute, talvolta compromettendo anche gli equilibri biologici del nostro organismo. Tra gli “effetti collaterali” emergono: depressione, deficit di attenzione, sintomi somatici, aggressività, compromissione della qualità del sonno (Lee et al., 2014; Thomèe et al., 2011; Ozguner et al., 2005; Elder, 2013; Lepp, 2014).
La tendenza a iper-utilizzare i dispositivi digitali ha inoltre preso piede nei momenti destinati all’aggregazione e all’interazione sociale, durante una cena al ristorante o un dopocena in un locale, riducendo considerevolmente le interazioni tra le persone presenti, l’impegno nella relazione e l’arricchimento personale (emotivo, affettivo, esperienziale) che ne deriverebbe (Greser, 2006). Coloro che non utilizzano lo smartphone nei luoghi pubblici o nei momenti di aggregazione, inoltre, risultano maggiormente empatici (Misra et. al., 2016). L’utilizzo del motore di ricerca “Google”, consultato per qualsiasi quesito o perplessità conduce verso “conversazioni killer” in cui è assente l’interazione faccia a faccia e lo scambio di opinioni. Non sempre le informazioni inoltre sono vere, nel web è semplice imbattersi in informazioni distorte. Sulla base di tali considerazioni, sembra opportuno parlare di disintossicazione digitale come aiuto alle persone nel ridurre la frequenza di utilizzo del proprio smartphone. La disintossicazione dai dispositivi digitali è fondamentale per aprire gli occhi, conoscersi, dare il buon esempio, partecipare, proteggersi, ascoltare, gustare, condividere, giocare, evitare conversazioni killer, migliorare la postura e la qualità del sonno.
È importante in quest’ottica comprendere come l’utilizzo pervasivo e disfunzionale di tali dispositivi possa essere influenzato in maniera importante da fattori contestuali. Daniel Kahneman, psicologo Israeliano e Premio Nobel per l’Economia nel 2002, mette bene in luce nel suo lavoro come l’ambiente in cui ci si muove possa esercitare un’importante influenza sulle nostre scelte, che ne siamo consapevoli o meno (Kahneman, 2012).
Il meglio che si può fare è strutturare contesti che promuovano comportamenti funzionali per il benessere individuale e sociale. Il Nudge, tradotto in italiano come “spinta gentile”, ci viene incontro in tal senso. L’obiettivo di questo approccio è quello di indirizzare le persone verso scelte il meno possibile distorte da bias, ovvero errori sistematici ai quali la maggior parte degli individui è sensibile. A tal fine, l’utilizzo di un’accurata “architettura delle scelte”, ovvero un’impalcatura contestuale che favorisce l’emissione di comportamenti funzionali per il benessere dell’individuo, può essere utile per modulare alcuni comportamenti, senza l’utilizzo di incentivi economici o punizioni e senza precludere la libertà di scelta. (Thaler & Sunstein, 2009).
Nei mesi di Aprile e Maggio del 2016, osservando i comportamenti delle persone all’interno di contesti adibiti alla socializzazione, quali ristoranti e pub, il team di ricerca di Nudge Italia, ha sviluppato un intervento di nudging in due locali Milanesi con l’obiettivo di ridurre la frequenza di utilizzo degli smartphone tra i clienti dei locali che hanno ospitato l’iniziativa.
A tale fine sono state posizionate sui tavoli dei locali scatole di legno all’interno delle quali era possibile inserire i propri smartphone. All’esterno di ogni scatola sono stati inoltre applicati adesivi con la scritta “Sei davvero social? #posalo”, invitando i clienti a lasciare al loro interno i dispositivi digitali (vedi immagini). È stata dunque monitorata la frequenza di utilizzo degli smartphone prima e durante l’intervento. Nel corso dell’osservazione preliminare si è rilevato che il 25% dei clienti utilizzava il proprio smartphone, percentuale scesa al 15% durante la fase sperimentale.
L’ARTICOLO CONTINUA DOPO LE IMMAGINI



Le scatole in legno sui tavoli dei locali che hanno aderito all’iniziativa per ridurre l’uso dello smartphone
L’iniziativa ha fatto leva sull’effetto gregge, la tendenza a preferire l’appartenenza al gruppo e comportamenti coerenti a quelli dei propri simili, utilizzando il comportamento degli altri come metro di paragone su come sia appropriato o non appropriato agire (Sunstein, 2014). Infatti, l’intervento di nudge ha strutturato il contesto in modo che fosse in evidenza il comportamento sociale che si riteneva il “modello desiderabile”. La modificazione del contesto (presenza della scatola riponi smartphone sui tavoli) e la scelta di una persona seduta al tavolo di riporre all’interno della scatola il proprio smartphone, ha reso più probabile l’emissione quello stesso comportamento da parte degli altri membri della tavolata. Inoltre la presenza e la salienza della scritta con l’immagine del dispositivo ai lati della scatola ha permesso di rendere visibili e immediatamente accessibili le informazioni necessarie a orientare l’attenzione delle persone sedute ai tavoli verso una determinata opzione/informazione.
Adulti e nuove generazioni mostrano quindi di essere tecnologicamente sempre connessi perdendo contatto con la realtà circostante, come dimostrato dalla letteratura (Srivastava, 2005). Questo semplice esperimento ha dimostrato come piccoli interventi di modificazione intenzionale dei contesti di vita possano supportare un uso più consapevole dei propri dispositivi, funzionale a non impattare aspetti fondamentali per il benessere, come le interazioni e relazioni sociali, e a non incorrere in una dipendenza.