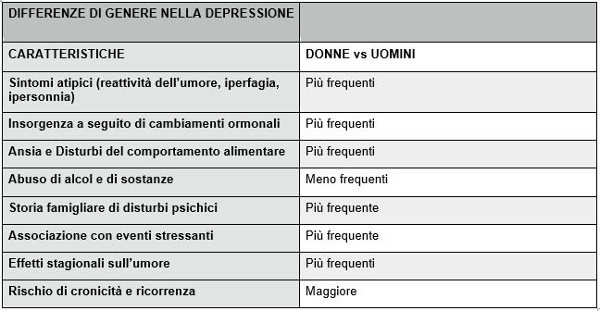Biglietto a/r destinazione: mamma – Alla scoperta dell’attaccamento e del comportamento materno tra le diverse specie animali
In questo articolo verranno illustrati gli aspetti neurochimici del comportamento materno: saranno analizzate le variazioni che la risposta materna ha subito nel corso dell’evoluzione, a partire dai mammiferi small-brained, nei quali il controllo neuroendocrino esercita un ruolo quasi esclusivo sul comportamento materno, fino ad arrivare ai mammiferi large-brained, nei quali si riscontra un coinvolgimento sempre maggiore della neocorteccia.
Valeria Fiocco – OPEN SCHOOL Studi Cognitivi Milano
Inoltre, il comportamento affiliativo fa parte di un elaborato sistema che prevede l’interazione tra diversi neuropeptidi, come dopamina, ossitocina e oppiacei endogeni. In particolare, il circuito del reward, mediato dalla dopamina, costituisce un sistema motivazionale aspecifico particolarmente importante che interagisce con un sistema motivazionale specifico per il comportamento materno, il quale a sua volta coinvolge regioni cerebrali e neurotrasmettitori specifici.
Il sistema di attaccamento materno
Nei mammiferi, la sopravvivenza della specie dipende dall’esteso repertorio di comportamenti sociali e parentali che inizialmente assicurano il soddisfacimento dei bisogni primari del neonato e successivamente ne plasmano il comportamento fornendo le prime esperienze sociali.
Per quanto riguarda nello specifico il genere umano, l’attuale psicologia dello sviluppo pone le sue radici nella teoria dell’ attaccamento di Bowlby (1969-1973), formulata a partire dallo studio delle associazioni tra la deprivazione materna e la delinquenza giovanile. Bowlby postula l’esistenza di un bisogno umano universale che consiste nella formazione di legami sociali, a partire dalla relazione con la madre o, in generale, con una figura di attaccamento. La sua prospettiva evoluzionistica ed etologica (che deriva, in un primo momento, dall’analisi degli studi di Darwin e dalla lettura degli scritti di Lorenz, oltre che dalla forte collaborazione con Hinde e, successivamente, dall’accesso all’opera di Tinbergen e ai costrutti neodarwiniani, che costituiscono la cornice entro cui interpretare la teoria di Bowlby) lo porta a sostenere che l’ attaccamento sia un sistema biologico innato che promuove la ricerca della prossimità con una figura di attaccamento specifica e che aumenta le probabilità del piccolo di sopravvivere e di riprodursi.
Le caratteristiche del legame di attaccamento con il caregiver determinano lo stile di attaccamento futuro del bambino: lo stile “sicuro” deriva da un caregiver disponibile, sensibile e responsivo rispetto ai bisogni fisici ed emotivi del bambino; al contrario, se gli interventi del caregiver sono caotici, imprevedibili o inadeguati, si sviluppa un attaccamento insicuro, che si declina in modo diverso a seconda del tipo di relazione tra la figura di attaccamento e il bambino (attaccamento insicuro/evitante, ansioso, disorganizzato).
Evoluzione del rapporto madre-figlio nei mammiferi non umani
Ruolo del sistema neuroendocrino nel comportamento materno dei mammiferi “small-brained”
Con l’evoluzione dei mammiferi, in particolare dei vivipari, tre processi acquisiscono un’importanza fondamentale: la formazione della placenta, lo sviluppo del feto all’interno dell’organismo materno e le cure fornite dopo il parto per assicurare la sopravvivenza del neonato fino al raggiungimento dell’età riproduttiva. Il genitore presente alla nascita, che investe tempo ed energia durante lo sviluppo in utero del feto e che è in grado di provvedere immediatamente dopo il parto al nutrimento attraverso la lattazione, è la madre: per questo motivo, tra il piccolo e il caregiver si instaura un legame sociale molto forte. In molte specie, le femmine non mostrano un comportamento materno spontaneo in assenza degli ormoni prodotti durante la gravidanza e il parto. Le cellule della placenta producono steroidi e altri ormoni che promuovono non solo lo sviluppo stesso della placenta, ma anche l’adattamento fisico, metabolico e comportamentale della futura madre. La risposta neuroendocrina ha il compito di sincronizzare la nascita con la produzione di latte e con il manifestarsi delle prime cure materne, che promuovono lo sviluppo di un legame sociale fondamentale per la sopravvivenza .
Tutte le relazioni sociali hanno tre aspetti in comune, anche se in percentuali diverse: la regolazione ormonale, il coinvolgimento dei meccanismi di reward e il riconoscimento sensoriale (Broad et al., 2006).
Il comportamento sociale di maschi e femmine riflette le diverse strategie che entrambi i sessi adottano per assicurarsi il successo riproduttivo: la coalizzazione tra soggetti di sesso maschile è tipicamente gerarchica e basata sull’aggressività piuttosto che sull’affiliazione. Le strategie riproduttive femminili sono completamente diverse: la maggior parte dei mammiferi “large-brained” è in grado di mettere al mondo un numero relativamente esiguo di piccoli, pertanto le madri investono molto su ognuno di loro e la loro sopravvivenza dipende dalla qualità delle cure fornite.
Le femmine instaurano, quindi, forti legami sociali con i propri piccoli e con altre femmine , che si basano sull’affiliazione e sulla collaborazione nell’assistenza verso la prole. Solo in una piccola minoranza di mammiferi (5%), l’ambiente rende svantaggiose le strategie maschili basate sulla promiscuità, pertanto il maschio è portato a legarsi in modo preferenziale ad una sola femmina, a difenderla dagli altri maschi e a partecipare alla cura dei piccoli (Broad et al., 2006).
La maggior parte dei mammiferi sono “small-brained”, avendo un maggior numero di strutture limbiche sottocorticali rispetto alle strutture corticali. La regolazione delle relazioni sociali richiede il riconoscimento degli stimoli olfattivi tra individui, soprattutto in corrispondenza di eventi di vita biologicamente rilevanti come l’accoppiamento e il parto. I cambiamenti ormonali che accompagnano questi stadi inducono variazioni nell’espressione di diversi neuropeptidi: fattori rilascianti la corticotropina (CRF), ossitocina (OT) e vasopressina (VP); questi sono importanti nella modulazione delle interazioni sociali, in particolare del comportamento materno.
L’ossitocina è un neuropeptide fondamentale che agisce a livello centrale promuovendo il maternal care e a livello periferico stimolando le contrazioni uterine durante il parto e la produzione di latte (Kendrick, 2000). Durante la tarda gravidanza, i recettori per OT sono regolati sia a livello cerebrale che in utero dagli elevati livelli di estrogeni presenti nel sangue. L’OT viene rilasciata nel cervello al momento del parto per facilitare il riconoscimento olfattivo del piccolo e il manifestarsi del
comportamento materno, che si mantiene durante il periodo dell’allattamento attraverso l’azione coordinata di OT, prolattina e dopamina (Broad et al., 2006).
L’OT prodotta durante altri eventi di vita biologicamente rilevanti (ad esempio, durante il periodo dell’accoppiamento) mantiene la funzione di facilitare le interazioni sociali e di creare delle memorie olfattive che permettono il riconoscimento dei conspecifici (Dluzen et al., 2000; Ferguson et al., 2000-2001; Winslow and Insel, 2002). L’ossitocina ha un ruolo importante anche nel superamento della paura nei confronti degli stimoli nuovi e nel controllo dei livelli di ansia (Mantella et al., 2003; Amico et al., 2004).
Sia la gravidanza che l’estro promuovono, attraverso le variazioni ormonali che le caratterizzano, la sintesi di OT e degli stessi recettori OT. Gli estrogeni hanno due tipi di recettori, ERalfa e ERbeta. I recettori ERbeta sono presenti nei neuroni ipotalamici che sintetizzano OT, mentre i recettori ERalfa sono richiesti per la sintesi dei recettori OT nell’amigdala (Patisaul et al., 2003). I topi knockout per entrambi i recettori ER mostrano gravi difficoltà nei test di riconoscimento sociale, come i topi knockout per il gene che codifica per OT (Choleris et al., 2003, 2004). Quindi, durante la gravidanza, il cervello materno subisce una radicale riorganizzazione rispetto alla sintesi di ossitocina e all’attivazione dei recettori ossitonergici; le aree cerebrali coinvolte in questa riorganizzazione sono quelle associate al riconoscimento sociale: il bulbo olfattivo, ricco di recettori OT è coinvolto nella formazione di memorie olfattive, l’amigdala (AMY) e il nucleo accumbes (NA) (Choleris et al., 2004; Kavalieris et al., 2004; Young and Wang, 2004). AMY e NA sono reciprocamente interconnesse; nel ratto entrambe mostrano un’attivazione significativa durante l’esposizione a stimoli olfattivi biologicamente rilevanti (Moncho-Bogani et al., 2005); il rilascio di OT e vasopressina (VP) nell’amigdala centrale provoca la risposta automatica di paura nei confronti di stimoli nuovi (Huber et al, 2005). Anche NA è ricco di recettori per OT: lesioni in quest’area compromettono il comportamento di retrieval e l’esperienza gratificante che normalmente deriva dall’interazione madre-figlio (Numan et al., 2005).
L’olfatto è, nei mammiferi small-brained, la più importante modalità sensoriale che coordina il comportamento sociale; gli stimoli olfattivi vengono processati da due sistemi: il sistema olfattivo accessorio e il sistema olfattivo principale. Il sistema accessorio contiene l’organo vomeronasale VNO, che riceve e invia i segnali olfattivi non volativi (ferormoni) direttamente verso l’ipotalamo e il sistema limbico. I ferormoni sono in grado di modificare l’assetto ormonale (ad esempio, inducendo l’estro) e di regolare il comportamento sessuale e il comportamento materno -genitoriale (Keverne, 2004).
Il sistema principale risponde ad un ampio range di odori, molti dei quali non hanno un intrinseco significato sociale: tuttavia, attraverso questo sistema, gli odori possono acquisire un significato sociale specifico se percepiti in contesti biologicamente rilevanti o legati al reward (Kippin et al., 2003). Ad esempio, durante il parto, gli stimoli olfattivi percepiti per mezzo del sistema principale diventano importanti segnali di riconoscimento della prole e quindi acquisiscono valore sociale (Broad et al., 2006). Il cervello conferisce significato agli stimoli olfattivi associandoli ad altre informazioni sensoriali che hanno un significato biologico intrinseco, in genere in contesti legati alla motivazione e al reward. Infatti, il circuito neuronale che traduce i ferormoni ha accesso al circuito mesolimbico, in particolare al NA, attraverso l’amigdala. Anche le proiezioni del sistema principale raggiungono l’amigdala passando dal bulbo olfattivo e dalla corteccia piriforme, che si connette alla corteccia frontale attraverso i nuclei medio-dorsali del talamo. Dalla corteccia frontale le proiezioni del sistema principale raggiungono, infine, il NA.
Ruolo della neocorteccia nel comportamento materno dei mammiferi “large brained”
Con l’espansione della corteccia, a partire dai primati non umani, si verifica un aumento della complessità delle relazioni sociali e una minore dipendenza dagli stimoli olfattivi nella comunicazione interpersonale. Si ha, inoltre, una parziale emancipazione del comportamento materno dall’influenza ormonale: il comportamento materno, infatti, si manifesta anche in assenza degli ormoni legati alla gravidanza e l’attività sessuale si presenta anche al di fuori del periodo fertile in quanto non ha più uno scopo unicamente riproduttivo. Gli imput olfattivi alle aree coinvolte nel reward vengono in parte sostituiti dagli imput alla neocorteccia, soprattutto per quanto riguarda gli stimoli sensoriali multimodali, la programmazione di azioni complesse e la regolazione delle emozioni (Schultz et al.,2000; Chiba et al., 2001). Lo sviluppo di nuove strategie comportamentali ha avuto un impatto significativo sull’evoluzione dell’organizzazione sociale.
Nei primati, gli ormoni della gravidanza, del parto e dell’allattamento non sono necessari per il manifestarsi del comportamento materno : risulta maggiormente importante, a questo scopo, il sistema degli oppiacei endogeni.
L’attivazione di questo sistema promuove l’emergere di sensazioni piacevoli durante l’allattamento e sopprime il dolore durante il parto. Il trattamento con Naloxone (oppiaceo-antagonista) nel periodo postpartum riduce il comportamento materno di caregiving: le madri sono maggiormente predisposte al neglect infantile, mostrano minori comportamenti di retrieval e di pup-grooming e, pur non rifiutandosi di allattare, lasciano che sia il piccolo a prendere l’iniziativa in ogni situazione; inoltre, la protezione e la possessività nei confronti del proprio piccolo vengono meno. Lo stesso si verifica nelle madri che fanno regolarmente uso di eroina, la quale agisce sugli stessi recettori oppiacei determinando gravi conseguenze sullo sviluppo dell’attaccamento materno. Il sistema oppiaceo endogeno nei primati large brained agisce anche sui recettori localizzati nello striato ventrale (Broad et al., 2006).
Il sistema olfattivo nei primati non ha più un ruolo esclusivo nella regolazione del comportamento sociale, soprattutto il sistema vomeronasale. Lo stile di vita prevalentemente diurno, al contrario di molte specie small-brained notturne, porta ad attribuire maggiore importanza agli stimoli visivi piuttosto che a quelli olfattivi; inoltre, i primati accudiscono la propria prole per molto più tempo rispetto alle altre specie, pertanto devono essere in grado, per riconoscere il proprio figlio, di registrare ogni cambiamento fisico e comportamentale nel corso del suo sviluppo.
Questo updating degli stimoli visivi coinvolge il circuito prefrontale-striato ventrale che è connesso all’amigdala, la quale media la risposta emozionale. In questo modo la corteccia visiva subisce una rapida espansione e le aree visive associative diventano più complesse; inoltre, emergono aree specializzate nella processazione di stimoli visivi particolari, come le espressioni facciali. Il circuito corteccia prefrontale-striato ventrale è parzialmente indipendente dalle modificazioni ormonali che intervengono durante la gravidanza: l’evoluzione ha fatto in modo che il controllo endocrino lasciasse spazio all’azione di importanti sistemi neuronali (OT , DA, oppiacei endogeni) nella determinazione del comportamento umano (Broad et al., 2006).
Questi sistemi spesso rendono l’individuo vulnerabile a varie forme psicopatologiche, come l’abuso di sostanze e il disturbo ossessivo compulsivo (DOC), nel quale sono coinvolte aree cerebrali come la corteccia orbitofrontale, il nucleo caudato, lo striato ventrale e il cingolo anteriore. Sappiamo, infatti, che il DOC è più comune nelle donne e che il periodo postpartum è un momento critico per l’insorgenza dei sintomi; lo stesso decorso della malattia è notevolmente influenzato dall’assetto ormonale (Broad et al., 2006).
Nei mammiferi large brained, la mPFC ha acquisito un’importanza fondamentale nella regolazione del comportamento sociale (Broad et al., 2006): le cortecce associative polimodali mandano informazioni alla mPFC, la quale proietta al cingolo anteriore, che è connesso allo striato ventrale. Se lo stimolo è rilevante dal punto di vista emotivo (ad esempio, il pianto del proprio figlio), si ha il rilascio di dopamina nello striato ventrale, mediato dall’interazione con i neuroni ossitonergici, il sistema oppiaceo endogeno e l’assetto ormonale. Winslow e colleghi nel 2003 hanno dimostrato che lo sviluppo della corteccia prefrontale risente degli stimoli sociali ricevuti durante i primi anni di vita: la deprivazione materna nelle scimmie riduce la secrezione di OT , aumenta l’aggressività e porta alla comparsa di comportamenti stereotipati: la compromissione delle funzioni della corteccia frontale risultano nell’incapacità di inibire risposte emotivo-comportamentali inadeguate.
Il controllo neurochimico sul comportamento materno umano
Ruolo dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene nel comportamento materno
Il periodo intorno alla nascita è accompagnato da adattamenti fisiologici e comportamentali del cervello materno che assicurano le funzioni riproduttive, le cure materne e la sopravvivenza del bambino. Inoltre, profondi cambiamenti neurobiologici sono stati descritti rispetto alla risposta allo stress dal punto di vista neuroendocrino e comportamentale nei roditori e nelle madri umane: la risposta ormonale dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene (HPA) e la risposta del sistema nervoso simpatico agli agenti stressanti fisici ed emozionali risultano notevolmente attenuate. In questo modo, il comportamento materno ansioso e la risposta emozionale agli stimoli stressanti sono ridotti e ne deriva uno stato generale di calma (Slattery and Neumann, 2008).
Questi complessi adattamenti del cervello materno sembrano essere la conseguenza di una aumentata attività dei sistemi neurali che hanno effetti inibitori sull’asse HPA, come il sistema ossitonergico e il sistema della prolattina, e di una minore attività dei circuiti eccitatori mediati dalla noradrenalina, dai fattori rilascianti la corticotropina (CRH) e dagli oppiacei endogeni. La manipolazione sperimentale di questi sistemi usando approcci complementari dimostra la loro importanza per quanto riguarda gli adattamenti del cervello materno che si osservano durante la gravidanza. Tali adattamenti non solo sono importanti per uno sviluppo prenatale sano del bambino prevenendo un eccessivo rilascio di glucocorticoidi e nel promuovere il comportamento materno dopo il parto, ma sono anche fondamentali per il benessere materno e per la sua salute psicofisica (Slattery and Neumann, 2008).
Tutti i mammiferi mostrano cambiamenti fisiologici e comportamentali durante la gravidanza allo scopo di preparare la madre al parto. In particolare, si osservano profonde alterazioni durante la gravidanza e l’allattamento rispetto allo stile di coping nei confronti degli eventi stressanti, con una riduzione significativa dell’attività dell’asse HPA (Stern et al., 1973; Neumann et al., 1998b; Russel et al., 1999; Lightman et al., 2001; Kammerer et al., 2002; de Weerth and Buitelaar, 2005).
L’asse ipotalamo-ipofisi-surrene (HPA) è primariamente coinvolto nella risposta dell’organismo allo stress. Attraverso l’azione coordinata di ipotalamo, ipofisi e ghiandola surrenale, l’asse HPA attiva e organizza la risposta agli stimoli stressanti ricevendo e interpretando informazioni che provengono da altre aree cerebrali, come amigdala e ippocampo, e dal SNA (Holsboer, 2001). La cascata ormonale ha inizio in risposta allo stimolo stressante con il rilascio di CRH da parte dell’ipotalamo, che stimola il rilascio di ACTH (ormone adrenocorticotropo) da parte dell’ipofisi. ACTH, a sua volta, stimola la produzione dei glucocorticoidi, i quali, una volta immessi nel circolo sanguigno, agiscono attraverso un feedback retroattivo a livello dell’ipotalamo, dell’ipofisi e dell’ippocampo, bloccando la risposta nei confronti dello stimolo stressante.
L’asse HPA è quindi responsabile di un meccanismo adattivo che mira a mantenere l’omeostasi dell’organismo anche a fronte di eventi stressanti (Shea et al., 2004). Nonostante queste risposte abbiano un’importante funzione protettiva nelle situazioni stressanti acute, vedremo come possano risultare dannose se gli ormoni vengono prodotti in quantità troppo elevate o per un periodo di tempo eccessivamente lungo (McEwen, 2002). Negli umani il cortisolo è il principale glucocorticoide che regola l’attività dell’asse HPA; esso agisce attraverso un feedback negativo inibendo il rilascio di CRH e ACTH.
Diversi sistemi neurali giocano un ruolo importante nel modulare l’attività dell’asse HPA attraverso input inibitori o eccitatori:
- I neuroni ossitonergici rispondono agli agenti stressanti con un elevato rilascio di OT da parte della neuroipofisi nel circolo sanguigno (Neumann et al., 1993a, 1995, 1998a; Douglas et al., 1998; Wotjak et al., 1998; Neumann, 2002; Landgraf and Neumann, 2004) e, localmente, a livello dell’ipotalamo (Wigger and Neumann, 2002; Bosch et al., 2004) e dell’amigdala (Bosch et al., 2004, 2005); Gli effetti di OT dipendono dalla regione cerebrale in cui OT agisce (PVN, amigdala o regione del setto) e in base alla condizione sperimentale (Numann et al., 2001). L’infusione di OT nel cervello di femmine di ratto vergini attenua la risposta neuroendocrina allo stress (Windle et al., 2004); tuttavia, è stato osservato che il blocco dei recettori OT nelle femmine in gravidanza non determina una disinibizione dell’asse HPA come accade nelle femmine vergini (Neumann et al., 2000b,c): probabilmente, esistono altri fattori inibitori , tra cui il sistema degli oppiacei endogeni e la prolattina, che insieme ad OT attenuano la risposta dell’asse HPA allo stress nel periodo intorno al parto.
- Si verifica un incremento dei livelli plasmatici di prolattina verso la fine della gravidanza (Grattan, 2001) e durante l’allattamento (Torner et al., 2004). PRL viene rilasciata localmente dai neuroni ipotalamici nelle femmine di ratto in lattazione in risposta alla suzione. La somministrazione continua di PRL attenua la risposta nei confronti di stimoli stressanti (Donner et al., 2007): PRL è quindi un fattore inibitorio importante dell’asse HPA durante l’allattamento (Torner et al., 2001).
- L’aumento della produzione di vasopressina (VP) a livello dei neuroni parvocellulari (Walker et al., 2001), accompagnata da un aumento della sensibilità degli stessi neuroni parvocellulari alla VP (Toufexis et al., 1999b) contribuisce a modificare l’attività basale dell’asse HPA durante l’allattamento: infatti, si osserva un aumento cronico del livello di corticosteroidi nel plasma durante la lattazione (Stern et al., 1973; Walker et al., 1995; Windle et al., 1997b). È stato dimostrato in diverse specie che la responsività dell’asse HPA ad un ampio range di stimoli fisici o psicologici risulta attenuata a partire dalla seconda metà della gravidanza fino alla fine del periodo dell’allattamento (Stern et al., 1973; Walker et al., 1995; Windle et al., 1997b; Neumann et al., 1998b; Shanks et al., 1999; Johnstone et al., 2000; Lightman et al., 2001; Neumann, 2001; Brunton and Russell, 2003).
- L’espressione dei fattori rilascianti la corticotropina (CRH) nel nucleo parvocellulare dell’ipotalamo è ridotta durante la gravidanza e l’allattamento, forse a causa degli elevati livelli di glucocorticoidi nel plasma che hanno un effetto inibitorio sull’espressione di CRH (Douglas and Russell, 1994; Johnstone et al., 2000; da Costa et al., 2001). La riduzione nell’espressione di CRH durante l’allattamento è stata descritta anche a livello dei nuclei centrali dell’amigdala, importanti non solo per la regolazione dell’asse HPA, ma anche per la processazione delle emozioni (Davis and Whalen, 2001). Se il sistema CRH è il maggior sistema eccitatorio dell’asse HPA, una sua minore attività contribuisce ad attenuare la produzione di ACTH e corticosterone, come avviene durante la gravidanza e l’allattamento. Quindi, una riduzione dell’attività del sistema CRH è associata a determinate modificazioni comportamentali che includono una riduzione dell’ansia (Hard and Hansen, 1985; Windle et al., 1997b; Toufexis et al., 1998; Neumann, 2003) e un aumento dei comportamenti tipicamente materni, come l’aggressività volta a proteggere la prole (Pedersen et al., 1991; Gammie et al., 2004).
- L’azione eccitatoria sull’asse HPA risulta notevolmente ridotta: la noradrenalina a livello centrale agisce come neurotrasmettitore e durante la gravidanza i nuclei PVN dell’ipotalamo risultano meno sensibili alla sua azione (Toufexis et al., 1998; Douglas et al., 2005). È stata rilevata una minore espressione dei recettori adrenergici e noradrenergici nei nuclei magno e parvocellulari dell’ipotalamo del ratto durante la gravidanza (Douglas et al., 2005).
- Un altro input eccitatorio sull’asse HPA attenuato in gravidanza è il sistema degli oppiacei endogeni (Douglas et al., 1998; Kammerer et al., 2002; Kofman, 2002). Al contrario, gli effetti degli oppiacei endogeni appaiono ribaltati durante il parto, quando inibiscono, invece che stimolare, l’asse HPA (Wigger et al., 1999). Inoltre, l’azione degli oppiacei endogeni sui neuroni OT a livello dei nuclei PVN ipotalamici è diversa nelle femmine di ratto vergini e nelle femmine gravide (Douglas et al., 1995; Wigger and Neumann, 2002). Gli effetti inibitori degli oppiacei endogeni sul rilascio intra-PVN di OT nelle femmine vergini e gli effetti eccitatori che invece si osservano nelle femmine gravide sono interessanti nel contesto dei meccanismi che regolano l’adattamento della risposta allo stress durante la gravidanza e l’allattamento.
Negli umani, in accordo con i risultati ottenuti dagli studi animali, si osserva un’attenuazione della risposta allo stress da parte dell’asse HPA nelle donne in gravidanza e durante il periodo dell’allattamento (Nisell et al., 1985; Sculte et al., 1990; Altemus et al., 1995; Kammerer et al., 2002); di conseguenza, si verifica un aumento dello stato di calma e del tono dell’umore positivo e una riduzione della risposta emotiva agli eventi di vita stressanti (Carter et al., 2002; Heinrichs et al., 2001; Glynn et al., 2004). Questi cambiamenti, che avranno un notevole impatto sul comportamento materno, possono essere ricondotti ad una minore attività del sistema CRH; inoltre, Heinrichs e collaboratori nel 2001 hanno dimostrato che l’attivazione del sistema OT e PRL contribuisce alla riduzione della risposta dell’asse HPA allo stress e al mantenimento del tono dell’umore positivo.
Riassumendo, la riduzione della risposta allo stress osservata durante la gravidanza e l’allattamento può essere in parte spiegata dall’aumentata attività del sistema OT e dalla maggiore produzione di PRL (Slattery and Neumann, 2008). Avendo un ruolo neuromodulatorio a livello centrale, OT e PRL esercitano un effetto significativo sul comportamento materno (Pedersen and Prange, 1979; Neumann and Landgraf, 1989; Neumann et al., 1993b, 1994 a,b; Bridges et al., 2001; Torner et al., 2002); ad esempio, è stato dimostrato che OT e PRL hanno importanti proprietà ansiolitiche, soprattutto durante la gravidanza e il periodo postpartum (Neumann et al., 2000b; Torner et al., 2002). È possibile osservare gli effetti ansiolitici di OT attraverso l’infusione diretta a livello di amigdala (Bale et al., 2001) e PVN: il rilascio di OT a livello di queste aree risulta inversamente correlato al livello di aggressività materna che si osserva nelle femmine in lattazione (Bosch et al., 2005).
Implicazioni dei sistemi ossitonergico, serotoninergico e dopaminergico nell’attaccamento materno umano
Abbiamo visto che il comportamento affiliativo fa parte di un elaborato sistema che prevede l’interazione tra i meccanismi implicati nel reward, i sistemi motivazionali, i sistemi emozionali e la reattività dell’organismo allo stress. Questo sistema complesso implica l’interazione tra diversi neurotrasmettitori, come dopamina (DA), ossitocina (OT) e oppiacei endogeni, oltre ad un notevole controllo ormonale.
Il paragrafo precedente ha messo in luce il ruolo fondamentale che il sistema ossitonergico riveste nel
comportamento materno umano: il rilascio di OT periferica aumenta durante e dopo il parto e anche durante l’esposizione a stimoli uditivi e visivi legati al proprio figlio; infatti, il sistema ossitonergico è importante nella formazione delle memorie sociali, nel comportamento affiliativo e nella regolazione delle
emozioni (Ferguson, Young and Insel, 2002). Le aree cerebrali coinvolte nel
comportamento materno e sociale, come i nuclei ipotalamici paraventricolari, l’amigdala, VTA, BNST e la regione del setto sono ricche di recettori per l’ossitocina.
A sua volta, il sistema serotoninergico è importante in quanto modula il tono dell’umore e il rilascio stesso di ossitocina. Nello studio di Bakermans e collaboratori del 2008 si valuta il ruolo dei geni che regolano i recettori ossitonergici (OXTR) e serotoninergici (5-HTT) in madri di bambini a rischio di esternalizzare problemi comportamentali, tenendo conto del livello scolastico materno, di eventuali episodi depressivi e della qualità della relazione con il partner. I risultati indicano che i genitori con una variante meno efficiente di questi geni mostrano bassi livelli di responsività e di sensibilità nei confronti dei propri figli.
La dopamina modula direttamente il sistema ossitonergico e ha un ruolo importante nella formazione dei legami sociali (Young, Murphy and Hammock, 2005). È il neurotrasmettitore principale coinvolto nei circuiti del reward e una sua regolazione disfunzionale può interferire in modo significativo con il comportamento materno e la formazione del legame madre-figlio. Pensiamo alle madri che fanno regolarmente uso di cocaina: il sistema ossitonergico risente particolarmente dell’esposizione a questa sostanza (Johns et al., 2005) in quanto essa agisce negativamente sul sistema mesocorticolimbico.
A fronte dell’importanza che i sistemi ossitonergico e dopaminergico rivestono nella formazione e nel mantenimento del legame di attaccamento umano, Strathearn e collaboratori nel 2009 hanno condotto uno studio particolarmente interessante che mette in relazione lo stile di attaccamento adulto con l’attivazione di determinate aree cerebrali in risposta ai cues infantili. Lo studio esamina trenta donne primipare, sottoposte durante la gravidanza all’Adult Attachment Interview, un questionario creato da Mary Main per determinare differenze negli stili di attaccamento adulto; circa sette mesi dopo il parto le madri osservano in fMRI alcuni videoclips che riproducono il volto triste o sorridente dei loro figli; inoltre, viene rilevata la produzione di ossitocina periferica in risposta al volto infantile mentre le madri interagiscono fisicamente con il proprio figlio.
I risultati mostrano che le madri con un attaccamento di tipo sicuro hanno un’attivazione maggiore della via mesocorticolimbica nel vedere il viso sorridente del proprio figlio; in particolare, si attivano lo striato ventrale e la corteccia prefrontale mediale. Anche in risposta al volto triste del proprio figlio si attiva lo striato ventrale destro.
Questi dati suggeriscono che qualsiasi cues infantile, sia positivo che negativo, ha una funzione di rinforzo e di motivazione per il comportamento materno di care-taking e quindi attivano il circuito responsabile del reward in modo specifico per l’attaccamento materno. Inoltre, le stesse madri mostrano un aumento della produzione di ossitocina a livello periferico mentre interagiscono con il proprio figlio, che implica l’attivazione a livello centrale del sistema ossitonergico (ipotalamo-ipofisi/striato ventrale) e dopaminergico. Le madri con uno stile di attaccamento insicuro/evitante mostrano, invece, una minore attivazione dello striato ventrale in risposta al volto sorridente; inoltre, si rileva l’attivazione dell’insula anteriore, associata alle emozioni negative, e della corteccia prefrontale dorsolaterale, che indica un controllo cognitivo sugli stimoli emozionali, in risposta al volto triste del proprio figlio. Questi dati concordano con il “modello dell’organizzazione corticale del sistema di attaccamento” di Strathearn (2006) e Crittenden (2008), in base al quale gli individui con un attaccamento insicuro/evitante tendono a inibire le risposte affettive negative a causa di un bias a livello della processazione delle informazioni cognitive dello stimolo.
Abbiamo visto che l’attivazione dello striato è inversamente correlata ai punteggi elevati di attaccamento insicuro; anche la produzione di ossitocina periferica è minore rispetto alle madri con attaccamento sicuro. Studi recenti mostrano una riduzione della risposta ossitonergica periferica nelle madri esposte al consumo di cocaina e nelle donne gravide con bassi livelli di attaccamento nei confronti del feto. L’aumento della produzione di ossitocina nelle madri sicure si associa all’esperienza gratificante che deriva dagli stimoli infantili e contribuisce ad incrementare l’abilità materna nel prendersi cura del proprio figlio. Le differenze individuali nello stile di attaccamento adulto possono quindi essere ricondotte al funzionamento dei sistemi ossitonergico e dopaminergico: questa correlazione può essere utile per comprendere meglio come lo stile di attaccamento materno, sicuro o insicuro, influisce sullo sviluppo del bambino e sul suo stile di attaccamento adulto, mettendo in luce i meccanismi che regolano la trasmissione intergenerazionale dell’attaccamento.
Una fondamentale componente emotiva del comportamento materno: l’empatia
La sensibilità e la responsività sono caratteristiche materne universali che garantiscono la sicurezza del bambino e il suo sviluppo socio-emotivo. La motivazione a prendersi cura del proprio figlio ha una forte base biologica: la prontezza a fornire cure, infatti, trova corrispondenza nell’anatomia e nella fisiologia della madre; il cervello femminile è programmato in modo tale da subire grandi cambiamenti durante la gravidanza: ad esempio, si rileva una maggiore attivazione a livello di specifiche aree cerebrali, come quelle appartenenti al sistema dei neuroni specchio, e ciò consente una migliore comprensione degli stati emotivi del figlio (Ellison, 2006).
Per studiare le basi biologiche dell’ attaccamento umano, l’attività cerebrale può essere misurata durante compiti che attivano il sistema dell’ attaccamento in soggetti adulti: questo è un approccio innovativo che valuta gli aspetti dell’attaccamento adulto in fMRI. Un esempio è lo studio pilota di Buchheim et al. (2006), in cui ad undici donne vengono presentati degli stimoli particolari (prevalentemente a valenza emotiva negativa) allo scopo di attivare il sistema dell’ attaccamento, dopo essere state classificate in base al loro stile di attaccamento adulto. I soggetti con un attaccamento sicuro mostrano una maggiore attività a livello dell’amigdala destra, dell’ippocampo sinistro e del giro frontale inferiore destro, aree che si ipotizza siano importanti nel sistema dell’ attaccamento. Recentemente alcuni ricercatori (Pelphrey, Morris, Michelich, Allison and McCarthy, 2005; Saxe, 2006b) stanno indagando le basi cerebrali del processo di “mentalization” (capacità di rappresentarsi lo stato mentale degli altri): queste ricerche innovative suggeriscono che regioni specifiche a livello della corteccia prefrontale mediale e della corteccia temporale mediano gli aspetti emotivi del comportamento, compreso il comportamento materno, come l’empatia.
Le basi neurobiologiche dell’empatia
L’empatia, definita come la capacità di percepire e rispondere in modo adeguato alle emozioni di un’altra persona, oltre alla capacità di comprenderle e di immedesimarsi con esse, è un aspetto fondamentale della relazione tra il bambino e il caregiver, soprattutto quando la comunicazione è totalmente o prevalentemente non verbale (Swain et al., 2007). Il network cerebrale che media le risposte empatiche si sovrappone al sistema dei neuroni mirror (Gallese, Keysers and Rizzolatti, 2004). Diversi studi condotti in ambito neuroscientifico mostrano che nel confronto con le emozioni espresse dai loro figli si attivano, nelle madri, i neuroni specchio in aree del cervello simili a quelle in cui si attivano i neuroni delle persone innamorate. Tale attivazione porta la madre a provare empatia per ciò che prova il figlio e le permette di intervenire con prontezza per proteggerlo (Leckmann and Mayes, 1999; Bartles and Zeki, 2004).
Due regioni primariamente coinvolte nella risposta empatica sono il cingolo e l’insula. In uno studio che si occupa di indagare la neuroanatomia dell’empatia usando la fMRI, Singer e collaboratori (2004) hanno misurato l’attività cerebrale in soggetti sottoposti a stimoli dolorosi ai quali viene successivamente detto che anche la persona amata sta vivendo la stessa esperienza; in questo modo hanno scoperto che regioni come il cingolo anteriore rostrale e l’insula anteriore si attivano in modo specifico se il soggetto immagina che sia la persona amata a provare dolore.
Il cingolo anteriore è coinvolto nella processazione dei cues emotivi che caratterizzano le proprie esperienze e quelle degli altri, nello spostamento dell’attenzione, nel decision making, nella rievocazione mnestica, nella regolazione del tono dell’umore e nell’organizzazione del comportamento volontario (Swain et al., 2007). Il cingolo anteriore, nell’esperimento di Singer e colleghi, sembra influenzare la dimensione affettiva del processo del dolore e gli aspetti motivazionali che orientano la selezione della risposta (C. Trentini, 2008).
Lo studio di L. Carr e collaboratori (2003) ha dimostrato che quando ai soggetti viene chiesto di osservare o imitare espressioni facciali corrispondenti a diverse categorie emozionali si rileva una maggiore attività a livello del solco temporale superiore (STS), nelle aree della corteccia premotoria in cui sono rappresentate le diverse configurazioni facciali e, soprattutto durante il compito imitativo, a livello dell’insula e dell’amigdala.
L’insula è un sito di integrazione delle informazioni emozionali ed è connessa alle aree che fanno parte del sistema mirror (corteccia parietale posteriore, frontale inferiore e temporale superiore). L’imitazione delle espressioni facciali delle emozioni produce una forte attivazione delle aree fronto-temporali che fanno parte del “mirror network” e che includono la “premotor face area”, la corteccia frontale inferiore e il solco temporale superiore. L’insula mette quindi in connessione la corteccia frontale e la corteccia temporale (aree deputate alla rappresentazione dell’azione, una componente cognitiva fondamentale per l’empatia) e le strutture profonde appartenenti al sistema limbico (coinvolte nella processazione emotiva). L’insula interviene nel tradurre le espressioni facciali nel loro significato affettivo, dando “colore emotivo” al processo cognitivo che permette la discriminazione delle emozioni altrui (C. Trentini, 2008).
Adolphs e collaboratori nel 2000 hanno dimostrato che un danno a livello della corteccia somatosensoriale destra, che include le aree somatosensoriali primarie e secondarie e l’insula, limita la capacità degli individui di identificare lo stato emotivo degli altri, a partire dall’osservazione della loro mimica facciale. Tali risultati avvalorano l’ipotesi in base alla quale il riconoscimento delle emozioni altrui richiede all’osservatore di ricostruire o simulare le immagini delle componenti somatiche e motorie normalmente associate all’esperienza soggettiva di quelle stesse emozioni.
Recentemente il gruppo di ricerca guidato da C. Trentini ha esplorato gli aspetti neurobiologici coinvolti nei processi empatici del comportamento materno durante il primo anno di vita del bambino. Sedici madri sono state sottoposte a fMRI durante la presentazione di immagini dei propri figli e di bambini sconosciuti della stessa età e dello stesso sesso, ritratti con diverse espressioni facciali (gioia, distress, neutralità, ambiguità). I compiti sperimentali prevedevano o l’imitazione delle espressioni facciali o l’ “osservazione/empatia”.
Durante la sessione di fMRI di “imitazione” sono state rilevate attivazioni significative nel circuito neuroni specchio – insula – sistema limbico, localizzate soprattutto a destra (corteccia premotoria ventrale destra, STS e amigdala bilaterale); in questo compito non sono state evidenziate differenze significative tra le attivazioni indotte dall’imitazione delle espressioni del proprio bambino e le attivazioni rilevate durante l’imitazione del bambino sconosciuto. Anche durante il compito “osservazione/empatia” sono state evidenziate attivazioni significative del circuito neuroni specchio – insula – sistema limbico, in particolare a livello del STS e, bilateralmente, nel lobo parietale inferiore e nell’amigdala. In particolare, quando alle madri è stato richiesto di empatizzare con le espressioni emotive dei propri bambini, sono state osservate attivazioni maggiori nel sistema dei neuroni specchio, bilateralmente, e nel giro frontale inferiore, nel lobo parietale inferiore, in STS e nell’insula anteriore prevalentemente a destra.
Le attivazioni evidenziate in questo studio riflettono il possibile substrato neurobiologico della capacità materna di recepire i segnali affettivi provenienti dal comportamento dei propri figli al fine di rispondervi in modo congruo. Queste competenze dipendono dalla capacità delle madri di riflettere sulle intenzioni, pensieri e stati affettivi del proprio figlio e queste abilità costitutive dell’empatia materna giocano un ruolo fondamentale soprattutto nel corso del primo anno di vita del bambino, quando non si sono ancora instaurate modalità comunicative più sofisticate, come il linguaggio (C. Trentini, 2008).