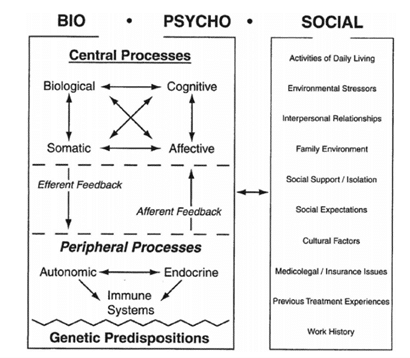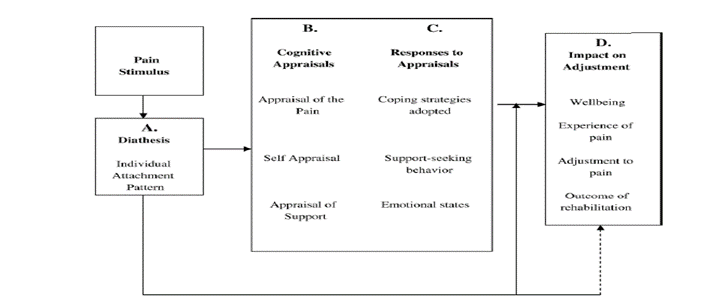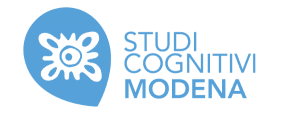Sex offender e psicopatologia
I Sex Offender sono coloro i quali commettono reati a sfondo sessuale contro qualsiasi essere umano, si tratti di uomini, donne o bambini.
Pastore Fabio, Di Gioia Concetta – OPEN SCHOOL Studi Cognitivi San Benedetto del Tronto
Sono identificati con l’articolo 609 bis del codice penale, il quale descrive le tipologie di reato che riguardano la violenza sessuale.
Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
- abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
- traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
I sex offender non costituiscono una tipologia omogenea di individui. ‘La vera caratteristica del sex offender è in primis una: la non uniformità‘ (Kröber, 2009). Le motivazioni sottese al reato, il tipo di comportamento sessuale agito, il modus operandi e l’età in cui viene commessa la prima aggressione sessuale possono essere molto diversi da un sex offender all’altro. Così come possono essere molto diverse le vittime oggetto, sia per l’età, sia per il sesso, sia per le loro caratteristiche fisiche, sia per il tipo di relazione che intrattengono con l’autore del reato.
Nell’ambito giuridico, i sex offender sono persone che commettono violenza sessuale su minori e/o stupro e quindi penalmente punibili. Dal punto di vista psicologico vi sono delle differenze dal momento che una persona potrebbe commettere un reato di violenza sessuale ma non possedere i criteri e le caratteristiche che rispecchiano questa categoria.
Svariati sono gli aspetti che influenzano lo sviluppo di un comportamento sessuale deviante, tra cui il contesto sociale, culturale, familiare, disturbi cognitivi e scarsa empatia. Questi fattori, accompagnati da esperienze traumatiche e dalla crescita in un contesto familiare dove la figura della donna è spesso una figura svalutata e dunque la figura maschile è ritenuta nettamente superiore rispetto alla donna, contribuiscono allo sviluppo del mancato controllo degli impulsi, ad un bisogno di dominio e all’aumento dei comportamenti violenti accompagnati da eccitazione sessuale.
Caratteristiche ricorrenti nei profili dei sex offender sono la presenza di una impellenza compulsiva (Kimmel & Plante, 2004) ad agire la propria sessualità abnorme (Small, 2004), senza alcuna preoccupazione per l’altro (Hickey, 2005), di elementi sessuali ritualizzati (Beauregard, Lussier & Proulx, 2005), di fantasie sessuali di potere e sopraffazione sulla vittima (Gee, Devilly & Ward, 2004; Howitt, 2004; Sheldon & Howitt, 2008), e di simbolismo, ovvero la tendenza ad attribuire connotazioni sessuali ad oggetti inanimati.
Una caratteristica che sembra essere presente nella maggior parte dei sex offender riguarda le limitate capacità empatiche. L’empatia è un costrutto composto da caratteristiche sia cognitive sia affettive e si riferisce alla capacità di un soggetto di comprendere i sentimenti e le cognizioni altrui. I soggetti con difficoltà empatiche non sono completamente in grado di discernere gli stati emozionali altrui; gli uomini che aggrediscono donne e/o bambini spesso considerano le loro vittime come diverse da loro e, quindi, hanno difficoltà ad assumere la loro prospettiva. (Petruccelli I., Pedata L.T.,2008).
Il sex offender presenta, inoltre, un pensiero basato su una specifica distorsione cognitiva utilizzata come strategia difensiva, come supporto a ciò che sta facendo in tal modo da commettere reati gravi mantenendo un’integra percezione di sé come persona non repellente. Tale distorsione cognitiva prende il nome di disimpegno morale. Esso è un meccanismo difensivo composto da un insieme di dispositivi cognitivi interni al soggetto appresi ed interiorizzati che portano il sex offender a liberarsi dai sentimenti di autocondanna, lesivi per il mantenimento del proprio equilibrio interiore.
P. E. Dietz suddivide i sex offender in:
- Tipo situazionale, il cui livello intellettivo è inferiore alla norma e il cui comportamento sessuale è mirato a soddisfare il bisogno sessuale di base e di potere attraverso rabbia intensa. Il comportamento è impulsivo, opportunista e considera in modo superficiale i rischi nel commettere e mettere in atto un comportamento sessuale criminale;
- Tipo preferenziale, il cui livello intellettivo è superiore rispetto al tipo situazionale, mette in atto dei comportamenti sessuali criminali che riguardano i bisogni sessuali devianti, le cosiddette parafilie. Il comportamento è spesso elaborato e compulsivo, e vanno a crearsi dei veri e propri rituali sessuali.
Dalla suddivisione proposta da Dietz, Hazelwood, Warren e Burgess hanno definito due tipologie di sex offender:
- Impulsivo, è un tipo di offender sessuale che di solito viene catturato con facilità a causa della sua scarsa pianificazione nel commettere i suoi crimini. È impulsivo e le fantasie di questa tipologia di sex offender sono semplici e concrete e solitamente includono due dimensioni: le caratteristiche della vittima e la percezione di Sé. L’apice del piacere sta nel catturare la donna e dominarla. La caratteristica che accomuna questi sex offender è la rabbia e l’odio che nutrono verso il genere femminile;
- Rituale, è meno diffuso ed è anche quello più difficile da catturare ed identificare. Investe grandi quantità di tempo nella pianificazione e nell’organizzazione del crimine con sopralluoghi, ecc. La motivazione sottostante riguarda il bisogno di potere. Frequentemente manifesta stili di vita che appaiono convenzionali e piuttosto ordinari.
Il comportamento del sex offender può essere inquadrato clinicamente se rientra tra i Disturbi Parafilici elencati del DSM 5. Il termine parafilia, all’interno del DSM 5, indica un:
qualsiasi intenso e persistente interesse sessuale diverso dall’interesse sessuale per la stimolazione genitale o i preliminari sessuali con partner umani fenotipicamente normali, fisicamente maturi e consenzienti (APA, 2014).
Affinché sia possibile effettuare una diagnosi di Disturbo Parafilico è necessario che tale condotta parafilica sia causa di un intenso disagio o di una compromissione dell’individuo o rischi di arrecare danno a se stesso o a terze persone. Una condotta parafilica di per sé è una condizione necessaria ma non sufficiente per una diagnosi di Disturbo Parafilico in quanto può, a volte, non inficiare il benessere psicologico dell’individuo e non creare danno a se stesso o ad altre persone. Per alcuni sex offender le parafilie sono strumentali al raggiungimento della soddisfazione sessuale, per altri esse rivestono un ruolo marginale o nullo.
Tra i Disturbi Parafilici, descritti nel DSM 5, che possono caratterizzare i profili di alcuni sex offender, vi sono:
- Disturbo Pedofilico, in cui è presente eccitazione e piacere sessuale da fantasie o comportamenti relativi ad attività sessuali con bambini prepuberi;
- Disturbo Voyeuristico, in cui l’eccitazione sessuale deriva dall’osservazione furtiva di soggetti, spesso nudi, non di rado impegnati in attività sessuali;
- Disturbo Esibizionistico, in cui l’eccitazione sessuale deriva da desideri o comportamenti di esposizione dei propri genitali a persone a loro insaputa;
- Disturbo Frotteuristico, che si caratterizza per l’eccitazione data dal toccare o dallo strofinarsi con una persona non consenziente;
- Disturbo Feticistico, che si caratterizza per l’attenzione sessuale verso un oggetto inanimato o una parte specifica del corpo non genitale;
- Disturbo da Travestitismo, dove l’eccitazione sessuale deriva dal cross-dressing, ovvero l’azione di indossare indumenti del sesso opposto;
- Disturbo da Masochismo Sessuale, in cui l’eccitazione sessuale deriva dal sentirsi umiliato, percosso, legato e da altri atti inducenti dolore e sofferenza;
- Disturbo da Sadismo Sessuale, in cui l’eccitazione sessuale nasce dal causare deliberatamente e intenzionalmente sofferenza fisica o psicologica ad un’altra persona.
- Disturbo Parafilico con Altra Specificazione, in cui rientrano parafilie quali la scatologia telefonica, dove l’eccitazione sessuale scaturisce da telefonate oscene; la necrofilia, consistente nel piacere derivato dall’atto sessuale con cadaveri; la zoofilia, ossia la preferenza per atti sessuali con animali; la coprofilia, ove il piacere è dato dal contatto con escrementi; la clismafilia, nella quale il soggetto trae eccitazione sessuale dall’inserimento nel retto di clisteri o altri oggetti, ed infine la urofilia, dove la soddisfazione sessuale è legata al contatto con l’urina propria o del partner.
Nei sex offender a volte tali Disturbi Parafilici sembrano essere associati alla presenza di Disturbi di Personalità. Molteplici studi effettuati mostrano come ormai si è concordi nel ritenere che esista stretta correlazione tra il comportamento del sex offender e la propria appartenenza diagnostica a categorie rientranti in Disturbi di Personalità specifici. I Disturbi di Personalità più ricorrenti nei sex offender sono:
- Disturbo di Personalità Narcisistico, che presenta totale incapacità empatica e relazionale, senso di grandiosità e onnipotenza, volontà personale di agire a proprio vantaggio ai danni o svantaggio dell’altro, disinteresse verso la sfera emotiva e psicologica della vittima. Dunque, abbiamo la presenza di un’esagerata infondata sensazione della propria importanza, preoccupazione con fantasie di successi senza limiti;
- Disturbo di Personalità Antisociale, il quale manifesta un estremo disinteresse e/o non riconoscimento delle regole sociali, anche inerenti la sfera d’azione dell’etica e della morale, reinterpretate secondo criteri puramente soggetti che violino il principio del ‘socialmente accettabile’. Tale disturbo è già possibile individuarlo, ma non diagnosticarlo dal momento che è possibile effettuare la diagnosi solo dai 18 anni, intorno ai 15 anni con la diagnosi di disturbo della condotta dove il ragazzo assume un atteggiamento oppositivo-provocatorio, aggressivo, violento nei confronti degli altri senza alcun risentimento. Il punto cardine di tale disturbo è la totale mancanza di empatia e indifferenza verso sentimenti e preoccupazioni altrui e la completa assenza di senso di colpa;
- Disturbo di Personalità Borderline, prende forma con oscillazioni continue dell’umore, sbilanciamenti di rapido passaggio da azioni di calma apparente ad agiti aggressivi nel lasso di brevissimo tempo senza reale motivazione oggettiva, controllo contenuto improvvisamente esploso in azioni violente/aggressive incontrollate. Il disturbo di personalità borderline è un equilibrio tra nevrosi e psicosi ed i soggetti affetti (tale disturbo colpisce maggiormente il genere femminile) sono particolarmente attraenti e compiacenti;
In uno studio, Bogaerts e collaboratori (2005) dimostrarono una significativa presenza di disturbi di personalità come il disturbo schizoide, quello narcisistico e l’evitante nel loro campione di child molesters. In uno studio condotto su un campione di oltre 8000 sex offender, Sjostedt e collaboratori (2003) hanno indagato la presenza di vari disturbi psichiatrici maggiori, evidenziando la presenza di percentuali più elevate rispetto alla popolazione generale (schizofrenia: 1,5% vs 0,3%; disturbo bipolare: 0,3% vs 0,1%; altri disturbi psicotici: 2,5% vs 0,4%). Secondo Leue e collaboratori (2004), invece, solo alcuni disturbi dell’umore, d’ansia e alimentari sarebbero presenti in maniera significativa nei sex offender. Fra i disturbi d’ansia, diversi autori (Douglas, Burgess, Burgess & Ressler, 1992; Keppel, 1995; Howitt, 1995; Iwawaki & Wilson, 1983; Briere & Runtz, 1989; Langevin & Lang, 1985) segnalano la fobia sociale come quadro clinico particolarmente rappresentato, a denotare l’incapacità di tali soggetti a stabilire relazioni solide ed efficaci con gli altri. In uno studio condotto in U.S.A. da Cochrane e collaboratori (2001) è emerso come la popolazione di sex offender, rispetto ad altri tipi di ‘offender’, manifesti più frequentemente alcuni disturbi mentali (ritardo mentale: 11% vs 2%; parafilie: 25% vs 2%); meno frequentemente altri disturbi (disturbi dell’umore: 5% vs 20%; disturbi psicotici: 16% vs 32%) e sostanzialmente in egual misura altri ancora (disturbi di personalità: 42% vs 42%; abuso di sostanze: 42% vs 48%).
Secondo Skeem e Mulvey (2001) i disturbi da uso di alcol e sostanze, oltre che correlati al rischio di reiterazione di reati sessuali, aumenterebbero il rischio di recidiva per reati violenti (sessuali e non sessuali) e gli stessi autori ritengono che la presenza di personalità antisociale aumenti il rischio di recidivismo per i reati violenti, non solo sessuali ma anche non sessuali.
In definitiva, i dati sinteticamente riportati sembrano dimostrare come le dimensioni psicopatologiche strutturali della personalità e i disturbi da uso di sostanze siano effettivamente correlati ad un più alto rischio di reiterazione di condotte sessuali delittuose (ma anche di altri reati non a sfondo sessuale). Tuttavia questi ed altri vari studi mostrano uno scenario piuttosto eterogeneo nella descrizione/definizione dei profili psicopatologici dei sex offender. Tale eterogeneità non ha consentito finora di delimitare chiaramente i confini di eventuali patologie mentali coesistenti con specifici comportamenti sessuali anomali a volte delittuosi. La correlazione tra psicopatologia e comportamento sessuale illecito è una questione, dunque, che necessita di ulteriori ricerche.
In aiuto alla valutazione attraverso il colloquio clinico e l’utilizzo dei test psicodiagnostici come test di personalità, è utile effettuare una valutazione neuropsicologica. Un’attenta valutazione neuropsicologica, oltre che a fornire un quadro cognitivo completo permette di comprendere il funzionamento. La valutazione comprende 3 fasi:
- il colloquio clinico e la raccolta delle principali notizie anamnestiche;
- la valutazione cognitiva standardizzata;
- la valutazione emotiva e comportamentale dell’esaminato.
È importante che ogni percorso preveda un assessment del rendimento cognitivo generale. Tuttavia, proprio per la vastità delle classificazione dei sex offender, è difficile definire un profilo neuropsicologico specifico. La valutazione neuropsicologica di un sex offender deve essere completa e non può prescindere da una valutazione di tutti i domini cognitivi ed è per questo che si dovrà prestare attenzione, in modo particolare, all’analisi qualitativa e quantitativa di alcuni test specifici da scegliere come ad esempio un test per il QI, per le funzioni esecutive, per la fluenza verbale, per l’attenzione e la velocità nel cogliere e codificare le informazioni, per la valutazione del giudizio morale e, fondamentale, un testo per la componente impulsiva. Dunque, una valutazione neuropsicologica potrebbe aiutare ad identificare differenti aspetti e fattori a rischio associati alla violenza sessuale quali una inclinazione al crimine o la presenza di competenze sociali ridotte o, ancora, profili con un’elevata impulsività e con ridotte capacità verbali, ma è anche importante per individuare i soggetti con più elevato rischio di recidiva nel commettere reati o fatti.
Sul piano dell’intervento terapeutico, l’associazione congiunta tra psicoterapia e l’uso del farmaco risulta essere maggiormente efficace rispetto alla sola psicoterapia o al solo farmaco, anche se il percorso terapeutico per essere più incisivo dovrebbe durare per almeno tre o cinque anni (Rice & Harris, 2011).
I trattamenti farmacologici sembrano facilitare l’adesione ai programmi terapeutici e aumentano la possibilità di successo nel diminuire il tasso di recidiva. Fra i presidi farmacologici usati, quelli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRI) si sono dimostrati efficaci in particolar modo sugli aspetti compulsivi del comportamento sessuale (Kraus, Hill, Haberman, Strohm, Berner & Briken, 2006). Le sostanze ormonali, come i farmaci antiandrogeni (GnRH agonisti), stanno assumendo un ruolo crescente nel trattamento dei sex offender per prevenire il rischio della recidiva criminale.
I trattamenti psicoterapici ad orientamento cognitivo-comportamentale mirano a ridurre la recidiva dei sex offender agendo sulle distorsioni cognitive, sugli atteggiamenti, e sull’autoregolazione sessuale, affettiva, relazionale e cognitiva; mirano a far comprendere al sex offender i motivi ‘profondi’ del proprio comportamento sessuale e i bisogni a cui essi rispondono, e a riprogrammare il comportamento sessuale verso delle modalità più appropriate e socialmente adeguate. Al centro dei programmi di trattamento vi è un lavoro sui pensieri, idee, convinzioni errate sul mondo e su se stessi: il diritto al sesso, la visione ostile del mondo o la convinzione che i bambini non vengano turbati da attività sessuali sono le convinzioni più frequenti che mantengono il ricorso alla violenza sessuale.
Obiettivo del trattamento terapeutico è quello di insegnare al sex offender a riconoscere e rispettare le esigenze e i bisogni dell’altro grazie al recupero della dimensione empatica con la vittima (cfr. Kenworthy, Adams & Bilby, et al. 2004; Hanson, Bourgon, Helmus & Hodgson, 2009; Giulini & Xella, 2011). L’obiettivo fondamentale è il raggiungimento di un cambiamento duraturo dell’assetto cognitivo relativamente al comportamento sessuale, attraverso una ristrutturazione cognitiva e psico-educazionale delle abilità sociali.
Con i sex offender caratterizzati da marcati aspetti di antisocialità e psicopatia si riscontrano particolari difficoltà trattamentali, poiché mostrano forte resistenza al cambiamento e elevato tasso di recidiva nel reato.
Un elemento che si configura come basilare per il buon esito della psicoterapia è il terapeuta stesso, e la relazione che si instaura tra quest’ultimo e il sex offender. L’empatia, il rispetto, il calore e la sincerità, la confidenza e l’interesse verso il sex offender si sono dimostrati fondamentali per una buona riuscita del trattamento. Una relazione terapeuta-paziente proficua è inoltre caratterizzata dalla presenza di comportamenti autorevoli, ma anche dall’ascolto, dall’incoraggiamento e dalla capacità di contenere la frustrazione e l’aggressività del sex offender durante le sedute. La relazione terapeuta-paziente incide fortemente sull’esito della terapia e ne previene l’abbandono del percorso trattamentale.