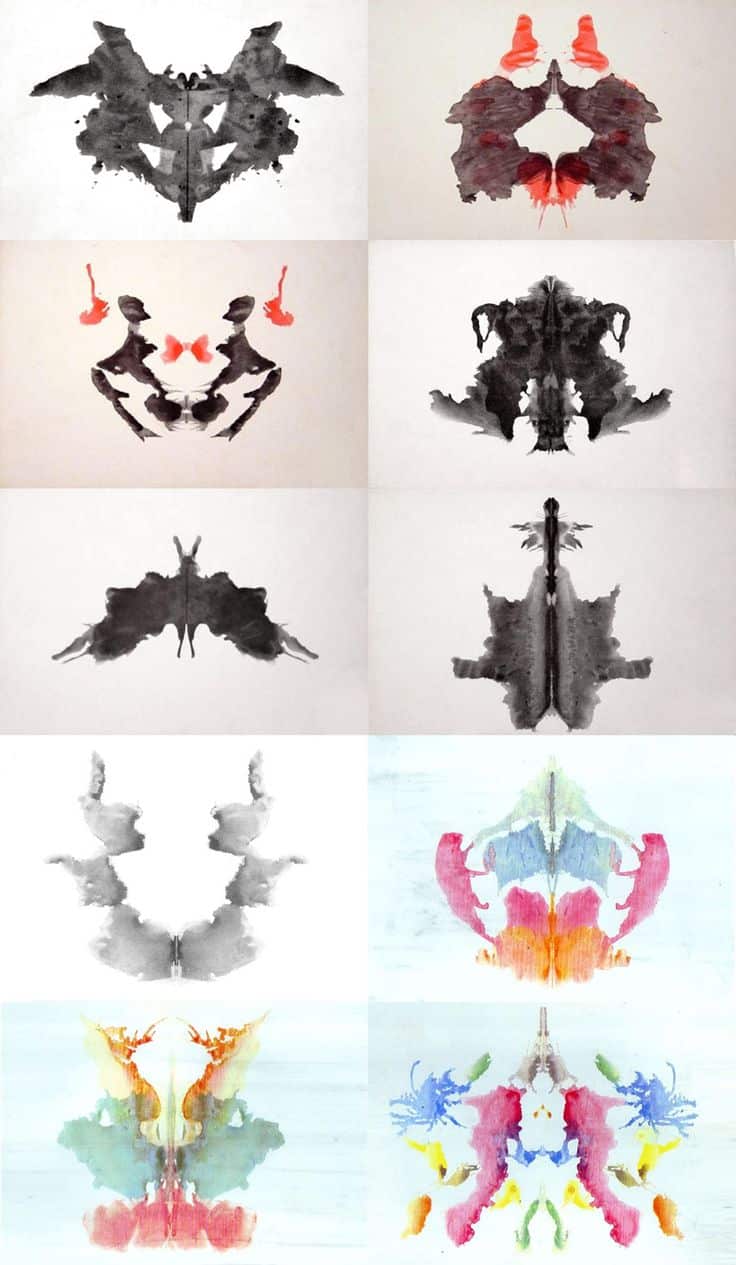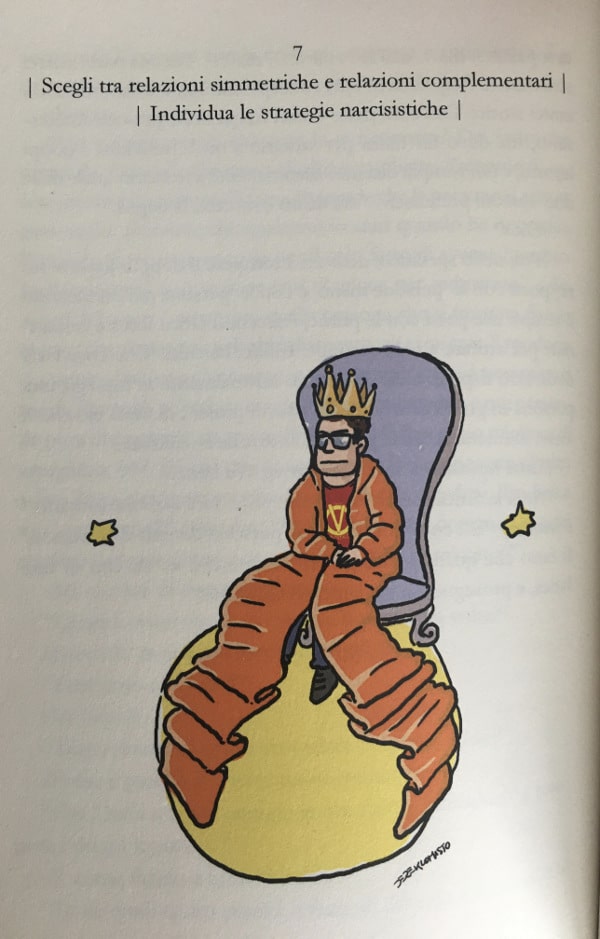Recharge in nature, recuperare il rapporto con la natura
Le evidenze scientifiche sull’impatto positivo della natura sull’uomo sono numerose, ed il progetto Recharge in Nature si è concentrato su alcune di esse.
Alberto Fistarollo – OPEN SCHOOL Psicoterapia Cognitiva e Ricerca Mestre
Recharge in Nature, il progetto
Recharge in Nature è un’iniziativa di Dolomites Maadness, un progetto di marketing con obiettivo di sviluppo locale e valorizzazione del territorio del Medio Alto Agordino finanziato dal Fondo Comuni Confinanti (Rocca Pietore, Alleghe, Colle Santa Lucia, Livinallongo del Col di Lana, Arabba, Cencenighe, San Tomaso Agordino, Taibon Agordino). Un modo per aiutare questi luoghi, duramente colpiti dalla tempesta Vaia dell’ottobre 2018, ad avere visibilità e ripartire, anche turisticamente.
Il progetto ha così ideato un concorso, nel quale dieci persone selezionate avrebbero vinto un soggiorno gratuito di 5 giorni (dal 13 al 17 settembre) nel Rifugio Falier di Val Ombretta, nel Comune di Rocca Pietore. Il risultato dell’iniziativa è andato oltre ogni aspettativa, superando le 19.000 iscrizioni da tutto il mondo.
Un’unica regola durante il soggiorno: l’impossibilità di utilizzare smartphone, computer, tablet. Una disconnessione totale dalla vita virtuale.
L’idea complessiva, al di là del piano di marketing, contiene anche un importante messaggio sociale: stando nella natura è possibile imparare a disconnettersi, rilassarsi, riprendere il controllo sulla tecnologia e utilizzarla con maggior consapevolezza. Un ritorno alla semplicità, fatta di ritmi più umani e relazioni reali; questo l’aspetto psico-sociale che ha permesso la mia partecipazione al progetto come psicologo.
Il rapporto uomo-natura
Il mio primo passo all’interno del progetto è stato quello di approfondire gli effetti della natura sull’uomo, in maniera da poter ispirarmi ai risultati di alcune ricerche per ottimizzare l’effetto del soggiorno sui partecipanti.
Il tema è attualmente molto vivace, anche in virtù del dibattito sulle questioni ambientalistiche, l’inquinamento e il riscaldamento globale; oltre alle discussioni sull’impatto dell’uomo sulla natura, recentemente viene molto indagato anche l’impatto della natura sull’uomo, principalmente in relazione allo stress.
L’argomento è particolarmente attuale nelle società caratterizzate da ambienti artificiali, ritmi frenetici, tendenza alla prestazione e alla produttività, pressioni sociali, uso sfrenato della tecnologia. Se un tempo si parlava comunemente di “esaurimento nervoso”, oggi la parola passepartout è stress.
Il termine viene comunemente utilizzato in modo da indurre a fraintendimenti: si usa affermare “il lavoro mi stressa”, “il traffico è stressante”, “il capo mi stressa”, come se lo stress fosse esclusivamente un fattore esterno di fronte al quale la persona è passiva. In realtà, i fattori esterni citati rappresentano stressors, ovvero potenziali fattori di stress, ai quali la persona però ha una capacità di reagire in maniera più o meno funzionale (da qui i concetti di eustress e distress); infatti Hans Seyle, il primo studioso che si occupò approfonditamente di stress nel lontano 1936, definì lo stress come una “Sindrome Generale di Adattamento”.
Lo stress dunque non è qualcosa di oggettivo e immodificabile, ma rappresenta la modalità individuale di reagire alle richieste ambientali. In sostanza, siamo soggetti attivi nella percezione dello stress e ciò significa che possiamo imparare a reagirvi in maniera più funzionale.
Un fattore importante dello stress odierno, che i nostri dieci partecipanti hanno riportato come il principale, è l’iperconnessione, la perenne presenza della vita online.
Mail, notifiche, chat, telefonate, è come se una parte di noi fosse continuamente in allerta ad attendere stimoli provenienti da… altrove. Il meccanismo di ricompensa legato alle notifiche, in particolare il rinforzo intermittente, crea di fatto un condizionamento molto potente che impedisce di concentrarsi su un’unica attività ignorando l’impulso a dare un’occhiata allo smartphone. Vita reale e vita online scorrono così in parallelo, rendendo davvero complesso stabilire delle priorità per la nostra attenzione.
Tutto ciò affatica il nostro cervello, comporta continue distrazioni e sottrae tempo e attenzione per il qui e ora. Ne risentono così le nostre relazioni, la qualità del sonno, l’efficacia sul lavoro, l’apprendimento, l’umore e la salute complessiva (per una rassegna sul tema si veda il riferimento Goleman, 2013).
Tali concetti sono risultati rilevanti per i partecipanti a RIN poiché uno degli obiettivi, oltre al rilassarsi e disconnettersi, era che riuscissero ad acquisire degli strumenti che li rendessero maggiormente resilienti rispetto allo stress della vita quotidiana.
Ad un livello puramente intuitivo, la natura viene considerata una sorta di antidoto nei confronti dello stress. E’ infatti esperienza comune che uscire dalle città per immergersi nel verde faccia sentire meglio; più rilassati, più calmi e di buon umore. Non è un caso che in vacanza si vada perlopiù in luoghi meno trasformati dall’uomo, che abbiano la natura come soggetto principale: mare, montagna, colline, lago e altri paesaggi naturali. Vari fattori contribuiscono a rendere l’ambiente naturale favorevole al benessere: il clima, il silenzio, i colori. Stando nella natura ci si rilassa, e pure la mente sembra farsi meno affollata. Effettivamente, molti personaggi illustri del passato (come Socrate, Kant, Rousseau, Ghoethe, Kafka) sottolineavano l’effetto benefico sulla mente del semplice passeggiare in mezzo alla natura, come se il verde avesse una sorta di potere calmante e chiarificatore sui nostri processi mentali.
Eppure, nonostante una certa consapevolezza di tali effetti, secondo un interessante ricerca dell’E.P.A. -Environmental Protection Agency- il tempo che trascorriamo all’aperto nel mondo occidentale rappresenta solamente il 5% delle nostre giornate (Environmental Protection Agency, 2011); una percentuale inferiore rispetto al tempo che un capodoglio passa in superficie per respirare!
Inoltre, uno studio ha stimato che le persone trascorrono circa il 25% di tempo in meno nella natura rispetto a vent’anni fa (Pergams & Zaradic, 2007).
Se stare nella natura comporta realmente dei benefici, è evidente che questo stile di vita impatta sulla nostra salute psico-fisica. In sostanza, la natura ci manca! Quest’ultima constatazione, che potrebbe apparire semplicistica, in realtà viene confermata da diverse ricerche che si sono occupate di indagare lo stato di salute psicofisica di chi vive in ambienti naturali e chi invece in grandi metropoli.
Le evidenze scientifiche sull’impatto positivo della natura sull’uomo sono davvero numerose, tra cui le più aderenti al progetto Recharge in Nature sono le seguenti:
- Basta un breve periodo passato tra i boschi per sentirsi “ricaricati”. Stare nella natura aumenta la voglia di fare e fa sentire più attivi, come se ricaricasse rapidamente la nostra riserva di energia (Ryan et al., 2010). Questa ricerca (Ryan et al., 2010) in particolare, condotta su un campione di 498 soggetti, ha mostrato che coloro che avevano praticato Shinrin-yoku (in sostanza, un “bagno nella foresta”) percepivano ridotti i livelli di ansia e depressione e sperimentavano un maggior senso di vitalità rispetto ai soggetti del gruppo di controllo.
- La natura consente di incrementare la creatività e la capacità di problem solving (Atchley et al. 2012). Lo studio ha mostrato che quattro giorni di totale immersione nella natura e di completa assenza di tecnologia hanno incrementato la creatività e l’abilità di risolvere problemi dei partecipanti fino al 50%.
- Riduce lo stress (Morita et. Al, 2006) e funge da fattore protettivo rispetto a eventi stressanti (Van de Berg, 2010).
- Favorisce la capacità di memorizzare (Berman, Jonides & Kaplan, 2008).
Ai partecipanti dello studio sopracitato veniva inizialmente chiesto di ripetere in ordine inverso alcune sequenze di numeri (digit span backward). Dopo questo compito, i partecipanti uscivano per fare una passeggiata: un gruppo camminava in un bosco, mentre il gruppo di controllo in città. Una volta ritornati, ripetevano il test di memoria precedentemente eseguito. I risultati hanno dimostrato che la capacità di rievocare le cifre era aumentata del 20% per il gruppo che aveva camminato nel bosco, mentre non hanno evidenziato cambiamenti significativi per il gruppo di controllo.
- Promuove benessere personale, felicità e tendenza prosociale (Passmore & Holder, 2017). Lo studio ha esaminato gli effetti di una sperimentazione di due settimane, in cui 395 studenti universitari erano assegnati casualmente a tre condizioni: ambiente naturale, ambiente artificiale o gruppo di controllo. Ai partecipanti veniva chiesto di prestare attenzione a come la natura o gli oggetti costruiti dall’uomo, a seconda dell’assegnazione, li facessero sentire in termini emotivi.
I risultati hanno dimostrato che il gruppo sperimentale, che prestava attenzione a elementi naturali, manifestava un livello significativamente incrementato di benessere generale, connessione con gli altri, verso la natura e una maggiore tendenza prosociale.
- Fare attività nel verde incrementa l’autostima (Barton & Pretty, 2010). Una revisione ha analizzato i dati di 1.252 soggetti che hanno partecipato a dieci studi differenti. La review ha rilevato che anche solo 5 minuti quotidiani di esercizio nella natura sono sufficienti per notare un incremento del livello di autostima.
- Vedere attorno a sé immagini naturali promuove le connessioni neurali e infonde uno stato di tranquillità (Hunter et al., 2010). Pare che il semplice fatto di osservare immagini naturalistiche permetta a differenti aree del cervello di lavorare in maggior sincronia, a differenza di quanto accade osservando paesaggi artificiali.
- Stare nella natura promuove una miglior salute mentale complessiva (Alcock et al, 2014) (Kuhn, S.,2017).
- Vivere in un ambiente naturale migliora la qualità del sonno (Johnson et al., 2018) (Grigsby-Toussaint et al., 2015).
- Riduce gli stati ansiosi, depressivi e la ruminazione mentale (Bratman et al., 2015), (Collingwood, 2018).
- Promuove la salute cardiovascolare (Lee et al., 2013) e riduce il rischio di ipertensione (Shanahan et al., 2016).
- Riduce il mind wandering, incrementando il controllo attentivo e la creatività (Williams et al., 2018).
- Riduce l’impulsività (Repke et al., 2018).
- Chi vive in aree verdi gode complessivamente di una miglior salute psico-fisica (Health council of the Netherlands, Nature and the Environment Nature and health, 2004), (Maas et al., Green, 2006), (Maas et al., 2009), (Maller, et al., 2002), (Ulrich, 1984), (De Vries, Verheij & Groenewegen, 2003), (Verheij, 1996).
Recharge in Nature: il ruolo dello psicologo
Gli obiettivi principali della mia presenza in qualità di psicologo nel team sono stati:
- Contribuire alla realizzazione e organizzazione del progetto, anche tramite la ricerca bibliografia sui benefici psicologici dello stare in natura.
- Monitorare i livelli di stress e presenza mentale pre/post esperienza. Per effettuare le rilevazioni sono stati utilizzati due strumenti: il SOS (Stress Overload Scale, J. H. Amirkhan 2012) per conoscere il livello di carico percepito (event load) e i fattori personali di vulnerabilità allo stress (personal vulnerability) e il FFMQ (Five Facet Mindfulness Questionnaire, Baer et al., 2006) per conoscere il livello di mindfulness dei partecipanti, inteso nelle cinque componenti: osservazione, descrizione, consapevolezza, non-giudizio e non-reattività.
- Presenziare durante l’intero soggiorno, proponendo delle attività ai partecipanti e osservando le dinamiche del gruppo.
Una delle finalità dell’esperienza era quella di disconnettersi dalla vita online e provare per cinque giorni a portare la propria attenzione nel momento presente, incrementando la consapevolezza sensoriale e imparando a stare semplicemente con ciò che era presente.
Le attività psicologiche proposte hanno riguardato principalmente una pratica di mindfulness (come meditazione sul respiro, body scan, pratica dell’uva passa), utili a mantenere l’attenzione nel qui e ora e dare ai partecipanti degli strumenti per gestire lo stress.
I partecipanti inoltre redigevano ogni sera il loro personale Diario della Gratitudine in cui indicavano tre momenti vissuti durante la giornata che avevano particolarmente apprezzato e per i quali potevano definirsi grati (un esercizio ripreso da diversi autori in ambito self-compassion e psicologia positiva; un esempio in Emmons & Stern, 2013).
Altre attività proposte durante il soggiorno sono state yoga, stone balancing, shrinin-yoku, escursioni e altre attività sempre volte a ripristinare l’attenzione nel qui e ora, riscoprire la valenza dei sensi, del movimento e delle relazioni vis-a-vis.
Risultati dell’esperienza Recharge In Nature
Nonostante le evidenti limitazioni sul piano empirico-sperimentale, si presenta in tale paragrafo uno studio pilota per verificare l’effetto dell’esperienza complessiva Recharge in Nature.
Ovviamente il progetto non aveva le caratteristiche per essere considerato rilevante sul piano scientifico, principalmente per l’impossibilità di isolare le variabili (a cosa è davvero attribuibile l’effetto? Il contesto? le relazioni? le attività svolte ecc..?), per l’assenza di un gruppo di controllo e altre limitazioni.
Inoltre, la lingua parlata dal gruppo era l’inglese (anche ai partecipanti italiani era stato richiesto una buona competenza in merito), pertanto sono stati utilizzati i test validati in versione inglese. I risultati dunque vanno interpretati con estrema cautela e sono da considerarsi principalmente come spunto di riflessione e non come evidenze scientifiche.
La rilevazione dello stress, percepito nell’ultima settimana di lavoro, è stata eseguita mendiante la Stress Overload Scale (Amirkan, 2011), che si compone di 30 item pertinenti a 3 cluster: 1) Event Load (carico percepito) fa riferimento alla percezione di essere sopraffatti dai propri impegni 2) Personal Vulnerability (fattori personali di vulnerabilità) si riferisce alla valutazione di non essere competenti nella gestione dei propri impegni. Infine, sono stati inseriti alcuni item di riempimento (filler) a valenza positiva, per interrompere la sequenza di item negativi ed evitare risposte automatiche; queste affermazioni si riferiscono a caratteristiche di personalità che il soggetto è chiamato ad autovalutare.
Il confronto fra i punteggi riguardanti lo stress dei partecipanti prima e dopo RIN è stato effettuato mediante un test non parametrico (test di Wilcoxon), in considerazione delle caratteristiche del campione (distribution-free e ridotta numerosità). Si è verificata, dunque, l’ipotesi che le due misurazioni fossero statisticamente differenti assumendo una probabilità di errore inferiore a .05.
Per ciascuna delle tre classi di item (curiosamente anche per il filler, a indicare che anche la percezione personale complessiva è migliorata durante il soggiorno) è stata rilevata una differenza significativa nelle due somministrazioni con valori di significatività inferiori a p .05. Infatti, per la categoria “event load”, p è .005; per la “personal vulnerability” p è .006 e anche per gli item di Filler è stata evidenziata una differenza significativa con p .006.
In conclusione, l’esperienza ha prodotto una significativa riduzione del carico di stress esperito dai partecipanti, in termini di percezione del carico degli eventi stressanti e di valutazione delle proprie incapacità di fronteggiarli. Quello che emerge è un incremento nell’autovalutazione delle abilità di coping e un decremento della sensazione di essere sopraffatti dagli stressors.
Per quanto riguarda il questionario FFMQ(Five Facet Mindfulness Questionnaire, Baer et al., 2006), è stato utilizzato il t di Student poiché è il test che solitamente si applica per verificare l’effetto sul gruppo pre-post nei percorsi di mindfulness.
Il gruppo ha visto un incremento davvero notevole, mai notato da noi in altre esperienze, su tutte le cinque componenti (observing, describing, acting with awareness, non-judging of inner experience, and non-reactivity to inner experience) con una significatività davvero molto elevata (p .00001) ed effetto sul gruppo “huge” secondo il D di Cohen (1,6397).
A livello puramente qualitativo, al termine dell’esperienza i partecipanti hanno dichiarato di sentirsi maggiormente rilassati, concentrati e focalizzati su quanto li circondasse. Se prima la loro attenzione tendeva spesso ad andare alla componente online (social network e chat, principalmente) con immediato ricorso allo smartphone, successivamente il contenuto dei loro pensieri era più contestualizzato nel qui e ora.
L’aspetto maggiormente apprezzato dai partecipanti è stata la componente sociale dell’esperienza: il fatto di passare molto tempo assieme, senza distrazioni, ha concesso loro di beneficiare pienamente delle relazioni, parlare guardandosi negli occhi, potersi conoscere, esprimere pensieri ed emozioni in diretta.
Da un insieme di persone sconosciute e provenienti da tutto il mondo, si è rapidamente creato un gruppo coeso e desideroso di mettere in discussione importanti temi di vita, chiacchierare e confrontarsi fino a tarda sera.
Concludendo, ecco le parole di una delle partecipanti che ha brevemente raccontato l’esperienza RIN nel suo blog:
Per 5 giorni ci siamo isolati dal mondo ma ci siamo connessi con la natura, con noi stessi e tra di noi (…). Con quella semplicità e leggerezza che tanto mi mancavano. Adolescenti degli anni ’90, che trascorrevano il tempo a conoscersi, giocare, ridere, piangere, abbracciarsi, brindare ai nostri desideri. (…).
Non abbiamo mai affrontato veramente il tema “cellulare”. Non eravamo lì per “disintossicarci dallo smartphone”, noi avevamo bisogno di riconnetterci con noi stessi. Con il presente. Con le vite che ci passano accanto e che spesso nemmeno notiamo. (…).
Ed ecco cosa mi è rimasta di questa esperienza. Mi è rimasta un’attenzione maggiore del qui ed ora, un amore per me stessa e la mia vita che avevo perso. Accendo il telefono più tardi la mattina, non ho più la necessità di condividere tutto quello che faccio perché preferisco viverlo, assaporarlo. Mi sento forte.