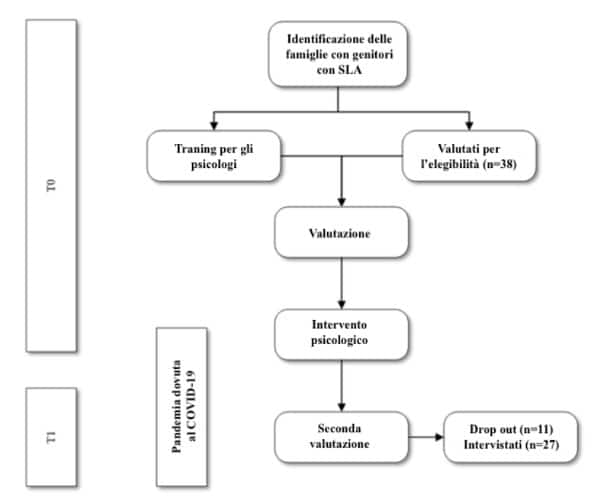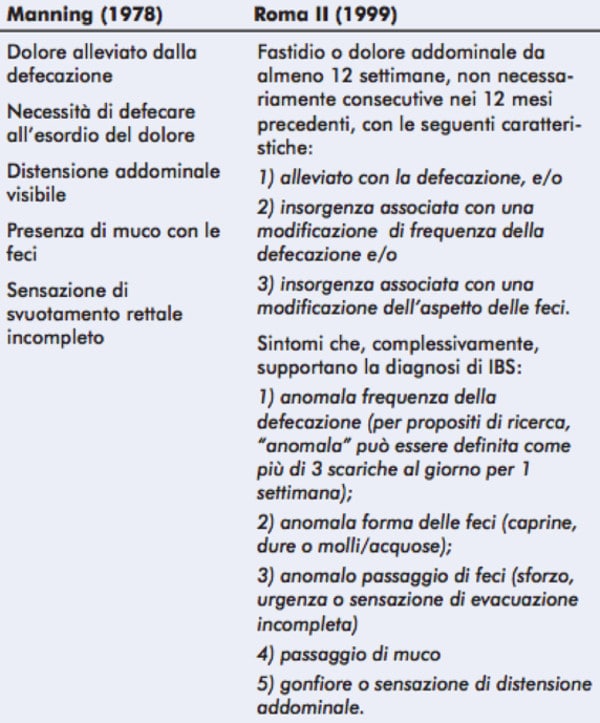Le lingue impossibili (2017) di Andrea Moro – Recensione
Le lingue impossibili è un libro che sfida l’idea generalmente accettata che una cosa così altamente arbitraria come una lingua abbia dei vincoli biologici che prescindono le nostre capacità creative.
Il libro Le lingue impossibili è stato scritto da Andrea Moro, noto studioso del linguaggio che insegna linguistica generale presso la scuola universitaria superiore di Pavia, conosciuto soprattutto per avere condotto un esperimento neuroscientifico particolarmente importante che ha gettato luce sulla natura del linguaggio umano confermando la tesi rivoluzionaria proposta dal geniale ed eclettico linguista Noam Chomsky più di cinquant’anni fa.
Le lingue impossibili è un testo scritto in modo molto accessibile anche per chi non è avvezzo ai tecnicismi scientifici né tantomeno della linguistica e, proprio per questo motivo, risulta essere uno dei pochi libri divulgativi italiani particolarmente aggiornati dal punto di vista scientifico dove si discute dell’architettura biologica del linguaggio.
Il testo è una sfida dichiarata ad alcune false convinzioni molto radicate che abbiamo nei confronti del linguaggio, ma soprattutto del fatto che vi sono dei limiti nella potenzialità sintattica che possiamo esprimere.
L’obiettivo del libro è convincere in maniera tanto provocatoria quanto scientificamente fondata che i limiti della sintattica linguistica sono di natura biologica ed in questo senso si tratta di uno scritto molto ambizioso perché sfida l’idea generalmente accettata che una cosa così altamente arbitraria come una lingua abbia dei vincoli biologici che prescindono le nostre capacità creative e quindi anche indirettamente la percezione che abbiamo della nostra libertà.
Il libro mira a dimostrare quanto non sia banale comprendere la base biologica del linguaggio umano e integrare questo aspetto specie specifico (appartenente cioè solo alla specie umana) con la disorientante quanto estesa varietà di lingue umane presente nel pianeta e quindi anche con la straordinaria moltitudine legata alla loro dimensione convenzionale ed arbitraria.
Così come la comprensione del processo che spiega il disegno di un maglione, o di un arazzo, può essere realmente compreso solo rovesciando l’artefatto stesso, perché solo così si afferrano gli indizi della trama sottostante e quindi del modo di cucire il disegno percepito dall’esterno, il linguaggio può essere compreso solo ribaltando il nostro punto di vista tradizionale che ci impedisce di vedere la trama invisibile ma esplicativa rappresentata dall’architettura biologica sottostante.
Questo ‘ribaltamento’ concettuale viene sostanziato, anche in termini metodologici, all’interno dello studio realizzato nel 2003 da Moro ed il suo gruppo di ricerca, dove hanno dimostrato la significativa differente attivazione neurale dell’area di Broca (dedicata all’elaborazione delle strutture linguistiche in particolare della proprietà della dipendenza della struttura linguistica) in seguito all’esposizione di lingue possibili rispetto quelle invece impossibili.
Nello studio condotto dall’autore, la ‘trama’ del maglione linguistico viene messa in evidenza introducendo il fattore delle ‘lingue impossibili’, di lingue cioè potenzialmente concepibili, ma che non soddisfano le caratteristiche strutturali gerarchiche di quelle umane.
Il gruppo, capitanato da Moro, ha infatti dimostrato in maniera pressoché unica e decisiva un aspetto particolarmente importante del meccanismo biologico del linguaggio perché, presentando alle persone strutture sintattiche gerarchiche possibili, ha verificato che, durante il processo di apprendimento, l’afflusso di ossigeno veicolato da quello sanguigno nell’area di Broca aumentava mano a mano che le esperienze linguistiche si accumulavano mentre, nel caso dell’esposizione a strutture sintattiche gerarchiche impossibili, avveniva esattamente l’opposto, cioè il sistema neurale riconosceva sempre più nettamente che si trattava di un’informazione non linguistica.
La dimostrazione che il cervello, procedendo nella sua esposizione a esperienze linguistiche di strutture sintattiche possibili ed impossibili, discriminasse sempre con maggiore facilità e precisione cosa ritiene corretto da ciò che non lo è, facendo attivare neuralmente l’area di Broca solo nel contesto della prima categoria di strutture, evidenzia l’esistenza di un meccanismo ‘progettato’ in maniera specifica, che precede l’esperienza linguistica stessa e che è indipendente dagli aspetti culturali umani.
Gli studi di Moro convergono sul concetto secondo il quale, in piena coerenza con la rivoluzionaria tesi sostenuta da Chomsky decenni fa, la specie umana è dotata di una architettura ‘progettata’ e predisposta per cogliere il significato di alcune specifiche strutture linguistiche (come la dipendenza della struttura gerarchica), ignorandone altre (come l’ordine sequenziale delle parole ascoltate o viste), attraverso l’esposizione di esperienze linguistiche (acustiche o visive) costituite anche da componenti convenzionali e arbitrarie.
La disorientante (e per alcuni versi fuorviante) molteplicità di lingue esistenti attualmente, quella che potremmo chiamare la Babele linguistica, è caratterizzata da una varietà ed eterogeneità formidabile, senza dubbio anche connotata da un’enorme arbitrarietà ma, proprio come altri fenomeni biologici, è stata prodotta attraverso un processo ‘a monte’ che è invariante a livello di architettura neurale (il cosiddetto ‘organo del linguaggio’ in termini chomskiani) che ne definisce i limiti strutturali.
Gli studi originali di Moro hanno gettato luce proprio sulla natura neurale, che definisce il perimetro esistente delle lingue possibili che una persona può imparare (il ‘recinto di Babele’) distinguendolo da quelle che non si possono apprendere perché non soddisfano le proprietà strutturali richieste dall’architettura umana (una lingua che per la specie umana è quindi ‘impossibile’).
Analogamente al contesto alimentare dove esiste una notevole varietà culturale gastronomica umana in cui vi sono popolazioni che si cibano di un certo tipo di alimenti e non di altri (per esempio pesci e non carne o insetti) mentre altre popolazioni esprimono scelte esattamente opposte, ma in nessun caso ci si alimenta con una pinta di cherosene per l’intrinseca incapacità dell’organismo umano di digerire tale miscela di idrocarburi, nel caso del linguaggio l’enorme eterogeneità linguistica presente sottende dei vincoli che sono determinati dallo specifico modo biologico di elaborare le informazioni linguistiche.
Almeno in parte, la difficoltà culturale di cogliere questi aspetti complessi del linguaggio nasce anche dalla difficoltà di associare al significato di vincolo ed architettura biologica l’enorme potenzialità in parte arbitraria che percepiamo quando pensiamo alle lingue ed alle loro possibili varianti che possiamo anche decidere di creare individualmente.
Probabilmente risulta importante sforzarsi di non intendere il concetto di ‘vincolo’ o ‘architettura’ solo nel loro significato restrittivo, bensì come struttura che permette di esprimere una possibile grande variazione determinata dalla traiettoria stessa di tale fattore intrinseco.
Un esempio di tale concetto potrebbe essere la performance di un centometrista olimpionico che può essere molto superiore rispetto alla media della popolazione umana, ma che è pur sempre in relazione alla struttura anatomica di un organismo terrestre che si muove principalmente con andamento bipede (attività motoria possibile) e che proprio per questa sua specifica architettura, la quale quindi intrinsecamente prevede dei vincoli, non è capace di svolgere una performance come il volo (attività motoria impossibile per la specie umana).
In questo contesto complesso le menti linguistiche ‘staminali’ dei bambini sono intrinsecamente predisposte ad apprendere qualsiasi lingua possibile umana in tutte le sue attuali e future varianti anche convenzionalmente definite data la natura biologicamente definita che ne limita sia le potenzialità logiche (entro quindi i confini della Babele linguistica che ne esclude quelle umanamente impossibili) che temporali (il processo di apprendimento linguistico della lingua ‘madre’ avviene all’interno di una limitata finestra temporale relativa lo sviluppo ontogenetico).
Il libro di Moro ci accompagna nella comprensione di questa architettura attraverso un percorso fatto di piccoli passi graduali ma persuasivi, puntellati da metafore calzanti (come quella che ho citato poco sopra relativa la trama del maglione o l’analogia alimentare appena descritta) che permettono al lettore di avere velocemente una certa competenza assolutamente non banale sulla natura del linguaggio.
Affrontando con progressione e precisione alcuni luoghi comuni sul linguaggio, come la presunta natura totalmente arbitraria delle lingue, così come l’altrettanto diffusa convinzione che a lingue diverse equivalgono aspetti mentali diversi (a questo proposito si leggano anche gli interessanti altri testi divulgativi dello stesso autore), l’autore propone delle argomentazioni che passano dalle evidenze matematiche a quelle osservazionali a quelle neuroscientifiche, sempre arricchite da riferimenti storici interessanti quanto illuminanti.
Gli studi particolarmente rilevanti sulla natura biologica del linguaggio dello stesso Moro sono citati nel testo per consolidare una visione più complessa, in parte ancora da comprendere, del meccanismo che permette alla specie umana di apprendere ed esprimere il nostro caratteristico codice linguistico.
Personalmente trovo interessante pensare al linguaggio un po’ come la ragnatela di un ragno dove però, diversamente da esso, la ragnatela linguistica umana non è costituita solo dalle componenti fisico-chimiche biologiche rappresentate dalle proteine che costituiscono l’artefatto dell’aracnide, ma anche dalle esperienze caratterizzate dai codici arbitrari convenzionalmente condivisi all’interno di una comunità.
Il libro è un testo che consiglio di leggere a tutti gli psicologi sia perché da professionisti delle dinamiche mentali umane ci aiuta a riconsiderare alcuni miti purtroppo diffusi anche all’interno della nostra categoria (si veda, ad esempio, il caso delle improbabili trecento parole utilizzate dagli eschimesi per indicare i diversi tipi di neve a dimostrazione del fatto che la lingua determina la percezione della realtà), sia perché offre un punto di vista originale e sfidante sul fenomeno del linguaggio e del dualismo natura-cultura.
La prospettiva offerta dal libro indica una maggiore complessità del fenomeno linguistico rispetto a quanto precedentemente creduto (si pensi a questo riguardo ai decenni di fallimentare comportamentismo applicato al linguaggio) e stimola ad una maggiore consapevolezza sulla natura, in parte inesplorata e misteriosa, di questo aspetto umano così importante per la nostra identità.