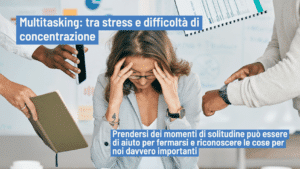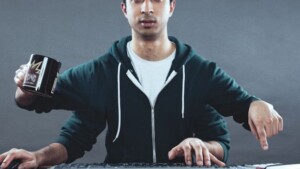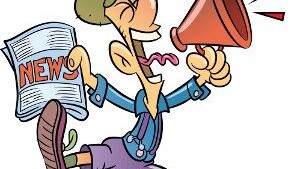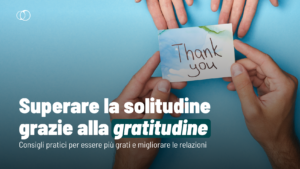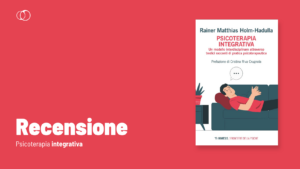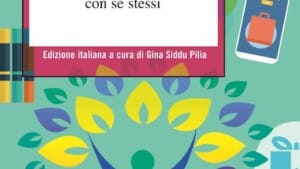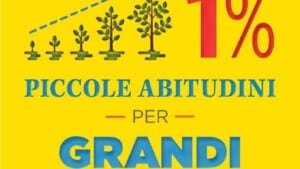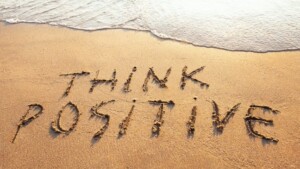Fibromialgia – Definizione, sintomi, cura
La fibromialgia (o sindrome fibromialgica) è una malattia cronica complessa definita dall’American College of Rheumatology come “una condizione di dolore cronico diffuso con caratteristici “tender points” (punti dolenti alla pressione) all’esame fisico, spesso associata con una varietà di sintomi o disfunzioni quali la fatica, i disturbi del sonno, la cefalea, la sindrome del colon irritabile e i disturbi dell’umore”.
Che cos’è la fibromialgia
La fibromialgia è stata ed è ancora una delle diagnosi più controverse in medicina. L’angolo di visuale del reumatologo non sempre concorda con quello dello psicologo, dello psichiatra o del neurologo.
Il gruppo italiano di studio sulla fibromialgia ha recentemente definito questa malattia:
[blockquote style=”1″]“una sindrome da sensibilizzazione centrale, caratterizzata da disfunzione dei neurocircuiti, che coinvolgono la percezione, la trasmissione e la processazione degli stimoli nocicettivi afferenti, con la prevalente manifestazione di dolore a livello dell’apparato locomotore”.[/blockquote]
Nel 1996 Turk e collaboratori avevano dimostrato l’esistenza di “subset” di pazienti differenziabili in base a caratteristiche cognitive, psicosociali e che rispondevano in modo diverso al trattamento farmacologico. Nel 2003, Giesecke e collaboratori, basandosi sulle caratteristiche del dolore (intensità, capacità di controllo del dolore e soglia nocicettiva) e sugli aspetti interpretativi ed emozionali della percezione nocicettiva (ansia, depressione e catastrofismo) hanno identificato tre tipologie di pazienti (1):
• il primo gruppo (51,5%) è caratterizzato da valori medi per tutti i parametri misurati; comprende la maggior parte dei pazienti che si rivolgono al medico di medicina generale a causa del dolore diffuso e che, solitamente, rispondono maggiormente al trattamento;
• il secondo gruppo (32%) è caratterizzato da alti livelli di ansia, depressione e catastrofismo, da scarsa capacità di autocontrollo del dolore e da elevata dolorabilità alla digitopressione;
• il terzo gruppo (16,5%) è invece caratterizzato da pazienti con bassi livelli di ansia, depressione e catastrofismo ma con soglia nocicettiva particolarmente bassa.
Diagnosi di fibromialgia
I criteri per la diagnosi della fibromialgia sono stati definiti dall’American College of Rheumatology nel 1990. Nel 1992 la fibromialgia è stata riconosciuta come malattia nosograficamente autonoma dalla Organizzazione Mondiale della Sanità ed è stata classificata con il codice M79.03 nella classificazione internazionale delle malattie (ICD-10). Infine, nel 1994 l’International Association of the Study of Pain (IASP) ha riconosciuto la fibromialgia come una malattia, classificandola con il codice X33.X8a. Ma quali sono i sintomi caratteristici di questa malattia così emblematica? Eccone un elenco.
Sintomi della fibromialgia
Dolore
Il dolore cronico diffuso, riferito a “tutto il corpo”, presente da almeno 3 mesi, è indubbiamente il sintomo più caratteristico della fibromialgia, rilevandosi nella quasi totalità dei pazienti. Il dolore che affligge i pazienti affetti da fibromialgia, è un dolore diffuso che non presenta una particolare distribuzione anatomica. L’elenco dei segni e dei sintomi è estremamente ampio e variegato. La semantica del dolore è alquanto variegata. Espressioni quali: “mi fa male tutto” o , “riesco prima a dire che cosa non mi fa male” sono del tutto caratteristiche dei pazienti fibromialgici. Il dolore viene abitualmente definito come “pungente”, “urente”, “lancinante”, “penetrante”. La sintomatologia dolorosa viene caratteristicamente accentuata dal freddo, dall’umidità, ma anche da eventi stressanti, periodi di inattività o dal sovraccarico funzionale. I malati tendono a definire il dolore “di tipo muscolare”.
Astenia
Un quadro di astenia talora intenso ed uno stato generale di affaticamento (che gli anglosassoni ben definiscono con il termine: la “fatigue”) sono presenti nel 75-90% dei casi (2,3). “Mi sento sempre stanco” è una tipica descrizione della “fatigue” da parte del malato, che riferisce inoltre spossatezza, stanchezza, mancanza di energie. L’astenia è nettamente più accentuata al risveglio, tanto che i pazienti spesso utilizzano la stessa frase per descrivere questa sensazione: “mi sento più stanca la mattina rispetto alla sera”. Tra i fattori correlati all’astenia ed al senso di affaticamento figurano: qualità e quantità del sonno inadeguate (sonno non ristoratore), un decondizionamento muscolare causato dall’inattività ed uno stato ansioso-depressivo (astenia “motivazionale).
Disturbi del sonno
Tipico della fibromialgia è un sonno non ristoratore, riferito dal 75% dei pazienti e si manifesta sotto forma di: insonnia iniziale, insonnia centrale (risvegli frequenti durante la notte con difficoltà a riaddormentarsi), insonnia finale, ipersonnia, sonno leggero, irregolare riposo diurno, inversione del ritmo sonno-veglia (4). Studi di polisonnografia hanno mostrato che i soggetti con fibromialgia, rispetto ad un gruppo sano di controllo, presentano una ridotta quota di sonno ad onde lente, di sonno REM, di sonno totale, così come un maggior numero di risvegli prolungati ed un pattern elettroencefalografico di intrusione di onde alfa (onde associate alla reazione di risveglio) sul ritmo delta (onde lente che caratterizzano il sonno profondo)(5). Le alterazioni del sonno appena riferite, creano un circolo vizioso, in quanto accentuano il dolore e influiscono sull’umore, che a loro volta contribuiscono a disturbare il sonno (6). I pazienti con sonno maggiormente alterato presentano una maggiore percezione del dolore ed un più elevato numero di tender point (5,7).
Parestesie
Una sensazione di formicolio, di intorpidimento, di spilli o aghi che pungono si rileva nell’ 84% dei pazienti (8). L’esame obiettivo neurologico e l’elettromiografia risultano il più delle volte nella norma.
Sensazione di gonfiore nelle zone dolenti
Una sensazione soggettiva di gonfiore si osserva in circa la metà dei pazienti (9). Questa sensazione è spesso associata a crampi muscolari, fascicolazioni e tremori palpebrali.
Disturbi neurocognitivi
Sintomi neurocognitivi della fibromialgia comprendono difficoltà e calo della concentrazione, disturbi della consolidazione della memoria a breve termine (“mi dimentico tutto”), rallentamento nei gesti, riduzione della performance linguistiche, inabilità a compiere più azioni contemporaneamente, facile distrazione e sovraccarico cognitivo sono particolarmente frequenti in corso di fibromialgia. I pazienti lamentano inoltre “nebbia cognitiva” (definita come “fibro-frog”), confusione mentale, dislessia, difficoltà nello scrivere, nel parlare, nel leggere, nel compiere azioni matematiche e nel reperire vacaboli (10). È stato dimostrato che i pazienti con fibromialgia presentano funzioni cognitive (in termini di memoria a lungo termine e “working memory”) inferiori rispetto a soggetti più anziani di 20 anni (11,12) e simili a quelle di adulti di venti anni più anziani. I pazienti possono avere performance simili ai soggetti sani di controllo ma solo con attivazione neuronale estensiva delle regioni frontali e parietali dell’encefalo (13).
Studi recenti mostrano come nei pazienti affetti da fibromialgia vi sia una significativa perdita di materia grigia (3,3 volte maggiore rispetto a soggetti sani della stessa età), con una correlazione tra durata di malattia e perdita di sostanza grigia (14).
Acufeni
Senso di ronzio e di rumore all’orecchio rientrano tra i sintomi frequenti nei pazienti con fibromialgia.
Dolore temporo-mandibolare
La Sindrome algico-disfunzionale delle articolazioni temporo-mandibolari è di non raro riscontro. Il dolore si accentua con i movimenti di apertura e chiusura della bocca.
Sindrome delle gambe senza riposo
Una tipica “restless leg syndrome” è presente nel 30% dei pazienti, e si manifesta con la caratteristica sintomatologia notturna (gambe che si muovono di continuo).
Colon irritabile
Sindrome del colon irritabile è presente nel 32-70% dei pazienti e si manifesta con dolore addominale, sensazione di gonfiore e turbe dell’alvo (diarrea alternata a stipsi).
Disturbi dell’apparato genito urinario
Dolori pelvici, spasmi vescicali con minzioni frequenti, tensione ai genitali, dismenorrea sono molto frequenti nelle pazienti con fibromialgia.
Disfunzioni sessuali
La fibromialgia risulta associata con alcune disfunzioni sessuali femminili. Tra queste figurano soprattutto la diminuzione della eccitazione sessuale, una negativa esperienza orgasmica ed un aumento del dolore correlato al coito (15,16,17,18). Sul ruolo della componete psicologica nella genesi di tali disturbi non si registrano orientamenti univoci. Anche se i dati epidemiologici non possono ritenersi esaurienti, si ritiene che circa 1/5 delle donne affette da fibromialgia presenti disturbi da dolore vulvare (19,20). La comparsa di dolore durante il rapporto coitale è più comune nelle pazienti fibromialgiche (50%) rispetto alle donne sane (16,7%) (Aydin et al). Secondo altri autori (Shower et al) il dolore nel corso di un rapporto sessuale sarebbe più frequente nelle pazienti con fibromialgia dal momento che in questa malattia la tolleranza e la soglia di percezione del dolore sono nettamente ridotte rispetto ai soggetti sani (21).
Disturbi della sfera affettiva
Il 50-60% dei pazienti con fibromialgia presenta almeno un episodio di depressione maggiore nel corso della vita. Degno di nota è il fatto che i parenti di primo grado dei pazienti con fibromialgia presentino una prevalenza elevata di disturbi dell’umore rispetto ai pazienti con artrite reumatoide ed ai soggetti di controllo (22). I soggetti affetti da fibromialgia riportano esperienze traumatiche infantili, come abusi, rifiuti e maltrattamenti fisici, più frequentemente rispetto ai soggetti di controllo (23).
Altri sintomi della fibromialgia
Altre manifestazioni: nell’infinita lista dei sintomi della fibromialgia figurano inoltre: disturbi vasomotori periferici, intolleranza alla luce ed ai suoni, sindrome sicca (secchezza degli occhi e della bocca), dolore toracico (descritto come “forti fitte al cuore da togliere il respiro”), cardiopalmo (sensazione soggettiva del battito cardiaco).
I tender point rappresentano invece il segno obiettivo più caratteristico della fibromialgia. Possono essere definiti punti dolenti alla pressione situati in corrispondenza di specifiche sedi muscolari e tendinee. La digitopressione che l’operatore esercita nei 18 punti dolenti individuati nella mappa dei tender point deve essere di 4 Kg/cm2 (questa pressione equivale allo sbiancamento del letto ungueale dell’esaminatore).
Il complesso quadro sintomatologico dei pazienti con fibromialgia può essere influenzato negativamente da fattori esterni, quali eventi stressanti (lutti, traumi, esperienze traumatiche infantili, abusi e/o violenze, rifiuti e maltrattamenti fisici, traumi fisici e psicologici, eventi particolarmente dolorosi), rumore (24), freddo, umidità, cambiamenti metereologici, fase pre-mestruale, sovraccarico lavorativo, lunghi periodi di inattività, ritmi di vita frenetici, stato di tensione continua, ansia, stress, sonno disturbato (25,26).
Epidemiologia della fibromialgia
Per ciò che concerne l’epidemiologia, è possibile affermare che la fibromialgia è una condizione di difficile valutazione e può contare un numero limitato di studi su incidenza e prevalenza che certamente non rendono agevole la messa a punto di una accurata mappa epidemiologica della malattia. Gli studi basati sui criteri classificativi dell’American College of Rheumatology (ACR) riportano una prevalenza sulla popolazione generale tra lo 0,1 ed il 3,3%.
Lo studio MAPPING riporta una prevalenza della fibromialgia nell’ordine del 2.22%. Sulla base di tale dato, in Italia risulterebbero affetti da fibromialgia 1.333.000 soggetti (5). Questa percentuale risulta quasi doppia rispetto alle stime di riferimento di Ciocci e coll. che vedevano la fibromialgia interessare l’1,2% della popolazione generale (circa 700.000 italiani) (27).
La motivazione della maggiore prevalenza nel sesso femminile non è del tutto nota. E’ probabile che la differenza tra i due sessi debba essere ricondotta ad una diversa interazione tra fattori genetici, biologici, psicologici e socio culturali (certamente gli estrogeni hanno un ruolo importante nella modulazione del dolore, come pure la ridotta produzione del testosterone nel sesso femminile). Sembra che la prevalenza della fibromialgia aumenti con l’aumentare dell’età fino ai 79 anni, pur potendo colpire adolescenti e bambini.
Il sesso femminile rappresenta certamente il maggior fattore di rischio per la fibromialgia (rapporto maschi/femmine 1:9). Uno studio del 1999 di Forseth (28) ha preso in esame i possibili fattori di rischio per la comparsa di fibromialgia in un gruppo di donne con dolore diffuso aspecifico. Sono risultati predittori la durata del dolore superiore ai 6 mesi, la presenza di dolore assiale e nella parte distale degli arti superiori, la presenza di sintomi associati quali disturbi del sonno, metereolabilità, la familiarità, la cefalea cronica, l’alvo alterno, le parestesie ed un tono dell’umore depresso. L’età attuale, l’età di esordio, la conta dei tender point alla digitopressione e le caratteristiche del dolore non sono elementi utili per discriminare i soggetti che possono sviluppare la fibromialgia.
Un dato interessante emerso da molti studi riguarda invece il rapporto inverso esistente tra il grado di istruzione e lo sviluppo di una sindrome dolorosa cronica, analogamente alla presenza di condizioni sociali svantaggiose (divorzio, handicap, immigrazione, basso reddito) (29,30).
Fibromialgia e disturbi della sfera affettiva
È inoltre evidente l’importanza che riveste nello sviluppo di una sintomatologia fibromialgica la presenza di disturbi della sfera affettiva in atto o pregressi (divorzi, separazioni, lutti) o di altre affezioni croniche, in particolare se aggravate da stress psicologico e/o caratterizzate dalla presenza di stimoli nocicettivi persistenti.
Oliver e Silman (31) hanno riproposto in un recente articolo, l’importanza degli studi epidemiologici nella fibromialgia, avvalorando la tesi secondo cui traumi fisici, problematiche psico-sociali, fattori genetici e raziali possano essere elementi condizionanti la comparsa e l’espressione della fibromialgia. Grazie ad un’intervista condotta in anonimo via Internet, Wilson e coll., hanno potuto confermare che le cause indicate dalla popolazione come motivo di insorgenza della fibromialgia sono nel 60% emozionali (40% fisiche) e che le stesse cause emozionali sono nel 94,2% motivo stesso delle riacutizzazioni (5,8% cause fisiche ed ambientali)(32).
Comorbilità nella fibromialgia
Le classiche espressioni cliniche della fibromialgia possono rilevarsi anche in soggetti con un’ampia e variegata gamma di affezioni ad impronta algico-disfunzionale. Tra le comorbilità più frequentemente osservate in pazienti con fibromialgia figurano (33):
– sindrome del tunnel carpale (23% vs 1% dei controlli);
– ansia (5% vs 1% dei controlli);
– depressione (12% vs 3% dei controlli).
Di rilevante interesse risulta lo studio di Bateman e coll. che nel 2009 hanno pubblicato un’indagine condotta su pazienti partecipanti al convegno tematico sulla fibromialgia tenutosi a Salt Lake City (USA). Fra le comorbilità più frequenti risultarono i disturbi del sonno (83%), la depressione (71%), l’ansia (63%) e l’artrite (38%).
Fibromialgia e disturbi psichiatrici
La prevalenza dei disturbi psichiatrici nei pazienti con fibromialgia è palesemente elevata rispetto alla popolazione generale. E’ stato dimostrato che il rischio di sviluppare disturbi d’ansia (in particolare il disturbo ossessivo – compulsivo ed il disordine post-traumatico da stress) nel corso della vita dei pazienti con fibromialgia è circa 5 volte superiore rispetto a soggetti di controllo (34). Studi epidemiologici hanno infatti osservato una concomitante depressione maggiore nel 14-36% dei pazienti fibromialgici contro il 6.6% dei soggetti di controllo (35). Un’ulteriore associazione è stata osservata tra il disordine post-traumatico e il 56% dei pazienti con fibromialgia.
Fibromialgia e depressione
Anche se vi è una associazione ben documentata tra malattie croniche e depressione, quella tra depressione e fibromialgia è particolarmente rilevante (Kassan et al, 2006). È stato recentemente dimostrato che la stanchezza e la depressione risultano essere le componenti che esercitano maggior impatto negativo sulla capacità funzionale dei pazienti (Del e coll., 2008). Dallo studio degli autori spagnoli è emerso che una storia pregressa di problematiche significative di ordine psicologico e psichiatrico risultava documentabile nel 50% dei casi. Al momento dello studio, tuttavia, la prevalenza di una “mental illness” è stata documentata solo nel 36,4% dei casi. Questa percentuale risulta sostanzialmente sovrapponibile a quella che si registra in studi precedenti in soggetti con altre malattie croniche.
Occorre sottolineare che in questi pazienti la diagnosi di fibromialgia viene accolta con un certo sollievo. In alcuni soggetti l’ansia innescata dalla perplessità e dai dubbi in merito alla natura della sintomatologia sembra quasi dileguarsi di fronte alla conferma della diagnosi di fibromialgia. L’espressione “mi sento meglio adesso che so che non mi stavo inventando tutto” è particolarmente frequente e caratterizza una reazione molto comune da parte dei pazienti, i quali si sentono considerati dei veri e propri “malati immaginari” anche dai propri familiari. In quest’ottica, la diagnosi di fibromialgia viene in parte considerata come una vera e propria liberazione.
Occorre sottolineare che i fibromialgici mostrano spesso una forte irritazione quando i propri disturbi vengono ricondotti nel contesto delle espressioni di una sindrome depressiva e tendono a rifiutare con fermezza i farmaci anti-depressivi e, in senso più generale, ogni terapia capace di incidere nel tono dell’umore. Tra i descrittori semantici più spesso utilizzati per esprimere tale atteggiamento figurano espressioni quali: “non sono pazzo”, “non sono depresso”. Di ciò deve tener conto il medico, dal momento che alcuni dei farmaci che si sono rivelati più efficaci nella terapia della fibromialgia appartengono proprio al gruppo degli anti-depressivi.
Trattamento della fibromialgia
Un principio fondamentale della strategia di trattamento della fibromialgia è l’approccio interdisciplinare e multiprofessionale finalizzato all’attenuazione del dolore, alla riduzione della “fatigue”, delle turbe del sonno e delle altre manifestazioni emotive della malattia. Il risultato finale dei diversi possibili schemi di intervento è quello di migliorare la qualità della vita, che risulta gravemente compromessa nella quasi totalità dei pazienti fibromialgici. La strategia di trattamento deve risultare particolarmente flessibile, dovendo tener conto delle molteplici variabili che incidono sulla espressione di malattia.
Depressione e angoscia sono sentimenti che nascono e si sviluppano come risposta naturale alla diagnosi di una malattia cronico – degenerativa o oncologica. Passare dalla condizione di “individuo sano” a quella di “individuo malato” è una esperienza complessa e delicata, non facile da gestire, specie in soggetti molto sensibili o particolarmente fragili (VEDI: Accettazione della malattia).
Psicoterapia per la fibromialgia
Fra le tante emozioni che il paziente vive figurano anche la tristezza, la rabbia (..”perché proprio a me” … “cosa ho fatto per meritarmi questo”), la vergogna, il senso di impotenza ed una tendenza all’isolamento, che porta inesorabilmente il malato ad una progressivo accentuazione della sofferenza e ad un stato di profonda solitudine dell’anima. Anche la famiglia vive gli stessi sentimenti del paziente, spesso uniti ad un senso di colpa e di imbarazzo per la difficoltà che ha nell’affrontare lo sguardo del proprio caro o per non sentirsi capace di gestire in modo adeguato la situazione. A tal fine risulta sempre più importante l’integrazione della terapia farmacologica alla psicoterapia.
 CONSIGLIATO: FIBROMIALGIA, UN ESPERIENZA DI TERAPIA DI GRUPPO
CONSIGLIATO: FIBROMIALGIA, UN ESPERIENZA DI TERAPIA DI GRUPPO
Una recente meta analisi orientata allo scopo di valutare il ruolo degli ”psychological treatments” ha dimostrato che l’ effetto della psicoterapia può definirsi “small but robust” e comparabile con quello attribuibile al trattamento farmacologico comunemente usato per la fibromialgia. La terapia cognitivo-comportamentale è risultata associata con il maggior “effect sizes” (36).
Quest’ultima è stata infatti utilizzata come base per molti programmi di trattamento del dolore e dello stress e costituisce una forma di educazione più complessa del paziente. Gli interventi della terapia cognitivo comportamentale possono comprendere:
– l’aiuto ai pazienti ad apprendere e a monitorare le interazioni tra i propri pensieri, sentimenti, sintomi, comportamento e ambiente sociale,
– il training cognitivo di adattamento alla malattia (tecniche di risoluzione dei problemi, tecniche di rilassamento, ristrutturazione cognitiva ecc),
– le tecniche comportamentali di adattamento (definizione degli obiettivi, tecniche di prevenzione delle recidive, ecc.)
– le strategie per promuovere il supporto sociale.
Alcuni studi apportano l’efficacia del trattamento educazionale associato a strategie terapeutiche multimodali più complesse da parte di specialisti per il dolore, che lavorano in modo multidisciplinare su protocolli terapeutici per i pazienti affetti da fibromialgia. Alcuni di questi studi combinavano l’educazione del paziente e/o la terapia cognitivo comportamentale con l’esercizio; nella maggior parte di questi studi è stato evidenziato alla fine del trattamento, un miglioramento significativo in una o più delle variabili cliniche considerate (37).
Attraverso una meta-analisi (38) condotta su 49 pazienti affetti da fibromialgia è stata confrontata l’efficacia di terapie farmacologiche e di trattamenti non farmacologici (terapia cognitivo comportamentale e terapia fisica) nei confronti della condizione fisica, dei sintomi, della fibromialgia, dello stato psicologico e delle capacità funzionali. Gli antidepressivi hanno determinato miglioramenti significativi sia della condizione fisica che dei sintomi soggettivi della fibromialgia.
La terapia cognitivo comportamentale del dolore, invece, ha determinato miglioramenti significativi di tutti e quattro gli aspetti, raggiungendo un risultato migliore anche rispetto al trattamento farmacologico per quanto riguarda il miglioramento dei sintomi soggettivi e l’abilità nello svolgere le normali attività quotidiane. Questa meta-analisi porta alla ragionevole conclusione che il trattamento ottimale per la fibromialgia dovrebbe includere anche i metodi cognitivo-comportamentali.
ARTICOLO CONSIGLIATO:
TUTTE LE DEFINIZIONI DI PSICOPEDIA
BIBLIOGRAFIA:
- Giesecke T, Williams DA, Harris RE, et al. (2003). Subgrouping of fibromyalgia patients on the basis of pressure- pain thresholds and psychological factors. Artritis Rheum, 48: 2916-22.
- Lessard JA, Russell IJ: Fibrositis/fybromialgia in private rheumatology practice; systematic analysis of a patient data base. 1989 (unpublished) Reported in: Fibrositis /fibromyalgia (Chapter 23), in The Clinical and Scientific Basis of Myalgia Encephalomyelitis/Chronic Fatigue. Syndrome. (1993). Editors: Hyde BM, Goldstein J, Levine P. The Nightingale Research Foundation, Ottawa, Canada.
- Russell IJ; Fibrositis/fybromialgia (Chapter 23), in The Clinical and Scientific Basis of Myalgia Encephalomyelitis/Chronic Fatigue. Syndrome. Editors: Hyde BM, Goldstein J, Levine P. The Nightingale Research Foundation, Ottawa, Canada, 1992.
- Sarzi-Puttini P, Cazzola M, Atzeni F, Stisi S. (2010). Fibromialgia, 11: 108-109.
- Moldofsky H, Scarisbrick P, England R, Smythe H. (1975). Musculosketal symptoms and non-REM sleep disturbance in patients with “fibrositis syndrome” and healthy subjects. Psychosom Med, 37: 341-51.
- Moldofsky H, Scarisbrick P, England R, Smythe H. Musculosketal symptoms and non-REM sleep disturbance in patients with “fibrositis syndrome” and healthy subjects. (1975). Psychosom Med, 37: 341-51.
- Yunus Mb, Inanici F, Aldag JC, Mangold RF. (2000). Fybromyalgia in men:comparison of clinical features with women. J Rheumatol, 27: 485-90.
- Simms RW, Goldenberg DL. (1988). Symptoms mimicking neurologic disorders in fibromyalgia syndrome. J Rheumatol; 15: 1271-3.
- Campbell SM, Clark S, Tindall EA, Forehand ME, Bennett RM. (1983). Clinical characteristics of fibrositis. I.A “blinded”, controlled study of symtoms and tender points. Arthritis Rheum; 26: 817-24.
- Jain KA, Carruthers M, Van De Sande MI, et al. (2003). Fibromyalgia Syndrome: Canadian clinical working Case Definition, diagnostic and treatment protocols – A consensus document. J Musculoske Pain, 4: 3-107.
- Grace GM, Nielson WR, Hopkins M, Berg MA. (1999). Concentration and memory deficits in patients with fibromyalgia syndrome. J Clin Exp Neuropsychol, 21: 477-87.
- Park DC, Glass JM, Minear M, Crofford LJ. (2011). Cognitive function in fibromyalgia patients. Arthritis Rheum, 44: 2125–213.
- Bangert AS, Glass JM, Welsh RC, Crofford LJ, Taylor SF, Park DC. (2003). Functional magnetic resonance imaging of working memory in fibromyalgia. Arthritis Rheum, 48: S90.
- Kuchinad A, Schweinhardt P, Seminowicz DA, Wood PB Chizh BA, Bushnell MC. (2007). Accelerated brain gray matter loss in fibromyalgia patients: premature aging of the brain? J Neurosci., 27(15):4004-7.
- Tizik C, Muezzinoglu T, Pirildar T, Taskn EO, Frat A, Tuzun C. (2005). Sexual dysfunction in female subject with fibromyalgia. J Urol, 174: 620-3.
- Prins MA, Woertman L, Kool MB, Geenen R. (2006). Sexual functioning of women with fibromyalgia. Clin Exp Rheumatol, 24: 551-61.
- Shaver JL, Wilbur J, Robinson FP, Wang E, Buntin MS. (2006). Women’s health issues with fibromyalgia syndrome. J Womens Health (Larchmt), 15: 1035-45.
- De Costa ED, Kneubil MC, Leao WC. The KB. (2004). Assessment of sexual satisfaction in fibromyalgia patients. Einstein, 2: 177-81. DOWNLOAD
- Arnold LD, Bachmann GA, Rosen R, Kelly S, Rhoads GG. (2006). Vulvodynia: characteristics and associations with comorbidities and quality of life. Obstet Gynecol, 107: 617-24.
- Gordon AS, Panahian-Jand M, McComb F, Melegari C, Sharp S. (2003). Characteristics of women with vulvar pain disorders: responses to a Web-based survey. J Sex Marital Ther, 29 (Suppl 1): 45-58.
- Bendtsen L, Norregaard J, Jensen R, Olesen J. (1997). Evidence of qualitatively altered nociception in patiens with fibromyalgia. Arthritis Rheum, 40: 98-102.
- Hudson JH, Arnold LM, Keck PE jr, et al. (2004). Family study of fibromyalgia and affective spectrum disorders. Biol Psychiatry, 56: 884-91.
- Van Houdenhove B, Neerinckx E, Lysens R et al. (2001). Victimization in chronic fatigue syndrome and fibromyalgia in tertiary care: a controlled study on prevalence and characteristics. Psychosomatics, 42: 21-8.
- Pellegrino MJ. Atypical chest pain as an initial presentation of primary fibromyalgia. Arch Phys Med Rehabil 1990; 71: 526-8
- Yunus Mb, Masi AT, Aldag JC. (1989). A controlled study of primary fibromyalgia syndrome: clinical features and associations with other functional syndromes. J Rheumatol Suppl., 19: 62-71.
- Campbell SM, Clark S, Tindall EA, Forehand ME, Bennett RM. (1983). Clinical characteristics of fibrositis. I.A “blinded”, controlled study of symtoms and tender points. Arthritis Rheum, 26: 817-24.
- Ciocci A, Buratti L, Di Franco M, Mauceri MT. (1999). L’epidemiologia delle malatie reumatiche: confronto fra i dati italiani e quelli stranieri. Reumatismo, 51 Suppl 2:201.
- Forseth KØ, Gran JT & Førre Ø. (1997). A population study of the incidence of fibromyalgia among women aged 26–55 years. British Journal of Rheumatology, 36: 1318–1323.
- White KP, Speechley M, Harth M & Østbye T. (1999). The London fibromyalgia epidemiology study: theprevalence of fibromyalgia syndrome in London, Ontario. Journal of Rheumatology, 26: 1570–1576.
- Pincus T, Callahan I & Burkhauser R. (1987). Most chronic diseases are reported more frequently by individuals with fewer than 12 years of formal education in the age 18–64 United States population. Journal of Chronic Diseases,40: 984–985.
- Oliver JE, Silman AJ. (2009). What Epidemiology Has Told Us about Risk Factors and Aetiopathogenesis in Rheumatic Disease. Arthritis Research & Therapy, 11 (3).
- Wilson H, Robinson J, Swanson K, Turk D.(2009). Emotionals factors in the onset and aggravation of Fibromyalgia symptoms: result of an internet survey. The Journ of Pain, 9 (4), Supplement 2:17.
- Berger A, Dukes E, Martin S, Edelsberg J, Oster G. (2007). Characteristics and healthcare costs of patients with fibromyalgia syndrome. Int J Clin Pract, ;61:1498-508.
- Raphael KG, Janal MN, Nayak S, Schwartz JE, Gallagher RM. (2006). Psychiatric comorbidities in a community sample of women with fibromyalgia. Pain, 124: 117 25.
- Ahles TA, Khan SA, Yunus MB, Spiegel DA, Masi AT. (1991). Psychiatric status of patients with primary fibromyalgia, patients with rheumatoid arthritis, and subjects without pain: a blind comparison of DSM-III diagnoses. Am J Psychiatry, 148: 1721-6.
- Pain. (2010), 151(2): 280-95. Epub
- Nielson WR, Walker C, McCain GA. (1992). Cognitive behavioural treatment of fibromyalgia syndrome: preliminary findings. J Rheumatol, 19: 98-103
- Rossy LA, Buckelew SP, Dorr N, et al. (1999). A meta-analysis of fibromyalgia treatment interventions. Ann Behav Med, 21: 180-91.



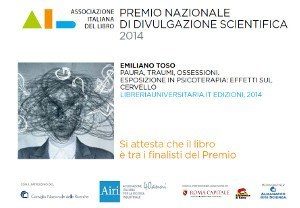 Il primo capitolo descrive l’esposizione, illustrando le diverse strategie che appartengono a questa famiglia; nonché quali elementi impediscano la sua attuazione o favoriscano la riuscita dell’intervento. Toso illustra, poi, sia efficacia dell’esposizione, sia l’impossibilità di comprendere i suoi sorprendenti effetti, poiché non sono ancora chiari i meccanismi che davvero cambiano la persona, i suoi comportamenti, la sua mente.
Il primo capitolo descrive l’esposizione, illustrando le diverse strategie che appartengono a questa famiglia; nonché quali elementi impediscano la sua attuazione o favoriscano la riuscita dell’intervento. Toso illustra, poi, sia efficacia dell’esposizione, sia l’impossibilità di comprendere i suoi sorprendenti effetti, poiché non sono ancora chiari i meccanismi che davvero cambiano la persona, i suoi comportamenti, la sua mente.