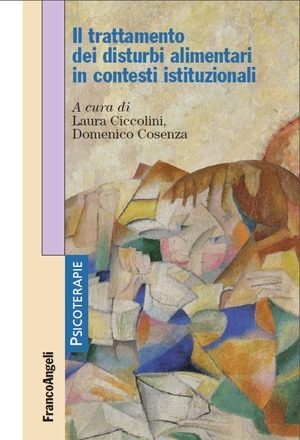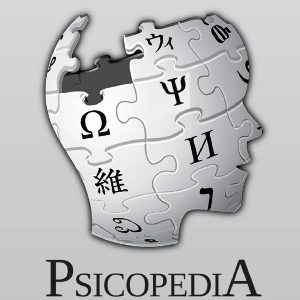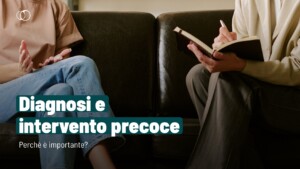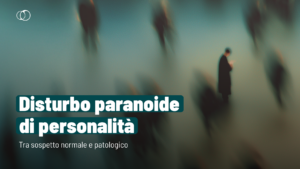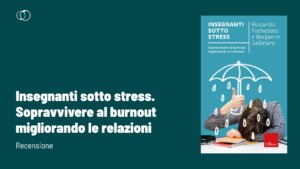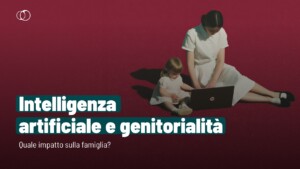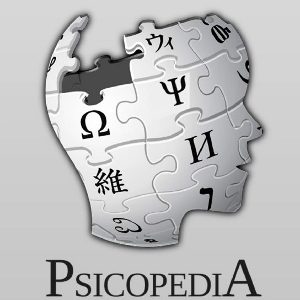Aspetti epistemologici e teorico-metodologici in Psicologia Clinica
Nell’ambito della psicologia clinica la riflessione epistemologica pone essenzialmente due grandi problematiche, ovvero come nasce e come si struttura la conoscenza, e quale rapporto esiste tra teoria e pratica all’interno di questa disciplina.
1. Il fondamento della conoscenza e i criteri di demarcazione tra “senso comune” e “senso scientifico”
Il termine epistemologia, derivante dal greco epistéme, conoscenza, e logos, discorso, può essere definito come “la branca della teoria generale della conoscenza che si occupa di problemi quali i fondamenti, i limiti, la natura e le condizioni di validità del sapere scientifico […]; è lo studio dei criteri generali che permettono di distinguere i giudizi di tipo scientifico da quelli di opinione tipici delle costruzioni metafisiche e religiose, delle valutazioni etiche”(Enciclopedia Garzanti di filosofia, 1981).
Tale definizione consente di porre in evidenza come l’epistemologia concerne il discorso generale sulla conoscenza, in quanto si occupa del fondamento, ovvero dell’apparato conoscitivo utilizzato per fondare un discorso stabilendone i criteri di validità scientifica; con il termine epistemologia, dunque, si fa riferimento al discorso sul fondamento dell’atto conoscitivo, ossia all’orizzonte paradigmatico entro il quale si situa la conoscenza. In tal senso, pertanto, si rileva come l’epistemologia non entra nel merito dei contenuti che vengono riferiti agli oggetti di conoscenza, bensì riguarda le modalità attraverso le quali essi vengono conosciuti , consentendo di delineare i confini entro cui un atto conoscitivo può essere considerato scientifico.
Al fine di esplicitare quest’ultimo aspetto, si ritiene pertinente introdurre alcune considerazioni relative ai criteri di demarcazione tra due modalità di conoscenza distinte: il senso comune ed il senso scientifico. In tale direzione, con il termine senso comune si intende “proposizioni di qualsiasi natura e tipologia che definiscono e sanciscono qual è la realtà; in questo senso, è la forza retorica dell’argomentazione che rende reale ciò di cui si parla, configurandolo come “realtà di fatto” […] Il “senso comune” manifesta autoreferenzialità nella propria legittimazione, ovvero si auto-legittima a prescindere dal fondamento delle sue affermazioni e dall’esplicitazione delle categorie conoscitive messe in campo […] risulta organizzatore di stereotipi e pregiudizi ed è trasversale a ruoli e contesti”(Turchi G.P., Della Torre C., 2006).
A fronte della definizione testè esposta si evidenzia come un discorso di senso comune, avvalendosi della sua autoreferenzialità, non è sottoposto a criteri di fondatezza epistemologica, ovvero “ciò che viene affermato dal senso comune diviene immediatamente reale, non chiedendo pertanto l’esplicitazione dei presupposti dell’atto conoscitivo posto in essere” (ibidem). In virtù di ciò, quindi, un discorso di senso comune non risulta passibile di confutazione attraverso un procedimento logico o empirico, bensì esso può essere smentito soltanto da un punto di vista dialettico, attraverso l’affermazione di una realtà differente.
Nell’ambito del senso comune il linguaggio utilizzato è quello ordinario, ossia un linguaggio i cui significati sono costruiti nell’interazione dei parlanti, attraverso cui si stabilisce qual è la realtà ed il significato di ciò che si nomina nel momento stesso in cui lo si nomina. Il linguaggio del senso comune, dunque, si compone di affermazioni che risultano non fondate a livello epistemologico né argomentate, contrariamente al linguaggio del senso scientifico che, viceversa, può essere definito come “l’insieme di asserzioni che risultano fondate e argomentate, in cui cioè si definisce con rigorosità il significato attribuito ad ogni termine utilizzato, che risulta univoco e condiviso da tutti gli appartenenti alla disciplina scientifica che utilizza uno specifico linguaggio tecnico”(ibidem).
In tal senso, quindi, mentre il senso comune si compone di affermazioni, il senso scientifico utilizza asserzioni, il cui fondamento e le cui categorie conoscitive necessitano di essere esplicitate ed argomentate. In virtù delle definizioni testé presentate, pertanto, emerge che “la demarcazione tra senso scientifico e senso comune risiede nella rigorosità dell’argomentazione, nella fondatezza epistemologica e nella rigorosità metodologica adottata”(Turchi G.P., Della Torre C., 2006).
Nell’ambito del senso scientifico, inoltre, è possibile distinguere diverse modalità di conoscenza, individuabili in base ai suffissi dei nomi che identificano le discipline che si rifanno a tali modalità, e differenziabili in base al linguaggio da esse utilizzato; a tal fine si rileva che mentre le scienze a suffisso ‘-ica’ e ‘-nomos’ coniano un linguaggio proprio, estraneo a quello comunemente utilizzato nella comunità dei parlanti, quindi utilizzano un linguaggio tecnico, formalizzato, avente un valore simbolico convenzionalmente stabilito a priori, viceversa le scienze a suffisso ‘-logos’ non coniano un linguaggio proprio, bensì utilizzano il linguaggio ordinario.
A fronte di quanto argomentato si ritiene pertinente evidenziare che, pur differenziandosi rispetto al linguaggio utilizzato, le tipologie di scienza sopra descritte (‘-ica’, ‘nomos’ e ‘logos’) condividono l’appartenenza ad un contesto scientifico. In merito a ciò, al fine di operare una demarcazione tra un discorso di senso scientifico ed un discorso di senso comune, l’epistemologia consente di delineare i criteri in virtù dei quali si rende possibile operare una distinzione tra le modalità di conoscenza scientifica e le affermazioni di senso comune; tali criteri di demarcazione sono stabiliti in relazione al tipo di scienza implicato ed al linguaggio (ordinario o formale) da essa utilizzato.
Nelle scienze ‘-ica’ e ‘-nomos’, in virtù del fatto che esse fanno riferimento ad oggetti di conoscenza rappresentati da enti fattuali i quali, in quanto tali, risultano empiricamente rilevabili e quantificabili, i criteri di demarcazione sono rappresentati dall’individuazione dell’oggetto di conoscenza e dalla precisione delle misurazioni che su di esso si compiono. In maniera differente, nell’ambito delle scienze a suffisso ‘-logos’, quindi nelle scienze discorsive, poichè gli oggetti di conoscenza non si collocano sul piano empirico-fattuale e quindi non esistono indipendentemente dal discorso che li genera in quanto tali, i criteri di demarcazione sono specificati dal rigore dell’argomentazione e dall’adeguatezza epistemologica del discorso rispetto all’oggetto di indagine posto dalla disciplina.
A quest’ultima tipologia di scienza appartiene la psicologia che, in quanto logos sulla psiche, al fine di rispettare i criteri di rigorosità argomentativa e di fondazione epistemologica che sanciscono l’appartenza di tale disciplina all’ambito del contesto scientifico, e non a quello del senso comune, necessita di definire precisamente l’oggetto di indagine e il piano epistemologico entro cui esso si colloca. In riferimento a quest’ultimo aspetto, il paragrafo seguente si dipana attraverso la trattazione delle differenti cornici epistemologiche, ovvero i “livelli di realismo” individuati dalla riflessione epistemologica contemporanea.
2. I livelli di realismo all’interno della riflessione epistemologica
Nell’ambito della psicologia clinica la riflessione epistemologica pone essenzialmente due grandi problematiche, ovvero come nasce e come si struttura la conoscenza, e quale rapporto esiste tra teoria e pratica all’interno di questa disciplina. In merito a ciò, si rende necessario considerare che in psicologia clinica ogni operazione conoscitiva colloca al centro della riflessione non solo l’oggetto di indagine, ma anche lo psicologo e i suoi assunti teorico-metodologici, in quanto le strategie conoscitive risultano necessariamente intersecate agli eventi osservati. In virtù di ciò, quindi, si evidenzia che “la riflessione epistemologica non è per lo psicologo un lusso da lasciare alla speculazione dotta o occasionale, dal momento che egli è comunque implicato in atti conoscitivi che lo rinviano a diverse configurazioni della realtà: a quelle del suo interlocutore e alle proprie in quanto ricercatore o clinico”(Salvini A., 1998).
In merito a quest’ultimo aspetto si ritiene rilevante mettere in luce che, come esposto in precedenza , affinché una disciplina possa dirsi scientifica, è necessario che vi sia una riflessione epistemologica che consente di poter stabilire la fondatezza degli assunti teorici ai quali si fa riferimento e l’adeguatezza dell’argomentazione rispetto all’oggetto di indagine posto. Questa operazione di fondazione epistemologica consiste nell’inscrivere l’oggetto di indagine in una adeguata cornice conoscitiva prima che teorica, in quanto è in virtù della corretta collocazione dell’oggetto d’indagine entro il piano epistemologico a cui esso appartiene che si rende possibile operare una scelta adeguata in termini di modalità di conoscenza utilizzate e di prassi operative adottate.
In riferimento a quanto sopra delineato, attualmente la riflessione epistemologica consente di individuare tre “livelli di realismo”(Salvini A., 1998), i quali corrispondono a tre concezioni di realtà implicanti differenti modalità di conoscenza, coerenti con quanto si assume essere reale; in tal senso, quindi, a seconda del livello di realismo al quale si fa riferimento ne consegue un differente modo di conoscere in quanto, in virtù della prospettiva epistemologica attraverso cui si procede ad indagare i fenomeni, consegue una diversa configurazione della realtà.
Al fine di esplicitare quanto sopra delineato, si procederà ora a fornire una definizione delle assunzioni epistemologiche su cui si basano i cosiddetti livelli di realismo, ovvero dei presupposti sui quali si basa la conoscenza scientifica. I livelli di realismo individuati sono denominati “realismo monista”, “realismo ipotetico” e “realismo concettuale”.
A livello di “realismo monista” (ontologico, o ‘ingenuo’) si assume che la realtà ‘c’è’ in quanto data a livello ontologico. Entro tale livello di realismo l’oggetto di conoscenza viene individuato come ente fattuale, il quale esiste a prescindere dal conoscente e dalle categorie di conoscenza utilizzate, e l’obiettivo della conoscenza scientifica riguarda l’essenza dell’oggetto, la conoscenza della realtà ultima, con la quale la conoscenza stessa è perfettamente sovrapponibile. In virtù di ciò, l’osservazione è intesa come la fotografia di una realtà esistente di per sè, indipendentemente dal processo di osservazione, in modo tale che vi è un rapporto di isomorfismo tra conoscenza e realtà.
Secondo la prospettiva del realismo monista, dunque, la realtà è indipendente dal soggetto che la conosce, e la concettualizzazione e l’elaborazione teorica seguono l’osservazione, in quanto la realtà è configurata come un dato certo, un dato a-priori, misurabile in maniera oggettiva, indipendente da chi compie la misurazione e soggetto alla legge di causa-effetto, come prescritto dal Paradigma Meccanicistico. Secondo tale Paradigma, infatti, le categorie concettuali dell’osservatore sono ininfluenti rispetto all’oggetto di osservazione, la cui realtà è univoca, non ambigua, misurabile, e gli esperimenti effettuati sugli enti sono riproducibili, a parità di condizioni, in qualsiasi momento e da chiunque. Il dato è considerato come cosa in sé, in esso coincidono la realtà e l’ente oggetto di studio, ed è certo lo statuto ontologico di tale ente. L’attenzione è rivolta al dato empirico e la ricerca scientifica è finalizzata a definire “un sistema di conoscenza che sia isomorfo alla realtà stessa”(Salvini A., 1998).
Il secondo livello di realismo individuato dalla riflessione epistemologica è il cosiddetto “realismo ipotetico”, in cui la realtà, pur essendo postulata come ontologicamente esistente, rimane inconoscibile direttamente. Entro tale livello di realismo, dunque, viene ipotizzata l’esistenza di una realtà esterna e indipendente dall’osservatore, ma si assume che tale realtà possa essere conosciuta soltanto attraverso le categorie concettuali e teoriche utilizzate dall’osservatore stesso. Secondo la prospettiva del realismo monista, quindi, sebbene la realtà esista indipendentemente dalle teorie, l’accesso ad essa non è diretto, bensì risulta mediato dalle “mappe della ragione”(ibidem), ovvero dagli assunti paradigmatici, dalle teorie, dai metodi e dagli strumenti adottati dal ricercatore per avvicinarsi a tale realtà; in tal senso, ne consegue che “ciò che è conoscibile è la mappa, cioè le teorie, mentre il territorio, cioè la “realtà in sè”, non si può conoscere”(ibidem). In conseguenza di tali presupposti, pertanto, le teorie, ovvero la conoscenza, non possono essere isomorfe rispetto alla realtà, bensì il rapporto tra conoscenza e realtà è del tipo “come se”.
A fronte di quanto argomentato assume rilevanza mettere in luce che il realismo ipotetico, rientrando in una prospettiva epistemologica “pluralista”(ibidem), non dà per scontata l’esistenza di una realtà unica, data, univoca e accessibile all’osservatore che, separato da essa, la misura ed analizza senza pregiudizi di sorta. Al contrario, l’accesso al mondo non è mai diretto, bensì viene mediato da una pluralità di assunti paradigmatici, teorie, metodi e strumenti che influenzano l’accesso al reale, il quale dipende dalle scelte teoriche adottate dall’osservatore stesso, da cui non può prescindere (Salvini A., 1998).
Metaforicamente, quindi, “le teorie e i modelli adottati stanno alla realtà che tentano di descrivere e spiegare come una mappa geografica sta al territorio. La costruzione di una mappa fa si che il territorio perda il suo carattere di insieme incoerente di fenomeni o di cose, entrando nei domini della ragione. Tuttavia pur essendo postulata come realtà, il territorio rimane inaccessibile”(ibidem).
Infine, differentemente da quanto postulato dai livelli di realismo finora delineati, nel livello di “realismo concettuale” la realtà non è intesa come esistente ontologicamente, bensì si assume che essa è discorsivamente costruita nell’atto stesso di conoscere, attraverso le categorie concettuali che il conoscente utilizza. Entro il livello di realismo concettuale, dunque, la realtà non viene configurata come esistente in quanto dato ontologico, bensì come costruita a partire dalle categorie di conoscenza che si utilizzano per descriverla in quanto tale. Tale livello di realismo, pertanto, postula l’impossibilità di distinguere tra conoscente e conosciuto, in quanto sono le modalità di conoscenza che stabiliscono il come e il cosa si conosce. In conseguenza di ciò, l’attenzione non è posta sui contenuti (il ‘conosciuto’), bensì sui processi di costruzione della realtà, ossia sulle modalità conoscitive messe in atto dall’individuo. All’interno di tale posizione epistemologica, quindi, gli oggetti di conoscenza sono dipendenti dai discorsi che li generano, in quanto la realtà non è data, bensì risulta costruita dalle categorie attraverso cui la si conosce in quanto tale.
In virtù di quanto testé delineato in merito agli assunti su cui si basa il realismo concettuale, assume ora rilevanza evidenziare la relazione di interdipendenza esistente tra il piano epistemologico entro cui si colloca l’oggetto di indagine di una disciplina ed il riferimento paradigmatico adottato dalla medesima. A tal fine si rileva che, a fronte della collocazione della realtà entro un piano epistemologico concettuale è necessario considerare che, affinché sia possibile intervenire in maniera scientifica rispetto a tale realtà, si pone la necessità di inserire la teoria di riferimento entro una cornice paradigmatica coerente con il piano epistemologico implicato. Il riferimento ad un livello di realismo concettuale, infatti, poggiando su assunzioni epistemologiche altre rispetto a quelle del realismo monista ed ipotetico, consente di abbandonare il Paradigma Meccanicistico per adottare un paradigma alternativo, definito Narrativistico. All’interno della posizione epistemologica entro la quale si situa il Paradigma Narrativistico viene sostenuta l’impossibilità di intendere la conoscenza come specchio di una realtà di fatto, esterna all’atto conoscitivo stesso, ossia ci si allontana dalla definizione di teoria come riproduzione fedele dell’oggetto di indagine, bensì si assume che la scienza è basata su “presupposti” (Bateson G., 1984), i quali guidano e costruiscono il pensiero scientifico.
Entro la posizione gnoseologica del realismo concettuale, infatti, l’osservatore e il teorico vengono considerati all’interno del sistema di conoscenza, in quanto si postula che le teorie scientifiche derivano e si generano in virtù dei presupposti conoscitivi dello scienziato; in conseguenza di ciò, l’attenzione non è posta su ciò che viene conosciuto, ovvero sui contenuti, viceversa è rivolta all’analisi delle modalità di conoscenza messe in atto dal conoscitore, ossia all’analisi dei processi di costruzione di ciò che viene considerato come reale.
Alla luce di quanto esposto relativamente alle assunzioni epistemologiche proprie di ciascun livello di realismo, nel paragrafo seguente si procederà a fornire una definizione del termine paradigma.
3. Paradigma, teoria e modello operativo
Nei paragrafi precedenti è stato evidenziato come una disciplina, al fine di produrre una conoscenza rientrante in una dimensione di senso scientifico e non, viceversa, nell’alveo del senso comune, necessita di utilizzare modalità di conoscenza adeguate rispetto alle assunzioni conoscitive del piano epistemologico entro cui si colloca l’oggetto di indagine della disciplina stessa. Sulla base di tale presupposto consegue che specifiche modalità di conoscenza risultano adeguate, e quindi scientificamente applicabili, rispetto a certi ambiti di indagine ed oggetti di conoscenza e non rispetto ad altri, in virtù della collocazione epistemologica degli stessi.
A fronte di quanto testé considerato, assume ora rilevanza fornire una definizione del termine paradigma. Per paradigma si intende un modo di conoscere, il quale fornisce le assunzioni, ovvero gli elementi di cornice, su cui si basa e si costruisce la conoscenza relativa all’oggetto di indagine e “viene definito attraverso concetti, legami tra concetti e teorie”(Turchi G.P., Ciardiello P., 2005).
Un paradigma si colloca entro un peculiare livello di realismo, e comporta una configurazione della realtà ed una definizione delle metodologie utilizzate per conoscerla; in virtù di ciò, scegliere di fare riferimento ad un paradigma piuttosto che ad un altro implica individuare un peculiare sistema di riferimento attraverso cui organizzare la conoscenza, ovvero “individuare un ‘mondo’ anziché un altro”(Turchi G.P., Ciardiello P., 2005) .
In merito quanto sopra esposto, inoltre, si ritiene pertinente considerare che dall’utilizzo coerente degli assunti paradigmatici è possibile produrre diverse teorie, ognuna delle quali risulta caratterizzata da un proprio assunto teorico; per teoria si intende “la formulazione sistematica degli assunti concettuali relativi ad una scienza, di per sé indiscutibili, legati tra loro da relazioni logiche, quantitative o di altro tipo”(Turchi G.P., Ciardiello P., 2005). Quindi, mentre la teoria definisce il cosa si conosce, il paradigma specifica il come si conosce, in quanto si configura come una cornice conoscitiva che consente l’albergare al suo interno di differenti teorie, e delimita le modalità di conoscenza in virtù delle quali diviene poi possibile operare.
In relazione a quest’ultimo aspetto, assume rilevanza evidenziare come il livello operativo relativo ad un determinato ambito di indagine costituisce la diretta emanazione non soltanto degli assunti teorici, ma prima di tutto paradigmatici, su cui si basa e si costruisce la conoscenza relativa all’oggetto di indagine stesso. In conseguenza di ciò si rileva che, al fine di disporre di prassi operative in grado di porre obiettivi perseguibili ed adottare strategie efficaci per raggiungerli, è necessario il riferimento ad una cornice paradigmatica epistemologicamente fondata rispetto all’oggetto di indagine, in quanto è all’interno di un preciso paradigma che nasce e si adagia il modello operativo. Il modello può essere definito come “un riferimento operativo che si basa su una precisa concezione teorica e si sostanzia in prassi operative, intese come insieme di operazioni di azioni concrete” (Turchi G.P., Ciardiello P., 2005).
E’ dunque sulla base del modello, formato da un insieme di assunti teorici e di prassi coerenti, che è possibile intervenire nella realtà, “oggettiva o costruita che sia”(ibidem). Il modello, infatti, assolve in genere due funzioni, una conoscitiva, esplicitata dagli assunti teorici, ed una operativa, corrispondente alle prassi utilizzate. Sulla base delle definizioni testè esposte, pertanto, emerge che ciò che sancisce l’efficacia e la storicità di un modello è la corrispondenza tra teoria e operazioni, è ciò che stesso, “ovvero quanto le prassi operative sono in grado di dare realtà all’assunto teorico e di divenirne l’enunciazione”(ibidem).
A fronte di quanto sopra delineato si rende ora rilevante considerare che un determinato modello si riferisce soltanto ad una certa classe di eventi, configurati attraverso le sue “categorie logico-concettuali e procedimenti formali di rappresentazione”(Salvini A., 1998), in quanto le specifiche modalità di conoscenza, rese disponibili dal paradigma ed adottate all’interno del modello, sono adeguate rispetto a certi oggetti di indagine e non altri, in virtù del piano epistemologico entro cui tali oggetti sono collocati; in tal senso, quindi, “se un modello (o una teoria) è adeguato a spiegare un certo problema, diverrà inutilizzabile su altri piani di realtà o per altri oggetti configurati entro altre categorizzazioni conoscitive”(ibidem).
Sulla base di tale presupposto, si evidenzia la necessità di operare una valutazione relativa alla coerenza tra gli assunti teorici, ovvero le modalità di conoscenza proprie di un determinato modello, ed il piano epistemologico entro cui si colloca l’oggetto dell’indagine; si rende necessario interrogarsi, quindi, sulla fondatezza epistemologica e correttezza metodologica sottese all’applicazione delle categorie conoscitive di un determinato modello rispetto all’oggetto verso cui ci si propone di intervenire.
In conseguenza di quanto argomentato, inoltre, emerge che la rilevanza del modello (o della teoria) è generata dalla pertinenza o adeguatezza dello stesso rispetto ad una certa classe di eventi piuttosto che ad un’altra; viceversa, il trasferimento e l’utilizzo di conoscenze e riferimenti peculiari di una disciplina ad un’altra disciplina genera un “uso spurio” (ibidem) del concetto di modello . A fronte di quanto testé argomentato, assume rilevanza mettere in luce che il processo di trasposizione di un modello pone la necessità di operare una riflessione epistemologica relativa sia all’adeguatezza ed alla pertinenza di determinati metodi o concetti rispetto al peculiare ambito conoscitivo considerato, sia alla possibilità di rispettare le implicazioni metodologiche delle categorie conoscitive mutuate.
In virtù di quanto sopra delineato, pertanto, emerge che, affinché la mutazione di categorie e modalità conoscitive da un ambito disciplinare ad un altro sia descrivibile come ‘operazione scientifica’, non è possibile eludere tale riflessione epistemologica.
ARTICOLO CONSIGLIATO:
Verso la Neuroestetica: le premesse filosofico-psicologiche
BIBLIOGRAFIA:
- Bateson G. (1979). Mind and nature, tr.it. Mente e natura, Adelphi, Milano, 1984
- Kuhn T.S. (1969). La struttura delle rivoluzioni scientifiche, Einaudi, Torino, 1999
- Turchi G.P., Ciardiello P. (2005). Reato e identità. Implicazioni epistemologiche ed operative, Upsel Domeneghini Editore, Padova
- Turchi G.P., Della Torre C. (2006). Psicologia della Salute. Dal modello bio-psicosociale al modello dialogico. Armando, Roma
- Salvini A. (1988). Pluralismo teorico e pragmatismo conoscitivo: assunti meta-teorici in psicologia della personalità, in Fiora E., Pedrabissi I., Salvini A., Pluralismo teorico e pragmatismo conoscitivo in psicologia della personalità, Giuffrè Milano