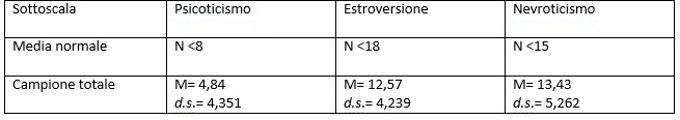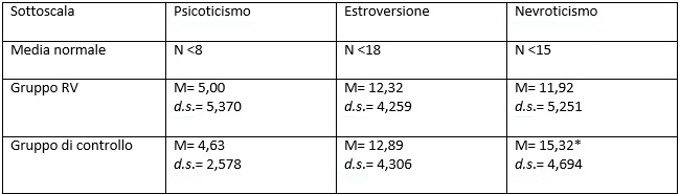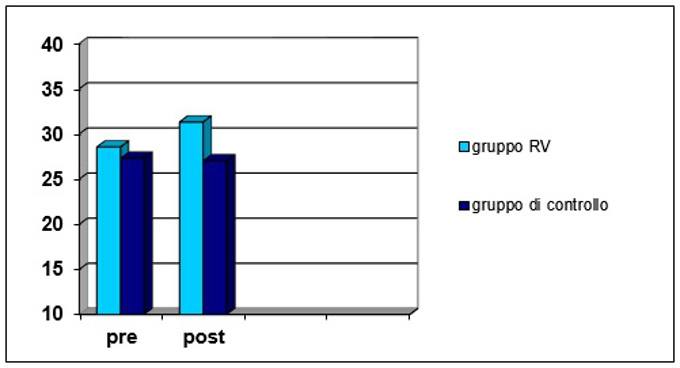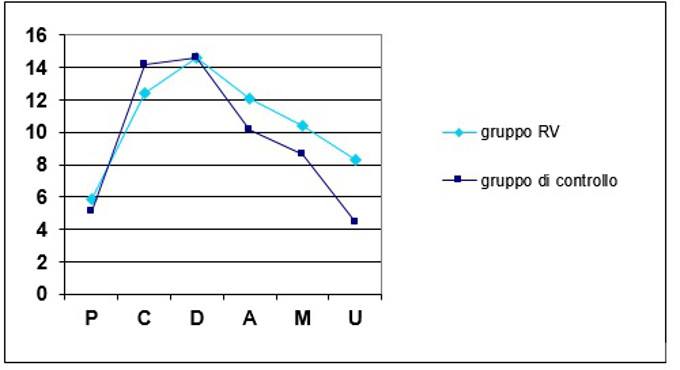Il nuovo ruolo degli utenti dei Servizi di Salute Mentale
Nel corso degli ultimi decenni il ruolo di utente di un servizio medico è cambiato radicalmente, e questo è accaduto anche per i Servizi di Salute mentale, sia in Italia che all’estero. Il fatto per esempio di essere consumatori dà il diritto di esprimere un’opinione su ciò che viene prodotto e consumato, si tratti di cibo, trasporti o sanità. Esprimere la propria opinione significa in qualche modo avere la possibilità, quantomeno teorica, di orientare politiche che attengono alla propria vita e di partecipare in maniera più o meno incisiva ai processi decisionali che ci riguardano direttamente (Agnetti, 2007).
Elena Sirotti, OPEN SCHOOL MODENA
Lo sviluppo nel campo sanitario del movimento dei consumatori, cioè dei cittadini utenti come soggetto collettivo e organizzato che agisce come attore sociale (Crozier & Friedberg, 1977), va inquadrato in dinamiche sociali che si situano a livello di macromutamenti e che in quanto tali hanno una forza incontrastabile, pur considerando la situazione di profonda ambiguità e disparità di potere in cui si trova il consumatore dell’offerta sanitaria. Nell’ambito della salute mentale, inoltre, diversi sono gli obiettivi dei gruppi di consumatori in base alla patologia che li accomuna.
Coloro che soffrono di depressione, disturbi alimentari, sindromi ansiose frequentemente considerano il proprio disturbo come una malattia, al pari di quelle fisiche, senza mettere in discussione i modelli interpretativi dei disturbi di cui soffrono e non pongono in agenda temi relativi ai diritti collettivi. Molti di questi gruppi sono attivi nel raccogliere fondi, organizzare e promuovere Servizi, esprimendo a volte critiche e dissenso sulla qualità dei trattamenti o sull’allocazione delle risorse, senza però contestare i fondamenti della psichiatria.
Le persone che invece soffrono di problemi psicotici o disturbi di personalità, al contrario, non sempre accettano lo status di “malattia” della loro condizione o ne ridefiniscono i contenuti, spesso mettono in discussione il modello psichiatrico e hanno come interesse principale i diritti, lo stigma, l’autodeterminazione, la definizione di “malattia mentale”, differenziandosi in questo modo da buona parte dei consumatori in campo sanitario.
Il cambiamento nei servizi di Salute Mentale
Vi sono periodi storici in cui avvengono capovolgimenti radicali in grado di mutare paradigmi e prospettive: è ciò che si è verificato negli ultimi cinquant’anni, con la fine dell’epoca dei manicomi e la nascita della psichiatria di comunità ed è ciò che sta accadendo oggi con lo sviluppo dei movimento di utenti con disturbi psichici gravi.
Il fenomeno è iniziato una cinquantina di anni fa con l’entrata in campo delle associazioni dei familiari. Dapprima in Francia nel 1964 con l’Union Nationale des amis et des familles des malades mentaux, poi in Inghilterra nel 1971 con la National Schizophrenia Fellowship e nel 1978 negli Stati Uniti con la National Alliance for the Mentally Ill. Si tratta di organizzazioni che hanno raggiunto livelli di potere rilevante, anche dal punto di vista economico e che hanno contribuito a far conoscere e far emergere nuovi punti di vista sui disturbi mentali, aumentando consapevolezza e tolleranza nelle comunità, influenzando la politica e le strategie dei Servizi di Salute Mentale e divenendo una forza di pressione anche politica senza precedenti (Agnetti, 2006).
Pur riconoscendo l’importanza del loro ruolo, anche come apripista, e le sue implicazioni, bisogna tenere presente che tra i movimenti dei familiari e quelli degli utenti esiste una distanza incommensurabile. Questa è dovuta alla diversa posizione occupata e ai punti di vista differenti, e spesso contrastanti, riguardo ad interessi e valori.
Per le persone sofferenti di disturbi mentali impersonare il ruolo di cittadino utente e attore sociale è stato un cammino più difficile, irto di ostacoli, non ultimo il dover pagare uno scotto storico e implicito alla psichiatria, connesso all’idea che le persone con sofferenza psichica non siano del tutto autonome e soprattutto non siano titolari d’indipendenza di giudizio e attitudine critica rispetto al proprio malessere e quindi ai modi per affrontarlo.
A dispetto di ciò, negli ultimi decenni vi è stato un proliferare di gruppi e organizzazioni di utenti, apparentemente divisi ma nel complesso in grado di acquisire una presenza sempre più visibile in molte parti del mondo, sponsorizzando convegni nazionali e internazionali, partecipando a incontri e congressi su argomenti psichiatrici, sedendo a tavoli in cui si discutono e decidono aspetti di politica sanitaria (Agnetti, 2007).
In Germania un’accentuata spinta alla centralizzazione e una maggiore capacità organizzativa hanno favorito la nascita di una solida associazione nazionale che per le sue dimensioni non ha rivali in Europa, il Bundesverband Psychiatrie Erfahrener. Questa associazione, pur portando avanti con forza posizioni in contrasto con la psichiatria ufficiale, è finanziata dal ministero della salute tedesco ed è considerata un vero e proprio interlocutore dagli amministratori, come altre realtà nei Paesi del nord Europa.
In tutti gli stati degli USA non è raro per gli utenti essere coinvolti nella gestione dei Servizi o gestire in proprio Servizi veri e propri.
In Australia e Nuova Zelanda gli utenti organizzati hanno raggiunto uno status riconosciuto, tanto che la loro presenza come partecipanti ai processi di accreditamento dei Servizi è ormai elemento indispensabile.
La forza del movimento nel suo insieme è notevole, nonostante i gruppi non siano omogenei tra loro e mantengano punti di vista e prospettive differenti, con obiettivi e strategie distinti. Alcuni gruppi si costituiscono prevalentemente come centri di aggregazione, auto-aiuto e promozione dei diritti, altri si pongono in un’ottica di integrazione rispetto ai Servizi Psichiatrici, altri ancora portano avanti l’ambizione di creare Servizi alternativi o di sostenere concezioni e ricerche sui disturbi mentali che si scostino radicalmente da quelle ufficiali, altri infine si pongono in un’ottica di sfida e denuncia rispetto alle pratiche e all’establishment psichiatrico.
Tuttavia questo elemento di divisione anche aspra è fonte di ricchezza e possibilità di confronto.
Mentre nel mondo anglosassone e nel nord Europa l’associazionismo degli utenti è una realtà con cui fare i conti, in Italia, come in tutta l’Europa meridionale, il movimento sta faticosamente emergendo e muovendo i primi passi. Analogamente a ciò che è successo in tutte le parti del mondo, sono stati i familiari ad andare avanti per primi, in nome degli interessi dei loro parenti.
L’occasione di costituirsi come gruppo di pressione è stata fornita dalla chiusura degli ospedali psichiatrici, che ha innescato processi all’inizio rivendicativi ma ben presto approdati a posizioni più mature e costruttive, determinando un risveglio di consapevolezza intorno alle questioni che riguardano i disturbi mentali e le loro cure. Per le persone sofferenti di patologie mentali, anche in Italia, il cammino è stato ed è molto difficile causando un inevitabile ritardo, rispetto ai familiari, nell’assumere un ruolo sociale. Negli ultimi anni tuttavia lo sviluppo di gruppi di utenti organizzati, più o meno in contiguità con gli operatori dei Servizi e le associazioni di familiari, ha preso gradualmente corpo, nonostante molte difficoltà legate a vari fattori culturali, economici, organizzativi e normativi (Re, 2005).
Tra gli ostacoli di ordine culturale bisogna annoverare una scarsa abitudine, fino a poco tempo fa, da parte dei cittadini italiani a esercitare un ruolo partecipativo al di fuori delle tradizionali organizzazioni politiche e sindacali. Inoltre, per quanto riguarda l’offerta sanitaria, la diffusa subordinazione al potere medico con oscillazioni tra atteggiamenti passivi di dipendenza e atteggiamenti rivendicativi, spesso connessi a campagne mediatiche, ha reso difficile per l’utente un ruolo reale e concreto di tipo contrattuale e partecipativo. È anche necessario aggiungere che non esistono, al momento attuale, politiche di sostegno alle associazioni di utenti, come invece succede in altri Paesi dell’Unione Europea. Vi sono infine fattori specifici, riguardanti il contesto psichiatrico italiano, l’assetto dei Servizi di salute mentale e il rapporto tra operatori e utenti. L’influenza di Basaglia, che dalla fine degli anni Sessanta ai primi anni Ottanta ha alimentato la crescita culturale di buona parte degli operatori e ha influito sulla riforma della psichiatria italiana, ha comportato una forte spinta etica e una sensibilità nei confronti delle violazioni dei diritti e delle pratiche violente quali l’elettroshock, la contenzione e in qualche misura anche il ricovero obbligatorio.
Nonostante vi sia a volte un divario, spesso misconosciuto dagli stessi operatori, tra le pratiche e i comportamenti ammissibili e quelli che vengono effettivamente messi in atto, la cornice concettuale dell’assetto psichiatrico italiano garantisce più che in altri Paesi un certo rispetto dei diritti.
L’abolizione dei manicomi e l’impossibilità di accogliere nelle comunità senza consenso, eliminando in pratica la detenzione forzata a lungo termine in ambito psichiatrico, sono state importanti garanzie su cui si è costruita una pratica più umana e attenta alla persona, che ha facilitato i rapporti di fiducia e vicinanza tra operatori e utenti, rendendo più inconsueto per gli utenti prendere posizioni critiche, in modo autonomo e organizzato, nei confronti dell’offerta di cura.
I Servizi di Salute Mentale oggi: la riabilitazione partecipata
Nell’insieme, a parte alcune eccezioni, i Servizi di salute mentale diventano facilmente punti di riferimento costante e molti sono inclini a sviluppare pratiche di riabilitazione partecipata.
Per questo motivo in Italia vi è una cultura consolidata del fare insieme e, in questa prospettiva, troviamo da più parti gruppi di auto-aiuto con la presenza di operatori dei Servizi di salute mentale in qualità di facilitatori e gruppi misti di utenti, familiari e operatori (Cirri, 1997).
Questo fenomeno è in crescita e come spesso avviene quando s’introducono cambiamenti, dopo una partenza stentata e vacillante, inaspettatamente si innescano sviluppi che non è possibile arrestare.
La presenza di un movimento degli utenti è destinata a introdurre profonde modifiche nel rapporto tra Servizi e utenti e tra operatori e soggetti affetti da disturbi psichiatrici. Alcuni elementi sono già delineati: innanzitutto un aumento della contrattazione a tutti i livelli, da quello più intimo dell’interpretazione del malessere e della gestione dei provvedimenti terapeutici, di cui la farmacoterapia è solo un aspetto, a quello della politica e dell’organizzazione dei Servizi, con la conseguente incorporazione di altri punti di vista che mettono in crisi il potere clinico con le sue esclusive prerogative di definizione e decisione (Agnetti, 2007).
È evidente che fare i conti con il movimento degli utenti significa accettare sfide difficili e allora, perché mai farlo? Vi sono ragioni a favore che sono etiche, politiche, scientifiche e cliniche. Dal punto di vista etico vi è il dovere di dare ascolto e voce agli interessati, senza contare il fatto che questo è ormai un imperativo storico da cui non è possibile esimersi. In termini di politica sanitaria è necessario riconoscere che non solo i Servizi Psichiatrici formali, ma neppure il mondo del privato sociale e della cooperazione possono ambire a governare programmi e progetti senza prendere in considerazione il punto di vista degli utenti sull’erogazione dei Servizi di salute mentale e su ciò che viene da loro esperito come importante.
Infine vi sono le ragioni scientifiche e cliniche: le ricerche ci dimostrano che il coinvolgimento delle persone nelle decisioni che le riguardano e il fatto di poter esercitare un ruolo attivo rispetto alla propria cura producono esiti migliori. Inoltre, tener conto delle valutazioni degli utenti e della loro esperienza soggettiva rispetto a sofferenza e cure migliora da un lato l’adesione al trattamento e dall’altro la comprensione clinica, per la quale è indispensabile cogliere le dimensioni significative dell’esperienza soggettiva (Bentall, 2003).
In un certo numero di Paesi l’affermarsi del movimento degli utenti ha modificato l’importanza data alle esigenze dei soggetti destinatari del Servizio di assistenza ed ha influenzato le politiche della salute mentale. Esso ha fatto aumentare in particolare, l’inserimento di persone affette da disturbi mentali nel sistema tradizionale di salute mentale ed in altri Servizi sociali. Tra i programmi gestiti dagli utenti figurano centri di consultazione senza appuntamento, programmi di presa in carico di casi, programmi periferici e Servizi di crisi.
È evidente che le associazioni degli utenti di tutto il mondo vogliono che la loro voce sia udita e presa in considerazione nelle decisioni inerenti la loro vita. Gli individui affetti da disturbi mentali hanno il diritto di farsi sentire nel dibattito sui princípi e le pratiche di salute mentale ai quali partecipano i professionisti, le famiglie, il legislatore ed i leader di opinione. Al di là delle etichette e delle diagnosi, si tratta di persone “a tutto tondo”, che, malgrado ciò che possono pensare gli altri, hanno idee, opinioni, speranze ed ambizioni (Chamberlin, 2004).
Per molti Autori (Kennedy, 2003) gli utenti sono da considerare degli esperti e prendere in considerazione la loro prospettiva è doveroso per motivi etici. L’esperienza che gli utenti acquisiscono circa la malattia e le cure viene infatti ritenuta insostituibile. Negli expert patient programs creati dal Chief Medical Officer del Regno Unito nel 1999, ad esempio, alcuni utenti di Servizi Sanitari affetti da patologie croniche vengono coinvolti nell’educazione degli operatori sanitari e degli altri utenti (Faulkner & Thomas, 2002). Tale approccio, nel quale la responsabilità dei Servizi Sanitari viene condivisa con la comunità, si ispira all’organizzazione dell’assistenza sanitaria in alcuni paesi del terzo mondo (McKenzie et al., 2004; Battersby, 2004).
Vi sono evidenze preliminari che suggeriscono come vi possa essere un effetto positivo sulla qualità dei Servizi di Salute Mentale derivante dalla valorizzazione dell’esperienza degli utenti (Crawford et al., 2002). Ciò potrebbe comportare una maggiore focalizzazione degli interventi sui problemi effettivamente ritenuti prioritari dagli utenti e dai loro familiari, una maggiore condivisione degli obiettivi ed una ottimizzazione nell’utilizzo delle risorse. Strategie terapeutiche basate su decisioni condivise e una maggiore attenzione alla soddisfazione degli utenti potrebbero, infatti, avere delle ricadute positive sia sull’efficacia che sull’efficienza nell’utilizzo delle risorse nell’ambito dei Servizi di Salute Mentale. Il coinvolgimento degli utenti dei Servizi di Salute Mentale e dei loro familiari nella programmazione e nella valutazione degli stessi Servizi è, peraltro, esplicitamente raccomandato nella politica sanitaria del Regno Unito e di altri Paesi (Simpson & House, 2003).
Esiste nella letteratura scientifica un crescente interesse per il coinvolgimento degli utenti anche nella ricerca. Viene, infatti, ritenuto che un’esperienza personale di sofferenza possa generare una competenza diversa da quella dei ricercatori e che questa competenza sia utile alla ricerca (Townend & Braithwaite, 2002; Trivedi & Wykes, 2002).
Importanti enti finanziatori britannici come il Medical Research Council ed il Community Fund (The National Lottery) prevedono già oggi che un progetto di ricerca, per poter essere finanziato, contempli qualche forma di collaborazione con gli utenti (Beresford, 2005).
L’unità di ricerca Service User Research Enterprise (SURE), presso l’Istituto di Psichiatria di Londra, rappresenta poi un esempio di come il coinvolgimento degli utenti-ricercatori possa coniugarsi con una ricerca di eccellenza. Il gruppo, che è costituito per il 100% da utenti-ricercatori, si finanzia concorrendo in modo competitivo all’assegnazione di fondi di ricerca ed è in grado di produrre ricerche d’impatto nazionale ed internazionale. È significativo che questa unità sia sorta in risposta a un’esigenza di partecipazione a tutti i livelli del processo di ricerca sentita dagli utenti (Thornicroft et al., 2002).
Effetti positivi, sotto forma di empowerment e di acquisizione di nuove competenze, vengono riferiti pressoché unanimemente per gli utenti che venivano coinvolti in progetti di ricerca. La pratica di formare gli utenti-ricercatori sui metodi di ricerca risulta indispensabile per favorire una situazione di parità tra utenti-ricercatori e ricercatori professionisti, ma anche per garantire una buona qualità delle ricerche stesse (Ochocka et al., 2002).
Quindi fonti diverse e indipendenti ci dimostrano che il coinvolgimento degli utenti dei Servizi di salute mentale nelle decisioni che li riguardano e il fatto di poter esercitare un ruolo attivo rispetto alla propria cura producono esiti migliori nel trattamento, nell’adesione al trattamento stesso, nella comprensione clinica e nel benessere in generale. Al di là delle etichette e delle diagnosi, le persone con problemi gravi hanno idee, opinioni, speranze ed ambizioni, ed è per questo che è importante ascoltare la loro voce.