La psicoterapia della Gestalt nel postmodernismo
Dal punto di vista clinico la consapevolezza per la psicoterapia della Gestalt è il principale strumento terapeutico. La consapevolezza è l’abilità di concentrarsi su ciò che esiste ed è attuale nel presente, ovvero l’essere in contatto con la propria esistenza.
Roberto Minotti, Iolanda Gaudiosi
La Psicoterapia della Gestalt e l’importanza di esprimere le emozioni represse
La Psicoterapia della Gestalt, come ogni altro modello teorico, è la risposta ad un’ urgenza che emerge da un contesto socio-culturale ben determinato.
Nel 1951, in un periodo in cui il modernismo, come atteggiamento di progressivo affrancamento dal passato e dai valori ritenuti obsoleti, rappresenta il pensiero dominante, la Psicoterapia della Gestalt con la “Teoria e pratica della Terapia della Gestalt” pubblica il suo testo fondamentale.
È un periodo in cui la creatività e il desiderio di ritrovare la propria soggettività, per troppi anni eclissata, riemerge prepotentemente dallo sfondo, e il paradigma gestaltico sembra poter dare voce ad emozioni come la rabbia e l’aggressività. Rimangono storici i seminari a Big Sur, in California, presso l’Esalen Institute; in cui l’esperienza, l’espressione delle emozioni più represse, la presa di consapevolezza e l’autoaffermazione divennero i nuovi imperativi categorici.
Il cittadino della seconda metà del XX secolo riscopre la propria autonomia, la responsabilità verso la propria libertà, comprendendo che per accrescere la propria personalità, sia necessario un rapporto dinamico con l’ambiente. L’individuo e i suoi desideri trovano un pieno soddisfacimento in un contesto storico che sembra finalmente in grado di esaudire tale volontà. Alla fine degli anni ’60 le nuove generazioni si liberano dai legami culturali, mettendo in crisi tutto il sistema normativo e politico. È l’alba dell’era della comunicazione in tempo reale e dell’interconnessione tra popoli e, al contempo, il tramonto del modernismo. Sono i personal computer, i mass-media e l’avvento di Internet, a trasformare la persona in soggetto individuale, rivoluzionando completamente tutto: i confini fisici, lo spazio e il tempo, e poi quelli psicologici si riducono sempre di più, fino a fondersi, sancendo l’epoca della percezione globale. Si parla di prossimità a distanza, di passioni tristi e, paradossalmente, in un periodo in cui tutto confluisce verso un’unica forma amalgamandosi e omologandosi, il ground si sgretola.
I centri di gravità permanente attorno ai quali i valori e i saperi convergevano realizzando la cultura e la storia, lentamente svaniscono; ogni sito, ogni portale o social network diviene un possibile palco da cui affacciarsi per osservare αγορά individuali, da cui esprimere valori e pensieri in solitudine.
“Nella nascita di una società postmoderna un ruolo determinante è esercitato dai mass media; che caratterizzano questa società non come una società più “trasparente”, più consapevole di sé, più “illuminata”, ma come una società più complessa, persino caotica e, infine, che proprio in questo relativo “caos” risiedono le nostre speranze di emancipazione”. Gianni Vattimo confermando la visione multipolare dell’individuo post moderno in una società complessificata, ci dà nuove coordinate per comprendere l’evoluzione culturale per i prossimi decenni. Se la frammentazione dello sfondo collettivo determina uno spaesamento e nuovi malesseri, lo stesso caos può certamente rappresentare una risorsa, se letto con una diversa consapevolezza. Resta da chiederci se un modello teorico come quello gestaltico possa calarsi completamente in una realtà che in qualche modo contraddice la sua stessa definizione, la buona forma, o se tale paradosso non costituisca già un elemento di auto e di meta analisi.
Già porsi la domanda se effettivamente l’instabilità si debba considerare una difficoltà e la frammentazione un disagio, vuol dire situarsi in un’ottica che tenga conto della complessità del contesto dell’individuo attuale, accettando di poggiarsi su di un ground mutevole, sbaragliando il campo da ogni euristica o introietto, per giungere ad una comprensione più autentica dei vissuti che ci riferiscono i nostri pazienti. La relazione terapeutica è un viaggio che si fa in due, ed è impensabile credere che sulla stessa barca in cui l’uno soffre il rollio, l’altro si senta stabile come sulla terra ferma.
La Psicoterapia della Gestalt, attraverso i concetti come: adattamento creativo, multipolarità del sé, continuum di consapevolezza e ascolto empatico, è certamente in grado di accogliere concretamente la dimensione fluida dell’uomo post-moderno e delle sue forme di contatto istantanee e apparentemente disconnesse.
Psicoterapia della Gestalt: la fenomenologia dell’intenzionalità e la relazione dialogica
Dal punto di vista clinico la consapevolezza per la psicoterapia della Gestalt è il principale strumento terapeutico. La consapevolezza è l’abilità di concentrarsi su ciò che esiste ed è attuale nel presente, ovvero l’essere in contatto con la propria esistenza. Ai nostri pazienti chiediamo di esprimere ciò di cui sono consapevoli in quel momento. Hedmund Husserl ha definito tale “momento” di contatto come la “datità” del mondo, in cui lasciamo che il fenomeno riempia il nostro orizzonte di conoscenza. In questo modo, il paziente impara in modo graduale che ciò di cui è consapevole, rappresenta ciò che realmente esiste per lui. Non c’è una realtà giusta o sbagliata. Ciò che è, è.
Fritz Perls propone il concetto di consapevolezza universale come ipotesi utile che si oppone al trattare noi stessi come oggetti o cose. Noi siamo consapevolezza piuttosto che avere consapevolezza. La consapevolezza, la coscienza e l’eccitazione sono esperienze sicchè hanno tra loro un legame molto forte e rappresentano le dimensioni che vorremmo evidenziare in questo lavoro. Con l’ipotesi di una consapevolezza universale, una coscienza unificatrice, ci disponiamo a considerare noi stessi in modo vitale in una presentificazione sempre aggiornata, nell’hic et nunc, e non a teorizzare intorno ad una mente, su concetti astratti come un Io, un Super-Io e così via (Perls, 1976). Alla luce di questi assunti metodologici, al terapeuta della Gestalt è richiesto uno “sforzo” in più da compiere nel processo terapeutico, quello di essere presente principalmente a se stessi, in un dasein riflessivo e descrittivo, partendo sempre dalle proprie sensazioni e propriocezioni.
Senza dubbio esiste fra terapeuta e paziente una relazione asimmetrica e che il potere trasformativo della psicoterapia si fonda proprio sulle caratteristiche specifiche di questa asimmetria, ma ciò non deve impedire alla relazione di costituirsi autenticamente senza pregiudicare il processo di co-creazione dell’ altra. E’ grazie ad esso, che la persona che chiede aiuto si trova di fronte un professionista in grado di regolare il proprio modo di entrare in relazione, sapendo indietreggiare con la propria persona e avanzare con la propria presenza, modulandosi con i bisogni del paziente, al fine di creare le condizioni più utili per elaborare le modalità e i contenuti condivisi.
La dinamica figura-sfondo, l’autoregolarsi organismico in un’omeostasi costante, costituisce il campo psicologico e la gestalt in cui l’esperienza terapeutica si realizza. È il criterio estetico della relazione ad orientare sia il terapeuta, che il paziente verso un medesimo sentire ed un ascolto comune. La questione delicata è, quindi, definire questa asimmetria nel modello gestaltico. Solo negli ultimi decenni si è affermata, in ambito psicologico, una concezione del setting come di un campo bipersonale e si è prodotta una descrizione del dialogo clinico che identifica un andamento a spirale. Si è arrivati a considerare i due componenti la coppia terapeutica, come contemporaneamente coinvolti nell’attualità dello stesso processo.
Ciò significa che il comportamento dei due protagonisti non può essere compreso senza prendere, contemporaneamente, in considerazione quello dell’altro. In questo bifrontismo, il campo psicologico si energizza, regolando i livelli di eccitazione di entrambi, in un rapporto dinamico. Si è progressivamente affermata la concezione secondo la quale il dialogo clinico può essere descritto da un andamento a spirale, costituito da sequenze di interazioni comunicative fra loro concatenate, che si susseguono nel tempo e che, progressivamente, ampliano e approfondiscono i contenuti sui quali paziente e psicoterapeuta dialogano.
E’ la singola interazione a orientare quanto accade successivamente, divenendo, quindi, l’unità di analisi dell’intero processo. In questa prospettiva, le comunicazioni del paziente non sono più considerate soltanto espressione di un mondo interno di significati, e le attribuzioni sullo psicoterapeuta come esito di una dinamica transferale, ma degli adattamenti creativi prodotti dall’incontro tra due persone in relazione.
La fenomenologia che ne emerge non è più una datità individuale, ma qualcosa che si crea con la responsabilità di entrambi. Potremmo parlare di polifenomenologia; sia il malessere che l’adattamento creativo (concetto caro alla gestalt classica) non può più essere considerato come espressione individuale, ma sempre e costantemente come universo relazionale. Ciò che accade nel colloquio è qualcosa che prende forma soltanto nel presente, dai significati soggettivamente attribuiti all’andamento delle diverse sequenze, spontaneamente e in modo imprevedibile.
Sequenze che avvengono, naturalmente, all’interno di un contesto specifico. La fenomenologia della relazione secondo la psicoterapia della Gestalt ci testimonia che, nonostante l’asimmetria dei ruoli, un’influenza si verifica in entrambe le direzioni e accompagna l’intervento di entrambi. Questa diversa concezione dello scambio comunicativo porta necessariamente a ripensare le funzioni dello psicoterapeuta. Egli, ora, è dentro la relazione in modo più pieno e consapevole, gli viene riconosciuta un’assertività e un’influenza che non possono più permettergli processi di deresponsabilizzazione rispetto a quanto accade, sia rispetto alle caratteristiche del materiale che emerge, che alla qualità del rapporto, fino ai possibili momenti di regressione e peggioramento sintomatologico del paziente. Il primo strumento terapeutico è, perciò, egli stesso. Nella ricerca di contatto con l’altro, nel continuum di consapevolezza, l’osservazione fenomenologica e l’intenzionalità del terapeuta devono partire, necessariamente, da un auto processo di esplorazione, se si vuole sbaragliare il campo da possibili confluenze e introietti iniziali. Osservando l’altro, consapevolmente o inconsapevolmente, qualcosa ci accade, qualcosa ci cade addosso (Waldenfels B. , 2011).
È il pathos “sentito”, che ci svela che qualcosa, in quell’hic et nunc, è accaduto. Sarà poi la consapevolezza del terapeuta, frutto dell’intenso lavoro fatto principalmente su se stesso, a tradurre, in un tempo sempre più breve, quella sensazione che emerge da uno sfondo indistinto, in una figura emotiva (Borgna E.,2015). Senza una tale “coscienza”, lo iato tra pathos e risposta, creerebbe una frattura incolmabile nella relazione terapeutica. Nella psicoterapia della Gestalt la discriminazione da parte del terapeuta tra gli “introietti” evidenti che impediscono un sentire autentico, da quelli che esprimono un vissuto chiaro, sono parte nucleare e fondante della reazione con il paziente; tale momento ci introduce il concetto di neutralità, costruito dall’intendere un’obiettività certa e garantita, con l’idea di creare un posto al paziente dentro di sé, non confondendosi con lui.
Tale distanza ci riconduce al concetto di estraneo introdotto dalla fenomenologia contemporanea. Infatti, “fino a quando ci ostiniamo a trattare l’estraneo come un “qualcosa” o un “qualcuno” d’ordine direttamente accessibile e definibile, che ci sta là di fronte senza troppi problemi, lo mancheremo fin dall’inizio. Il mantenere questa separatezza, implica la capacità da parte del terapeuta di conservare la lucidità di fronte alle intuizioni che suscita il mondo interno del paziente, attraverso meccanismi, quali per esempio la proiezione; nella stessa misura, non si dovrebbe misconoscere la possibilità d’influenzare con il proprio modo di sentire ed essere, e con i propri comportamenti, l’altro che è davanti a noi. Questa modalità di considerare il processo comunicativo porta ad una maggiore umiltà da parte del terapeuta, che non assume più una posizione di privilegio, con una pseudo inviolabilità nell’interazione con il paziente, ma che convalida eticamente le sue precise competenze, tra cui, la capacità di imparare dalle risposte del paziente. Questa consapevolezza è l’humus su cui trarranno sostegno e nutrimento le radici di entrambi, il campo psicologico ed esistenziale in grado di far sviluppare, ogni volta e in una gestalt sempre rinnovata, la relazione terapeutica.



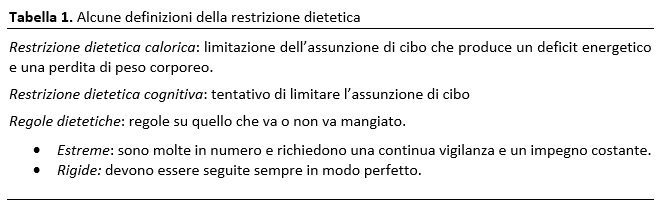
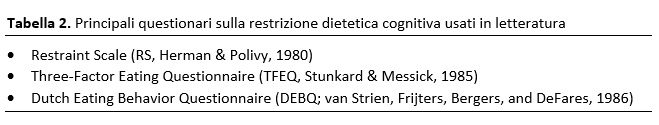
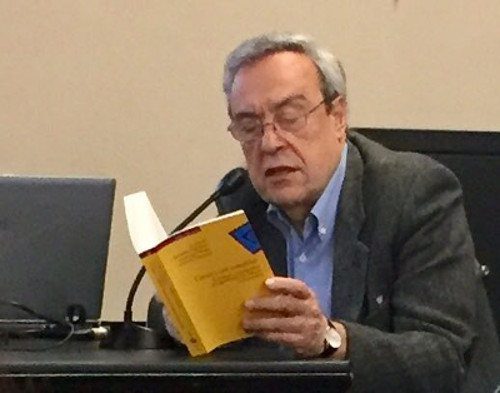
 Giacomo Vivanti: Pensare al bambino con autismo come ad un bambino che impara in modo diverso, anziché ad un bambino che impara “di meno”, crea un cambiamento di prospettiva che spinge all’azione. Per esempio, quando il bambino sembra non imparare, pensare in questo modo può spingere il terapista o l’insegnante a passare da una prospettiva del tipo “il bambino non impara perché essendo autistico ha meno capacità di apprendimento e non ci posso fare niente”, ad una prospettiva del tipo “se il bambino non sta imparando, sono io che sto insegnando con delle modalità che non sono quelle giuste per questo bambino, quindi devo sforzarmi per trovare quelle giuste”.
Giacomo Vivanti: Pensare al bambino con autismo come ad un bambino che impara in modo diverso, anziché ad un bambino che impara “di meno”, crea un cambiamento di prospettiva che spinge all’azione. Per esempio, quando il bambino sembra non imparare, pensare in questo modo può spingere il terapista o l’insegnante a passare da una prospettiva del tipo “il bambino non impara perché essendo autistico ha meno capacità di apprendimento e non ci posso fare niente”, ad una prospettiva del tipo “se il bambino non sta imparando, sono io che sto insegnando con delle modalità che non sono quelle giuste per questo bambino, quindi devo sforzarmi per trovare quelle giuste”.