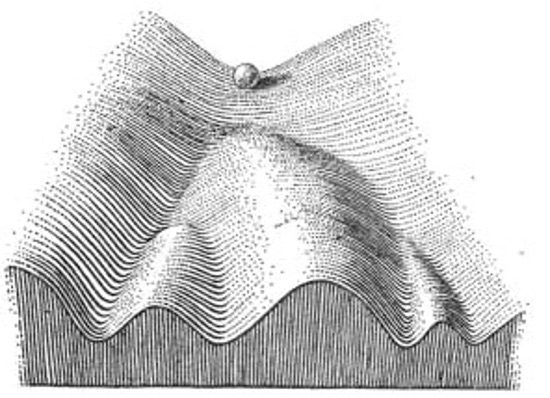Il rischio internet-correlato alle scuole medie: uno strumento di indagine per l’intervento nelle classi
La diffusione di tecnologie che permettono l’accesso a Internet o l’utilizzo di videogiochi sembra diventare sempre più pervasiva e precoce, l’utilizzo dei pc e degli smartphone da parte di giovani e giovanissimi porta con sé numerose dimensioni di rischio internet-correlato.
Matteo Kettmaier – OPEN SCHOOL Studi Cognitivi, Bolzano
La diffusione di tecnologie che permettono l’accesso a Internet o l’utilizzo di videogiochi sembra diventare sempre più pervasiva e precoce. Questo fenomeno ha portato a reazioni di preoccupato interesse da parte della comunità scientifica e, talvolta, a manifestazioni di panico morale sui mass-media.
Diversi tipi di rischio internet-correlato: quali sono e perché è facile incontrarli?
L’utilizzo dei personal computer, dei tablet e degli smartphone da parte di giovani e giovanissimi porta con sé numerose dimensioni di rischio internet-correlato:
- Il rischio di sviluppare una dipendenza tecnologica
- Il rischio di adescamento da parte di pedofili o organizzazioni terroristiche
- Il rischio della messa in atto di comportamenti aggressivi nei confronti dei pari (cyberbullismo)
Ad esacerbare questi tipi di rischio internet-correlato possono concorrere tanto una situazione di disagio pregressa, quanto il gap generazionale tra genitori e figli, con questi ultimi nati in un contesto in cui tali strumenti tecnologici sono una realtà scontata, nonché un “ambiente” virtuale nel quale vengono agite parte delle tappe di crescita e formazione della personalità.
Un genitore nato trenta o quaranta anni fa può non avere la consapevolezza di che cosa effettivamente è possibile fare con le varie applicazioni, né essere aggiornato sui contenuti degli ultimi videogiochi in circolazione, considerato anche come, questi ultimi, non godono ancora del riconoscimento sociale del proprio valore culturale e artistico come invece è successo, ad esempio, con il cinema e pertanto non vengono considerati dai quotidiani e dai telegiornali, se non, occasionalmente, in maniera allarmistica.
Un atteggiamento di condanna e svalutazione del potenziale positivo di Internet, difficilmente può avere effetti positivi. Alimentare le paure dei genitori promuovendo un atteggiamento censorio non fa che incrementare l’incomunicabilità e l’incomprensione tra i cosiddetti “nativi digitali” e gli adulti. Va anche preso atto di una realtà in cui lo smartphone è, a torto o a ragione, considerato uno strumento di controllo parentale e in cui i computer sono una realtà presente in quasi qualsiasi contesto lavorativo. Inoltre, se già attualmente i divieti ai minori vigenti in materia di social network e videogiochi vengono puntualmente disattesi, pensare ad una legislazione che restringa l’accesso a Internet ai soli maggiorenni non è realistica.
Il rischio internet-correlato nei ragazzi: la Scala del Rischio Internet-Correlato in Adolescenza (RICA)
Insieme ai colleghi dott. Daniele Maramaldo e dottt.ssa Giulia Tomasi stiamo portando avanti un progetto di prevenzione del rischio internet-correlato, formazione e ricerca nelle scuole medie in cui ci proponiamo di ridurre il gap generazionale facendo da cerniera tra genitori, figli e insegnanti. Per poter fare questo, non partiamo da una posizione preconcetta ma andiamo ad indagare l’effettivo utilizzo dei mezzi tecnologici da parte dei ragazzi nelle scuole secondarie di primo grado. Per poterlo fare, abbiamo approntato uno strumento di screening specifico, grazie al quale possiamo avere una fotografia dell’attuale livello di rischio di ciascuna classe esaminata sulla quale calibrare gli interventi formativi nelle classi: la Scala del Rischio Internet-Correlato in Adolescenza (RICA)
La Scala del Rischio Internet-Correlato in Adolescenza non si propone di essere uno strumento diagnostico, bensì di rilevazione dei rischi connessi al comportamento on-line del ragazzo. Tale strumento è stato perfezionato in itinere e sicuramente verrà modificato per adattarsi alla mutevolezza del fenomeno indagato. Riguardo al costrutto della “dipendenza da Internet”, ad esempio, non ha più molto senso parlare delle conseguenze economiche del tempo trascorso in rete, considerato come le tariffe per la connessione sono precipitate nel corso degli ultimi anni e un accesso illimitato a Internet, attualmente, può costare meno di quaranta euro al mese.
Mediante tale strumento si può ottenere un indice generale di quanto il comportamento del ragazzo sia un potenziale pericolo per la sua salute mentale e la sua sicurezza. Tale indice è composto di quattro dimensioni, ciascuna rappresentata da cluster specifici, e da un cluster specifico relativo ai fattori protettivi.
Tempo trascorso in rete e sui videogiochi
Prima delle dimensioni relative specificatamente all’utilizzo “a rischio”, chiediamo ai ragazzi quanto tempo trascorrano utilizzando videogiochi, social network e altri servizi (ad esempio i quotidiani on-line). Particolare attenzione è data ai videogiochi, con una lunga checklist che include diversi generi di videogiochi tra i quali indicare i propri preferiti e una voce libera in qui indicare i videogiochi maggiormente utilizzati. Un’altra checklist è relativa ai social network, una voce di approfondimento importante, considerato come ciascuno presenti peculiarità e problematiche potenziali specifiche.
Rischio esterno
Tale indice si riferisce direttamente al rischio internet-correlato che corre il ragazzo di essere adescato online ed è dato dalla misura auto-riportata di alcuni suoi comportamenti (fare amicizie direttamente on-line, cercare in rete risposte a domande personali), del controllo parentale e dall’utilizzo prevalente di social network, è documentato infatti come l’adescamento avvenga tipicamente mediante un processo di seduzione operato mediante le tecnologie di comunicazione tramite il quale l’aggressore guadagna la fiducia del ragazzo (Cohen-Almagor 2013, Katz 2013). Un altro indice della disinibizione del ragazzo è dato dal suo imbattersi involontariamente in contenuti che ritiene spaventosi o lo mettono a disagio (Dobrowski et al. 2007, Webb et al. 2007)
Comportamento dipendente
Le domande che indagano modalità di comportamento dipendente sono in parte mutuate dai criteri proposti da Young (1996), tradotti ed adattati per la popolazione di riferimento. Nello specifico indaghiamo: la preoccupazione riguardo a Internet (intesa come pensiero anticipatorio del tempo passato on-line), la perdita del senso del tempo durante la navigazione, la riduzione di altre attività (ricreative, sportive o sociali) per trascorrere più tempo in rete, l’uso di Internet come fuga dai propri problemi.
Per la popolazione di riferimento abbiamo deciso di non includere item relativi all’escalation nell’uso e i tentativi di riduzione perché riteniamo che siano fenomeni che si verifichino almeno intorno ai sedici anni mentre l’età delle scuole medie può coincidere con una fase di esordio del comportamento dipendente nella quale non c’è ancora consapevolezza dell’escalation o tentativi di mantenimento dell’astinenza. Abbiamo invece aggiunto una voce specifica relativa alla perdita di ore di sonno, che può avere conseguenze dirette sul rendimento scolastico. Giova qui sottolineare ancora una volta come si sia preferito evitare parlare di “dipendenza” o “sintomi” preferendo il termine “funzionamento”: la massima prudenza e delicatezza viene infatti da noi applicata nella restituzione dei risultati per evitare che dei ragazzi si trovino ad essere etichettati come “dipendenti” il che potrebbe avere conseguenze negative in tale fase dello sviluppo.
Problemi relazionali
Una serie di domande relative ad episodi di conflitto famigliare in cui l’uso di Internet è stato centrale. Tale dimensione va a sommarsi alla precedente nel costituire l’indice di “rischio interno” ma va considerata separatamente in quanto non è possibile stabilire un nesso di causazione tra le due in nessuna direzione. Non possiamo dare per scontato che i problemi relazionali in famiglia focalizzati sull’uso delle tecnologie Internet rifletta effettivamente un comportamento preoccupante del ragazzo, può darsi infatti il caso che sia una conseguenza di altri problemi pregressi nel nucleo famigliare o semplicemente del gap generazionale, per cui, magari, un ragazzo sta trovando la propria strada professionale nella programmazione o nel web design senza che i genitori se ne rendano conto. In tali situazioni, la reazione parentale negativa può diventare causa (e non effetto) di un comportamento aberrante, in quanto alimenta il senso di incomunicabilità in famiglia e può rinforzare l’idea che i computer siano solo degli strumenti di intrattenimento: degli “iper-giocattoli”.
Videogiochi
Meritevoli di una voce a sé stante: i videogiochi, una realtà quotidiana e ineludibile di praticamente tutti i giovani occidentali contemporanei.
Nonostante il dibattito sulla loro nocività generale sullo sviluppo sia ancora aperto, l’uso prolungato di videogiochi è stato associato a fenomeni dissociativi e pseudo-allucinatori (Caretti et al. 2010, De Gortari & Griffiths, 2013) e la dipendenza da videogiochi è stata indagata come fenomeno a sé Stante, ad esempio, in uno studio su ragazzi olandesi dai 13 ai 16 anni (vanRooij et al. 2010). Nella prima versione della scala, l’unica domanda era relativa all’uso specifico di videogiochi come modo di sfogare la rabbia, indicata come fonte di rischio da Tonioni (2014), nella versione più recente è stato incluso l’Item “Ti capita di sentirti “strano” o “confuso” dopo aver giocato molto tempo con i videogiochi?” relativo al fenomeno della “Trance dissociativa da videoterminale” (Caretti et al. 2010) ricercata attivamente come spia di una forte tendenza alla fuga dalla realtà, associato all’item “Ti capita mai di giocare ai videogiochi per distrarti e non pensare ai problemi?”.
Fattori protettivi
Considerato come il dialogo famigliare sia un fondamentale fattore protettivo nei confronti dello sviluppo di una “dipendenza da Internet” (Wąsiński & Tomczyc, 2015), nonché del rischio internet-correlato di adescamento, quattro dei cinque item che compongono questo cluster possono essere letti come l’opposto degli item del cluster “Problemi relazionali”. In essi si indaga se viene trascorso del tempo famigliare collettivo usando Internet e quanto i ragazzi parlino di cosa fanno in rete (soprattutto nel caso si imbattano in contenuti non adatti) con i loro genitori e viceversa. La bi-direzionalità è infatti fondamentale per evitare pericolose ambivalenze che possono ingenerare confusione o rifiuto da parte del ragazzo. L’ultimo item indaga se il ragazzo pratica altre attività oltre a passare tempo on-line.
Modalità di somministrazione
Dopo una prima somministrazione in forma cartacea (circa 500 soggetti), il test è stato digitalizzato mediante il servizio Google Forms. Gli item relativi al rischio internet-correlato e al tempo trascorso on-line sono in forma di scala semi-likert. Per rendere più potente lo strumento in sé, può essere somministrato insieme a questionari relativi al funzionamento sociale e famigliare dei ragazzi, oltre a questionari specifici sulla resilienza e la gestione delle emozioni negative. Il tempo medio di compilazione dell’intera batteria è intorno ai 35-40 minuti, pertanto viene dedicata un’ora scolastica allo screening di ciascuna classe.
Applicazione e possibili sviluppi della Scala del Rischio Internet-Correlato in Adolescenza
Attualmente la scala R.I.C.A. viene utilizzata per inquadrare la classe in un livello di rischio internet-correlato da uno a cinque. Questo risultato, insieme a quelli degli altri test somministrati e ai resoconti degli insegnanti riguardo ad episodi specifici, viene usato per calibrare degli interventi sul rischio internet-correlato nelle scuole medie. Tali incontri consistono in tre formazioni dal taglio pratico-maieutico da due ore ciascuna. Il primo incontro è focalizzato sul concetto di rete, sulla comunicazione e la relazionalità, il secondo incontro consiste in un training sul lessico emotivo e il terzo incontro è un’attività pratica di lavoro sulle chiavi di ricerca in forma di gioco a squadre.
L’obiettivo della formazione è quello di far parlare i ragazzi del loro vissuto relativo all’uso di Internet, a seconda dei risultati dei test il discorso verte su tematiche specifiche (ad esempio l’aggressività nei videogiochi o il pericolo nel fare amicizie on-line) cercando di essere il meno prescrittivi possibile ma cercando di condurre i ragazzi a dei ragionamenti condivisi.
Evitare la demonizzazione del mezzo ed enfatizzarne le potenzialità positive è una linea guida costante di tutto il percorso che si chiude infatti con un’esercitazione pratica sull’utilità di Internet come fonte di informazione che è anche un’importante occasione formativa per correggere i ragazzi su comportamenti superficiali e potenzialmente dannosi come il copiare acriticamente i contenuti trovati in rete o il fermarsi ai primi risultati di una ricerca.
Ulteriori analisi condotte sull’intero campione daranno un’immagine complessiva del territorio in esame (la Provincia Autonoma di Trento) e delle specificità dei singoli istituti (ad esempio tra scuole in città e scuole in montagna).
Un altro tema di indagine è quello relativo alle esigenze emotive a cui i diversi tipi di videogiochi possono rispondere: se videogiochi violenti come GTA V possono prevedibilmente essere preferiti da ragazzi con un alto livello di aggressività oppure che hanno difficoltà ad esprimere l’aggressività positiva nei contesti quotidiani, sarebbe interessante indagare il potenziale “dissociativo” di videogiochi arcade molto semplici come “Geometry Dash” o “Candy Crush” per verificarne anche il potenziale additivo. Se queste due categorie di videogiochi sono quelle potenzialmente più pericolose, videogiochi di costruzione e gestione come “Minecraft” o “Age of Empires” potrebbero rispondere ad un’esigenza di percezione di controllo in un’età particolarmente soggetta a cambiamenti destabilizzanti e imprevedibili mentre i giochi sportivi potrebbero rappresentare un’importante momento di aggregazione tra pari.
Infine, incrociando la scala R.I.C.A. con altri test si possono identificare dei profili di rischio internet-correlato per programmare interventi individuali. Ad esempio un ragazzo che riporta valori alti di rischio esterno, valori bassi relativi alla sua percezione dell’ambiente famigliare e valori bassi in un test che ne misura l’integrazione sociale tra i pari.