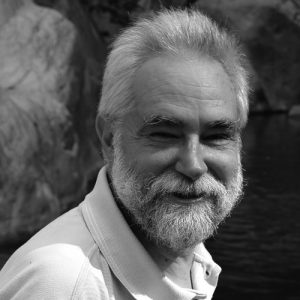Approcci psicoterapeutici per i pazienti affetti da sclerosi multipla
La sclerosi multipla è una malattia infiammatoria neurodegenerativa del sistema nervoso centrale la cui natura è autoimmunitaria, che si manifesta su una base genetica con l’interazione di fattori ambientali. Tale patologia presenta un decorso imprevedibile e la disabilità da essa provocata è dovuta a infiammazione e degenerazione nel SNC, con distruzione progressiva della guaina che avvolge i neuroni, la mielina.
Nausicaa Berselli – OPEN SCHOOL Studi Cognitivi Modena
Sclerosi multipla: sintomi ed impatto sulla qualità di vita
I
sintomi della sclerosi multipla dipendono dalla localizzazione delle aree di demielinizzazione; la loro comparsa può essere causata sia dall’edema e dall’azione di mediatori infiammatori tossici che dalla perdita assonale. Il progressivo danno degli assoni, nei casi a decorso cronico, porta ad estesa degenerazione ed atrofia cerebrale, la quale sembra essere molto più correlata con i deficit neurologici permanenti rispetto alla demielinizzazione (Poser, Raun, & Poser, 1982).
I sintomi all’esordio della sclerosi multipla sono molto variabili e possono presentarsi singolarmente o in associazione, in forma acuta, subacuta o lentamente progressiva. Tali sintomi riguardano principalmente i sistemi motorio, visivo, sensitivo (Ghezzi & Cazzullo, 1980) e l’apparato vestibolo-cerebellare. Altri sintomi che sono stati individuati sono la fatica (Colosimo, Millefiorini, Grasso, Vinci, Fiorelli, Koudriavtseva, & Pozzilli, 1995), i disturbi intestinali (Chia, Fowler, Kamm, Henry, Lemieux, & Swash, 1995), dolori di intensità variabile, disartria e disfagia, presenti nelle forme più gravi e cronicizzate, disturbi urinari (Awad, Gaiewsky, Sogbein, Murray, & Feld, 1984) e sintomi da disfunzione sessuale (Ghezzi, 1999).
La sclerosi multipla ha un forte impatto sulla funzionalità dell’individuo; entro dieci anni dall’esordio, metà dei pazienti non sono in grado di adempiere pienamente alle attività domestiche e alle responsabilità lavorative, entro quindici anni metà di essi diviene incapace di camminare senza aiuto, ed entro venticinque anni la metà dei pazienti ha bisogno della sedia a rotelle (Confavreux, Vukusic, & Adeleine, 2003).
Nella sclerosi multipla i farmaci comunemente utilizzati appartengono a quattro categorie principali: gli steroidi, gli immunosoppressori, gli immunomodulatori e i sintomatici. Gli effetti che la terapia della sclerosi multipla intende conseguire sono quelli di abbreviare le ricadute e di ridurre la loro gravità, prevenire le ricadute, e prevenire o ritardare la progressione della malattia.
È stata stimata la presenza di compromissione cognitiva nella metà dei pazienti con sclerosi multipla, con percentuali che oscillano tra il 40 ed il 65% (Beatty, 1993). Per la maggior parte i disturbi cognitivi sono lievi o moderati, anche se sono riportate in letteratura forme di demenza da sclerosi multipla. Vi sono alcuni domini cognitivi ritenuti più compromessi rispetto ad altri, quali le funzioni esecutive, l’attenzione volontaria, la memoria e le abilità visuo-spaziali. Vengono invece ritenuti meno vulnerabili il rendimento intellettivo globale ed il linguaggio.
Sclerosi multipla e disturbi psicologici
Sono stati condotti numerosi studi valutare la prevalenza e le caratteristiche delle difficoltà psicologiche che si riscontrano nei pazienti con sclerosi multipla. Si rilevano disturbi d’ansia e di somatizzazione, disturbi bipolari e psicosi, anche se il disturbo più comune è rappresentato dalla depressione (Thompson, Polman, Hohlfeld, & Noseworthy, 1997).
Sono state avanzate diverse ipotesi per spiegare l’associazione fra depressione e sclerosi multipla: l’esistenza di una comune base genetica, la presenza di una correlazione con il processo di demielinizzazione e di gliosi in specifiche aree cerebrali, la concomitanza di comuni alterazioni del sistema immunitario, il coinvolgimento di fattori psicologici che possano spiegare il disturbo depressivo come modalità di reazione del singolo individuo ad una patologia particolarmente stressante ed invalidante come la sclerosi multipla.
Il disturbo d’ansia rappresenta la modalità immediata di risposta agli eventi più stressanti correlati alla malattia, quali l’esordio dei sintomi, la comunicazione della diagnosi, l’ospedalizzazione, il confronto diretto con forme gravi di malattia, l’incertezza dell’evoluzione, l’inadeguatezza delle proposte terapeutiche, il progressivo accumulo di disabilità.
Un altro tipo di disturbo psicopatologico che si verifica in corso di sclerosi multipla è il disturbo bipolare, dovuto ad una condizione medica generale che designa quelle situazioni in cui il disturbo insorge in rapporto cronologico con una patologia fisica, anche se non si può escludere che la malattia costituisca un fattore scatenante di un disturbo primario dell’umore. In questi casi è spesso possibile identificare nella storia del paziente pregressi episodi ed una familiarità positiva per patologia psichiatrica. Gli episodi maniacali in corso di sclerosi multipla sono distinti dalle manifestazioni psicotiche vere e proprie nelle quali il paziente si mostra più agitato, senza però presentare una persistente alterazione del tono dell’umore. Un’ulteriore condizione frequente che può essere confusa con manifestazioni di tipo maniacale è la sensazione di benessere e di noncuranza verso la malattia, definita come euforia. Questa condizione è caratterizzata da uno stato di labilità emotiva e di ottimismo incongruo, ma non presenta l’iperattività motoria e le fluttuazioni tipiche del disturbo bipolare.
Un altro disturbo che si verifica in corso di sclerosi multipla è sicuramente la psicosi dovuta a cause mediche generali. Le caratteristiche cliniche della psicosi nei pazienti affetti da sclerosi multipla sembrano essere relativamente diverse da quelle dei pazienti schizofrenici: l’età d’esordio è più tardiva, la risposta affettiva è preservata, i sintomi si risolvono più rapidamente e la risposta al trattamento è migliore (Feinstein, du Boulay, & Ron, 1992).
Una condizione clinica di frequente riscontro nella sclerosi multipla è costituita da riso e pianto spastico, in cui episodi di riso e pianto si manifestano e alternano in maniera improvvisa, incontrollabile e incongrua rispetto al contesto ambientale. Questa condizione rappresenta un’alterazione della risposta emozionale ed è associata a lesioni cerebrovascolari coinvolgenti i tratti cortico-bulbari (Kim, & Choi-Kwon, 2002), che compromettono i movimenti necessari per ridere e piangere.
Le reazioni alla diagnosi di sclerosi multipla
Ricevere la diagnosi di sclerosi multipla e vivere ogni giorno con questa malattia è molto difficile. Il momento della comunicazione della diagnosi comporta nel paziente una crisi psicologica molto intensa, caratterizzata da emozioni contrastanti tra loro: rabbia, frustrazione, senso di impotenza, senso di colpa e incredulità. Dopo aver ricevuto la diagnosi di sclerosi multipla crollano tutte le certezze e la propria progettualità di vita. Tutto diventa, allora, imprevedibile, a partire dal decorso della malattia stessa, ai sintomi e alla assunzione di farmaci; ciò ha un enorme impatto sulla qualità di vita del paziente e della famiglia che lo circonda.
La prima fase che una persona vive dopo aver ricevuto la diagnosi di sclerosi multipla è quella definita di shock caratterizzata da incertezza, confusione e disorientamento. La seconda fase è quella di reazione caratterizzata da sentimenti di rabbia: la persona acquisisce consapevolezza di malattia e inizia a chiedersi il motivo per cui si è ammalato, concentrandosi sulle informazioni relative alla patologia, sugli esami e sulle terapie. La terza fase è quella di elaborazione, in cui il paziente inizia ad adattarsi alla malattia e a gestire le proprie difficoltà. Quarta e ultima fase è quella di accomodamento alla malattia, caratterizzata da una convivenza totale con la sclerosi multipla; anche se è importante considerare che l’individuo, pur accettando la sua patologia, incontri comunque delle difficoltà. Per far sì che queste fasi si evolvano e l’individuo possa giungere a una convivenza quanto più possibile serena e un’accettazione della sclerosi multipla, è fondamentale il ruolo del sostegno psicologico soprattutto nella fase di comunicazione della diagnosi e possibilmente durante i primi anni di malattia (Bonino, 2002).
La psicoterapia con pazienti affetti da sclerosi multipla
L’intervento psicoterapico nella sclerosi multipla può essere definito come l’insieme degli interventi volti a ripristinare un equilibrio emotivo e relazionale ottimale in una persona malata e in difficoltà, promuovendo le risorse dell’individuo e dell’ambiente. Tale complesso di interventi si propone di favorire il processo di accettazione e adattamento alla malattia, evidenziano le distorsioni cognitive, i vissuti emotivi e i comportamentali disfunzionali correlati alla sclerosi multipla, che inducono il paziente a modificare aspettative e obiettivi di vita e ad “arrendersi” passivamente alla propria condizione.
I fini dell’intervento psicoterapico sono quelli di ridefinire il concetto di sé e ristrutturare le relazioni con gli altri e il proprio progetto di vita con l’obiettivo di conseguire un adattamento alla condizione di malattia, che ambisca al miglior inserimento possibile del soggetto nel proprio ambiente con il più elevato livello di qualità della vita che la disabilità consenta. Compito del terapeuta è riconoscere le difficoltà del paziente, valutandone i bisogni espressi e le potenzialità, facendo attenzione alla complessa interazione tra gli aspetti di base della personalità e gli effetti che la malattia produce sul piano fisico, cognitivo e relazionale. Alla base di ogni tipo di intervento psicologico con pazienti affetti da sclerosi multipla c’è l’ascolto della sofferenza emotiva di chi è toccato dalla malattia e il riconoscimento del malato come persona.
Primo obiettivo del clinico, quindi, deve essere quello di stabilire la cosiddetta “alleanza terapeutica”. Il dare spazio, il tollerare la sofferenza del paziente rappresenta un aspetto integrante delle cure, da garantire in vista dell’umanizzazione delle stesse. Un aspetto importante della psicoterapia con pazienti affetti da sclerosi multipla è il problema della motivazione al trattamento, il condizionamento imposto dalla malattia sul processo terapeutico e la presenza di tematiche ricorrenti legate ai vissuti psicologici più tipici della sclerosi multipla.
Gli interventi richiedono una modulazione in relazione alla fase e alla gravità della malattia; nelle fasi iniziali risultano più rilevanti i problemi correlati all’impatto con la diagnosi, con la conseguente necessità di riassestamento delle relazioni familiari e sociali, mentre in quelle più avanzate, con l’instaurarsi dei deficit neurologici, divengono più pressanti i problemi assistenziali e correlati alla gestione dell’handicap. L’intervento terapeutico quindi dovrebbe essere globale, finalizzato alla presa in carico delle sofferenze esperite dai pazienti nella convivenza con la cronicità e invalidità della malattia neurologica e all’attivazione di risorse familiari e sociali, in modo che il paziente possa partecipare pienamente alla vita familiare e sociale nel pieno rispetto delle sue capacità residue. Tale intervento dovrebbe inserirsi nell’ottica di un’assistenza integrata che metta assieme l’apporto di diverse competenze e figure specialistiche sulla base di una “neuroriabilitazione”.
Nell’affrontare una psicoterapia con pazienti affetti da sclerosi multipla è necessario considerare non solo il disturbo, le caratteristiche di personalità, il sistema di apprendimento del paziente, ma anche la precarietà dell’adattamento dovuta alle caratteristiche cliniche della malattia. Diventa, quindi, ancora più importante porre attenzione alle procedure sottostanti il processo di cambiamento, operazionalizzare il disagio riportato dal paziente e l’obiettivo dell’intervento, e progettare un intervento di mantenimento che tenga conto della precarietà della condizione clinica.
La maggior parte degli studi è concorde nel sottolineare gli effetti benefici di una terapia integrata, in cui l’utilizzo della psicoterapia abbia come finalità il trattamento dei sintomi psichici, una maggiore aderenza ai trattamenti, la riduzione dei sintomi fisici, la prevenzione delle ricadute del disturbo psicologico, ed un maggior benessere bio-psico-sociale in termini di migliori relazioni con i familiari e le figure sanitarie.
Gli studi presenti in letteratura hanno preso in considerazione vari tipi di psicoterapie, dai gruppi di sostegno e i gruppi di auto-aiuto con supporto psicologico, alle terapie più strutturate come la psicoterapia cognitivo-comportamentale. La maggior parte degli studi clinici è concorde nel sottolineare l’effetto positivo della psicoterapia nella gestione delle problematiche psicologiche, specialmente di tipo depressivo.
Uno studio di particolare interesse è stato condotto da Tesar, Baumhackl, Kopp, & Gunther (2003), che ha integrato teorie e tecniche psicologiche diverse in un programma di trattamento singolo: strategie di tipo cognitivo-comportamentale applicate alla gestione dei fattori di stress individuali e correlati alla malattia ed esercizi di rilassamento muscolare progressivo sul corpo, con lo scopo di migliorare la percezione e l’immagine del proprio corpo. Sono stati istituiti due gruppi, di cui uno sperimentale ed uno di controllo. I pazienti appartenenti al gruppo sperimentale sono stati sottoposti a colloqui di sostegno non strutturati, in cui si trattavano le problematiche legate all’accettazione di malattia.
A tutti i pazienti sono stati somministrati questionari per la quantificazione della sintomatologia depressiva (BDI), del grado di soddisfazione relativa all’immagine corporea (FKB-20), delle modalità di coping della malattia (FKV-LIS SE) e dell’ansia di stato (S.T.A.I. X-1). I questionari sono stati somministrati prima dell’inizio, alla fine del trattamento e a due mesi dalla fine. Sono stati arruolati 14 pazienti nel gruppo sperimentale, divisi in due gruppi, e 15 nel gruppo di controllo, per una durata complessiva di 6 mesi. Sono state effettuate con il gruppo sperimentale sei sessioni di terapia.
Nella prima sessione, i pazienti sono stati informati sulle regole del gruppo e sulle strategie terapeutiche. Nella seconda sessione sono stati proposti il modello di gestione dello stress, le strategie di coping cognitive e di distrazione da utilizzare in situazioni di stress ed è stata effettuata la prima serie di esercizi per il rilassamento muscolare secondo Jacobson, abbinata ad esercizi di fantasia guidata. Nella terza sessione sono state approfondite le modalità di coping implementando attività di role-playing che favorissero l’uso di strategie di coping focalizzate sul problema, e sono stati approfonditi gli esercizi di rilassamento muscolare progressivo. Nella quarta sessione sono stati affrontati gli aspetti psicosociali della malattia, discutendo i cambiamenti di ruolo connessi all’eventuale disabilità e alla restrizione dell’autonomia, con lo scopo di aumentare il senso di autostima ed efficacia personale del paziente attraverso la consapevolezza delle proprie potenzialità attraverso esercizi corporei. Nella quinta sessione sono state esplicitate le strategie di coping che favoriscono l’adattamento alla
sclerosi multipla, con particolare attenzione all’applicabilità delle strategie apprese in un contesto ecologico. Nella sesta sessione sono stati proposti esercizi volti a migliorare la consapevolezza del proprio corpo, con lo scopo di aumentare la capacità di discriminare i propri movimenti, di diventare consapevoli dello spazio interno del proprio corpo e di prestare attenzione al senso del tatto. Infine gli sperimentatori hanno richiesto una valutazione orale e scritta del programma di trattamento. I risultati del questionario valutativo completato dai pazienti del gruppo sperimentale hanno mostrato un alto grado di accettazione della terapia. I pazienti del gruppo sperimentale hanno presentato una minore sintomatologia ansioso-depressiva rispetto al gruppo di controllo ed hanno utilizzato modalità di coping focalizzate sul problema piuttosto che sulle emozioni.
Un interessante studio condotto da Mohr, Cox, Epstein, & Boudewyn (2002) riguarda il trattamento della fobia in pazienti affetti da sclerosi multipla a cui è prescritta la cura con interferone, che prevede l’autosomministrazione.
Il campione era costituito da 8 pazienti con sclerosi multipla affetti da fobia specifica per l’iniezione cui veniva prescritto l’interferone beta-1a. Tutti i pazienti sono stati sottoposti a 6 sedute cognitivo-comportamentali a cadenza settimanale della durata di 50 minuti circa, con lo scopo di ridurre l’ansia legata all’iniezione e aumentare il senso di auto-efficacia. Il trattamento prevedeva una valutazione clinica e una cognitiva condotta alla baseline, dopo il trattamento e a tre mesi dalla fine del trattamento. Lo studio ha previsto 6 sessioni: nella prima sessione il terapeuta ha introdotto il modello cognitivo-comportamentale dell’ansia, sottolineando la connessione tra pensieri, emozioni e comportamento e informando il paziente sulle caratteristiche psicologiche e fisiologiche delle risposte ansiose. Il paziente è stato informato sulle modalità di esecuzione degli homeworks. Inoltre, è stato proposto un modello di auto-valutazione dell’ansia chiamato SUDS (scala delle unità soggettive del distress), in cui il paziente ha sviluppato una gerarchia degli stimoli ansiosi legati all’iniezione, ordinati dal meno al più ansiogeno e si è sottoposto a brevi esercizi di rilassamento.
Nella seconda sessione il terapeuta, basandosi sulla gerarchia di stimoli ansiosi compilata dal paziente, ha proposto la tecnica di desensibilizzazione sistematica, in cui il paziente si espone, attraverso l’immaginazione, agli stimoli ansiogeni precedentemente graduati, gestendo la risposta ansiosa attraverso gli esercizi di rilassamento. Nella terza sessione il terapeuta ha introdotto le tecniche di ristrutturazione cognitiva, in cui vengono esplorati i pensieri disfunzionali legati all’iniezione e alla malattia in generale. Nella quarta sessione i pazienti si sono autosomministrati il farmaco con l’assistenza del terapeuta per monitorare l’effettivo uso del rilassamento, la giusta tecnica di somministrazione e le tecniche cognitive di gestione dei pensieri legati all’iniezione. Solitamente, i pazienti riportano elevati livelli d’ansia prima di cominciare l’auto-somministrazione e un incremento del senso di auto-efficacia personale immediatamente dopo aver effettuato l’iniezione. Nella quinta sessione i pazienti hanno ripetuto la procedura di auto-somministrazione del farmaco, presentando un livello d’ansia minore rispetto alla sessione precedente e svolgendo la procedura più velocemente. Nella sesta sessione il terapeuta ha chiesto al paziente di prospettare un piano di prevenzione delle ricadute, identificando pensieri e situazioni che potrebbero favorire l’insorgenza dell’ansia e formulando un piano per fronteggiare adeguatamente le situazioni problematiche.
I risultati ottenuti indicano che sette pazienti hanno acquisito, nel corso dei sei incontri, la capacità di auto-somministrarsi il farmaco, mentre l’ottavo ha acquisito tale capacità dopo sette incontri. Il follow up a tre mesi indica che sette degli otto pazienti hanno mantenuto l’abilità acquisita, mentre l’ottavo ha scelto volontariamente di non somministrarsi il farmaco, pur rimanendo capace di farlo.
Mohr, Staley, & Alison (2003) hanno inoltre rivolto la loro attenzione alla fatica, un altro importante sintomo della sclerosi multipla, che impatta significativamente sulla qualità di vita dei pazienti. L’obiettivo dello studio era verificare se il trattamento della depressione con psicoterapia cognitivo-comportamentale individuale o psicoterapia supportiva espressiva di gruppo o trattamento farmacologico riducesse il grado di fatica esperito da 60 pazienti. La psicoterapia cognitivo-comportamentale individuale è stata condotta secondo le procedure e le metodiche convenzionali, così come la terapia supportiva espressiva di gruppo. I risultati mostrano che il grado di fatica esperito dai pazienti si è ridotto significativamente durante il corso del trattamento e si è associato a riduzione della sintomatologia depressiva. I risultati non sono stati influenzati dalla tipologia di trattamento.
Foley, La Rocca, Sanders, & Zemon (2001) hanno invece concentrato il loro studio sulla riabilitazione delle disfunzioni sessuali nelle coppie con sclerosi. Gli autori si sono proposti di valutare l’efficacia di un intervento psicoeducazionale e di counselling per la riabilitazione delle disfunzioni sessuali, della soddisfazione e della comunicazione tra coniugi in pazienti affetti da sclerosi multipla e nei loro partner. Entrambi i membri della coppia sono stati valutati al momento del reclutamento, all’inizio e alla fine del trattamento. Nella prima sessione sono state fornite informazioni relative alle cause, alla natura e ai trattamenti farmacologici che possono interferire con l’attività sessuale di coppia. Nella seconda fase si è provveduto ad individuare la tipologia delle difficoltà sessuali per coppia e ad implementare il programma delle attività sessuali da svolgere. Nella terza è stato effettuato un intervento di counseling focalizzato sul miglioramento delle abilità sessuali attraverso esercizi corporei di tipo sessuale e tecniche di ristrutturazione cognitiva dei pensieri e comportamenti che contribuiscono a mantenere il disturbo sessuale.
Inoltre è stato affrontato il tema del miglioramento delle abilità comunicative delle coppie attraverso l’applicazione della terapia cognitivo-comportamentale e del training delle abilità comunicative che ha previsto tre fasi: nella fase educazionale, sono state fornite informazioni relative ai problemi sessuali e di comunicazione della coppia; nella fase di ripetizione sono state individuate, con l’aiuto del terapeuta, le strategie necessarie alla risoluzione delle difficoltà comunicative; nella fase applicativa le coppie hanno applicato le strategie apprese nella vita quotidiana. I risultati indicano che nella condizione “trattamento” le coppie presentano un significativo miglioramento rispetto alla fase di “attesa del trattamento”, nelle abilità di problem solving, nella comunicazione affettiva e nella soddisfazione maritale e sessuale.
Wiesel, Norton, Roy, Storrie, Bowers, & Kamm (2000) hanno rivolto il loro studio all’applicazione della tecnica di biofeedback nel trattamento di pazienti affetti da sclerosi multipla con stipsi, incontinenza fecale o entrambi i sintomi. Lo studio sottolinea come il biofeedback possa assumere un’importanza rilevante nel management di pazienti con disfunzione pelvica o rettale, che spesso riportano un’incoordinazione dei muscoli del pavimento pelvico. Tutti i 13 pazienti reclutati sono stati sottoposti ad un intervento della durata di quattro sessioni, caratterizzato da un insieme di tecniche comportamentali e farmacologiche, con follow up a 14 mesi.
Tali studi mostrano come l’intervento terapeutico abbia come obiettivo primario la riduzione di sintomi depressivi e la promozione di una buona aderenza alle terapie farmacologiche specifiche. Il lavoro terapeutico deve procedere poi considerando le emozioni contrastanti che caratterizzano le prime fasi della sclerosi multipla, per accompagnare il paziente stesso verso un migliore adattamento nell’impatto quotidiano con i disturbi e le limitazioni causate da essa. Successivamente l’obiettivo psicoterapico prevede un lavoro sull’autoefficacia del paziente, sulle proprie risorse interne fondamentali per convivere con la malattia per poi ricostruire la sua identità e i suoi progetti di vita. Di grande importanza è anche il lavoro supportivo effettuato con le famiglie ed il partner del paziente, sia nel momento della comunicazione della diagnosi che per aiutare le famiglie nel rielaborare i sentimenti di rabbia e gli atteggiamenti iperprotettivi che potrebbero danneggiare il senso di indipendenza e autoefficacia costruito con il paziente.
È importante che l’individuo a cui venga diagnosticata la sclerosi multipla si affidi a una équipe multidisciplinare specializzata nella patologia e accetti il sostegno psicologico sia nella fase della comunicazione della diagnosi che nelle fasi successive. Il percorso psicoterapeutico può aiutare il paziente e la sua famiglia a mettere in atto buone strategie di coping per affrontare la malattia, per poter gestire l’aspetto sociale e relazionale-affettivo e superare le sfide che la malattia presenta nel corso della quotidianità.