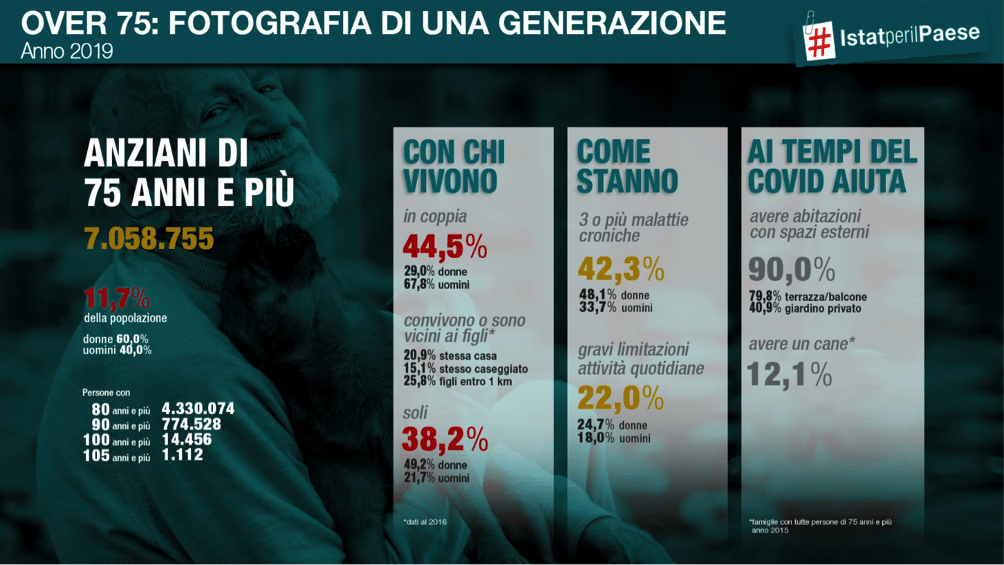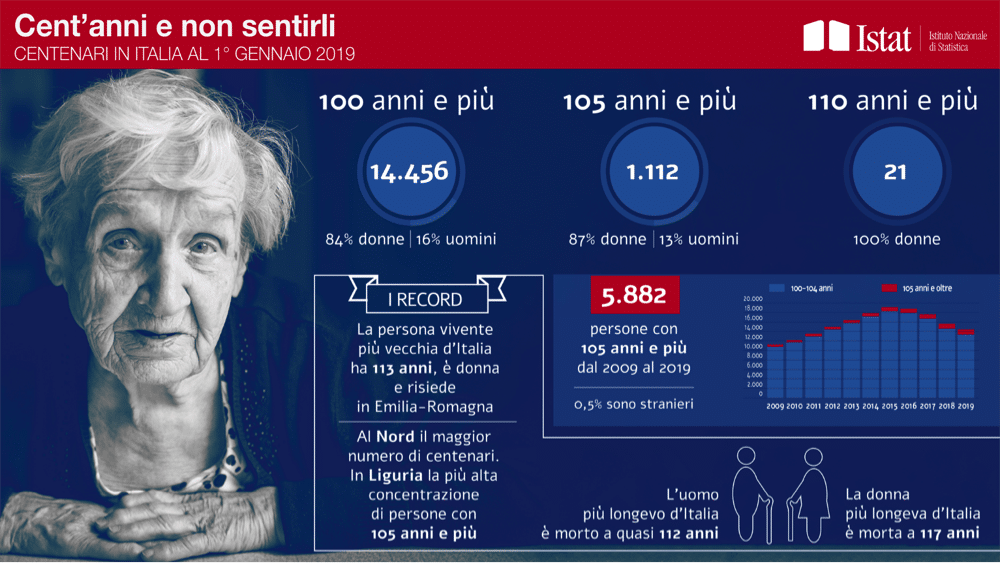L’uomo nelle relazioni
Percepiamo chiaramente che le relazioni, nel bene e nel male, influenzano le nostre emozioni. Oggi sappiamo che, mediante le emozioni, le relazioni influenzano anche la nostra fisiologia determinando benessere o sintomi vaghi.
La natura umana è inscindibilmente relazionale, vale a dire che l’uomo trova la propria ragion d’essere solo nel giusto rapporto con le altre persone. In quest’ottica il successo e, più in fondo, la propria realizzazione altro non sono che una comunicazione riuscita con chi ci sta intorno.
È atteggiamento nevrotico l’usare il proprio potenziale per manipolare gli altri anziché crescere personalmente: il nevrotico prende il controllo e usa gli altri in compiti che non riesce a fare da solo.
Invece la persona in sintonia con l’ambiente non dirige ma integra le proprie capacità tra le persone con le quali condivide affetti o esperienze professionali.
In ciò la lingua di una comunità svolge un grande fattore di integrazione sociale. Attraverso la stessa lingua è possibile far passare la comunanza delle persone. Per questo in una occupazione di un paese straniero gli occupanti lo dotano della loro lingua.
Una stessa lingua non è mai uguale a sé stessa. Ci sono differenze diatopiche (dialetti regionali), diastratiche (tra classi sociali), diafasiche (dei registri, pensiamo che quello di uso quotidiano è diverso da quello ufficiale), diamesiche (dei mezzi di comunicazione). Ma ogni lingua costituisce un unicum, un sistema originale con cui il singolo popolo si dota di senso in vista dell’esperienza. Ogni lingua ha delle particolarità. Nella grammatica ebraica il termine ‘vocale’ significa letteralmente ‘movimento’ per indicare che, in questa lingua (e anche in aramaico), le vocali cambiano spesso nella formazione delle parole. In aramaico biblico i femminili che escono in –U servono a formare gli astratti. In sanscrito la E indoeuropea è resa A. L’Italiano deriva dal toscano. Sono tutti segni di una organizzazione interna che promana da ciò che si chiama lo spirito specifico di un popolo.
Il nostro psichismo deve procedere in armonia con il mondo esterno. La ragione ci spinge a scegliere quelle azioni con le quali interagiamo con gli altri. L’emotività ci fa sentire che quelle sono scelte giuste. Un padre avverte emotivamente che lavorare coscientemente e impiegare il proprio tempo per la famiglia è qualcosa di giusto.
Parte razionale e parte emotiva devono quindi andare di pari passo. Nel caso in cui non ci vadano, la psicoanalisi parla di ‘personalità come se’: colui che fa una cosa, è all’apparenza impeccabile buon padre di famiglia, buon impiegato, ma dentro avverte che tutto questo lo soffoca e non esprime adeguatamente la propria interiorità. Certamente la società nasce sempre per una certa repressione delle pulsioni, tuttavia tale repressione non deve essere parossistica, altrimenti l’individuo diviene macroscopicamente malato, cioè terribilmente insoddisfatto, senza un senso.
Nel fr. 46 di Eraclito vi è una frase, che in greco suona così: tēn de oiēsin ierēn nouson. Di solito si traduce: ‘L’opinione individuale è malattia sacra’ (epilessia). Ma la resa di oiēsin come ‘opinione individuale’ risponde a un significato tardivo del sostantivo greco. Probabilmente Eraclito voleva dire che quando l’emotività prende il sopravvento sulla ragione abbiamo una malattia sacra.
Nella realtà quotidiana ciò che sentiamo è la bussola di ciò che facciamo. Se la logica inconscia, basata sulla emotività, prende il sopravvento sulla ragione, abbiamo un delirio. Quando la ragione soffoca la sensazione più vera che i cuori avvertono, siamo schizoidi.
A questo punto il successo di una azione equivale a imporre il nostro potenziale contro le varie interferenze che accadono. Abbiamo la formula: P = p – (le + li). Vale a dire che la nostra performance (P) equivale al nostro potenziale totale (p) meno le interferenze interne (li) e le interferenze esterne (le). Le interferenze interne sono i pensieri che ci demotivano (non ce la farò mai). Le interferenze esterne sono gli ostacoli lungo la via. Il potenziale totale sono le capacità che abbiamo per compiere una azione. Mettiamo che dobbiamo andare in città: l’automobile è il potenziale totale, l’interferenza interna è la voglia di non farcela a guidare fino in città, l’interferenza esterna sono le buche lungo il percorso.
Ora, il nostro potenziale totale non è mai solo un fattore individuale: noi abbiamo capacità se intessiamo relazioni soddisfacenti. Se vogliamo diventare medici, il nostro potenziale è costituito non solo dal tempo che abbiamo impiegato a studiare, ma anche da quel professore che ha insegnato bene una materia e ci ha predisposti a imparare con successo. La interferenza interna potrebbe essere costituita dalla discrasia tra pensiero e emozione: vogliamo diventare medici per un progetto razionale di guadagnare denaro, ma non ne abbiamo una convalida emozionale, per cui non ci impegniamo abbastanza perché non sentiamo quella strada veramente nostra.
La maggior parte delle situazioni problematiche che ci capitano non sono reali, ma stanno unicamente nella nostra mente. La mente subisce queste interferenze:
- Parte razionale: errata valutazione del reale, mediante inferenze non esatte: per esempio, se il partner non sta abbastanza con noi, tendiamo a inferire che non ci voglia più bene, ma il suo atteggiamento potrebbe dipendere anche da altre cause, come il fatto che stia male;
- Parte subconscia: risente delle pressioni relazionali e culturali: per esempio, in base a tali pressioni le donne sono indotte a concedersi il meno possibile, invece gli uomini il più possibile, ma questo crea difficoltà nei rapporti di coppia;
- Parte inconscia: istinti e pulsioni aggressiva e libidica sono tutti elementi che non rispondo all’ideale dell’io come ce lo immaginiamo, e questo crea innumerevoli problemi in noi e nel rapporto con gli altri.
Il nostro comportamento è lo specchio di ciò che siamo. È possibile conoscere una persona analizzando ciò che fa, anche senza introspezione. Per questo l’individuo in sé equilibrato ha un comportamento che lo fa stare in relazione ottimale con gli altri. Ma dall’altra parte la relazione squilibrata fa ammalare il singolo.
La qualità delle nostre relazioni influisce sulla qualità della nostra vita. Ma quando stiamo male con qualcuno ne viene inficiata anche la nostra salute fisica. Le relazioni costituiscono uno degli ambiti di ciò che ci crea stress, ma non l’unico. Oggi sappiamo per certo che molti problemi di salute hanno a che fare con lo stress: sono i cosiddetti sintomi vaghi (colon irritabile, stanchezza cronica, acidità, dolori di stomaco, disturbi digestivi, alterazioni del ritmo cardiaco, dolori cronici, difficoltà a dormire, ansia, e così via). Si stima che più della metà degli accessi ai medici sono causati da questi malesseri. Uno stress prolungato altera gli equilibri del nostro organismo fino all’insorgenza di questi sintomi.
Lo stress è la pressione a cui siamo sottoposti dall’ambiente. Il nostro organismo ha un sistema deputato a far fronte alle richieste più o meno impegnative che ci provengono dall’ambiente: è lo Stress System. Attraverso di esso ci adattiamo volta per volta all’ambiente. È costituito dal sistema nervoso autonomo, formato dal sistema simpatico (attivo soprattutto di giorno, che ci predispone all’azione) e dal sistema parasimpatico (attivo soprattutto di notte, che ci predispone al recupero e alla riparazione).
Quando le richieste dell’ambiente sono eccessive, lo stress si trasforma in sovra-stress, fino allo stress cronico quando il fattore stressante è prolungato nel tempo. Alcuni hanno identificato in questo stress eccessivo la causa di tutte le malattie. È come se ci fosse un logorio continuo che non fa attivare il simpatico la mattina quando serve e non permette il recupero la notte con l’attivazione del parasimpatico.
Il sistema nervoso autonomo è molto complesso: agisce in connessione con molti altri centri nervosi. Risponde a tutto ciò che accade nell’ambiente integrando gli input esterni con quelli interni. Il suo scopo è di coordinare tutti questi input per una finalità precisa: l’adattamento.
Il ricercatore che meglio ha chiarito questo aspetto è Porges. Nel nervo vago (che corrisponde al sistema parasimpatico) ci sono due unità: quella dorsale e quella ventrale. Pertanto, in base alle conclusioni cui è giunto Porges, il sistema dello stress è composto da tre sottosistemi: simpatico, parasimpatico dorsale, parasimpatico ventrale. il simpatico si attiva in tutte quelle situazioni che richiedono una mobilitazione dell’energia (impegni quotidiani, pericolo). Il dorsale si attiva quando dobbiamo bloccarci (minaccia e paralisi conseguente). Il ventrale si attiva quando possiamo rilassarci e ricaricarci. Sono tre risposte diverse di adattamento globale all’ambiente.
Questi sistemi si attivano sulla base della percezione che abbiamo dell’ambiente: è la neurocezione, la capacità inconscia che ogni organismo ha di captare i segnali che giungono dall’ambiente. Tutto questo è mediato dalle emozioni, che sono in grado di attivare i vari sistemi. Le emozioni sono espedienti che noi abbiamo per valutare l’ambiente. Allora se l’imperativo del sistema dello stress è di adattarci per garantire la nostra sicurezza, questo deve rispondere alla valutazione che noi facciamo della realtà (emozione) sulla base della percezione esterna e interna.
Quando percepiamo l’ambiente sicuro, si attiva il sistema ventrale (stiamo a riposo). Quando percepiamo un ambiente potenzialmente pericoloso, si attiva il simpatico (ci prepariamo all’azione: attacco o fuga). Quando percepiamo un ambiente minaccioso, si attiva il dorsale (è il freezing: ci blocchiamo dalla paura).
Questi tre sistemi si sono sviluppati nella storia dell’evoluzione progressivamente, in tempi differenti. Il più antico è il dorsale: ancora oggi gli animali inferiori si bloccano davanti a una minaccia, la lumaca si ritira, altri fingono di essere morti. In seguito sorse una risposta più evoluta: l’attacco o la fuga, quindi si sviluppò il sistema simpatico. Per ultimo venne il ventrale, quello dei mammiferi, che è una modalità di adattamento e difesa che coinvolge anche i propri simili: l’organismo cerca il senso di sicurezza stando insieme ai membri della propria specie.
Anche le relazioni sono fonte di pericolo e di minaccia (un capo nocivo o una famiglia irosa), pertanto, possono allertare i relativi sistemi. In questo modo scatta lo stress e i sintomi vaghi. Percepiamo chiaramente che le relazioni, nel bene e nel male, influenzano le nostre emozioni. Oggi sappiamo che, mediante le emozioni, le relazioni influenzano anche la nostra fisiologia determinando benessere o sintomi vaghi.
Il cervello che abbiamo nell’intestino è un insieme di neuroni che ha una sua autonomia. Il cervello cranico tramite il nervo vago influenza il secondo, e viceversa. Il microbioma è l’insieme di batteri che stanno nell’intestino e che manda segnali al cervello cranico. Si parla di 2 kg di microbioma intestinale e in tutto il corpo. Alterazioni del microbioma intestinale creano problemi nell’asse dello stress e nel comportamento. Esso:
- Regola l’attività metabolica;
- Produce molecole;
- Regola l’epigenetica (espressione genica).
Prende le fibre insolubili, come la cellulosa, che non riusciamo a digerire, per produrre altre sostanze. Le sostanze così prodotte sono usate per regolare l’epigenetica delle nostre cellule in senso anti-infiammatorio. Per questo la fibra è utile al nostro organismo.
Il microbioma produce vitamina K, vitamine del gruppo B, acido folico, acido butirrico. L’acido butirrico è prodotto dalla fermentazione delle fibre e favorisce la termogenesi (produzione di calore) e l’ossidazione degli acidi grassi che mangiamo, cioè la loro degradazione. Questo acido migliora anche la sensibilità all’insulina.
Il microbioma intestinale produce i neurotrasmettitori, che fanno funzionare il cervello cranico. Per esempio, l’acetilcolina, che produce molti altri neurotrasmettitori e ormoni. Il glutammato, che è eccitatorio. Il GABA, che è inibitorio. Il cervello funziona bene se c’è la giusta connessione tra attivazione e inibizione. Non solo, ma le relazioni tra persone sono neurologicamente una attività nella quale sono coinvolti GABA e glutammato.
I tipi privi di microbioma intestinale hanno mostrato un aumento dell’attività motoria legata all’ansia.
Il microbioma viene distrutto da:
- Antibiotici (è necessario un lasso di tempo di 2 anni per recuperare il microbioma completo dopo aver assunto antibiotici);
- Sterilizzazione disfunzionale (quando la pulizia del corpo è eccessiva);
- Eccesso di carboidrati (che favorisce i batteri patogeni);
- Infiammazione cronica.