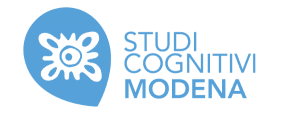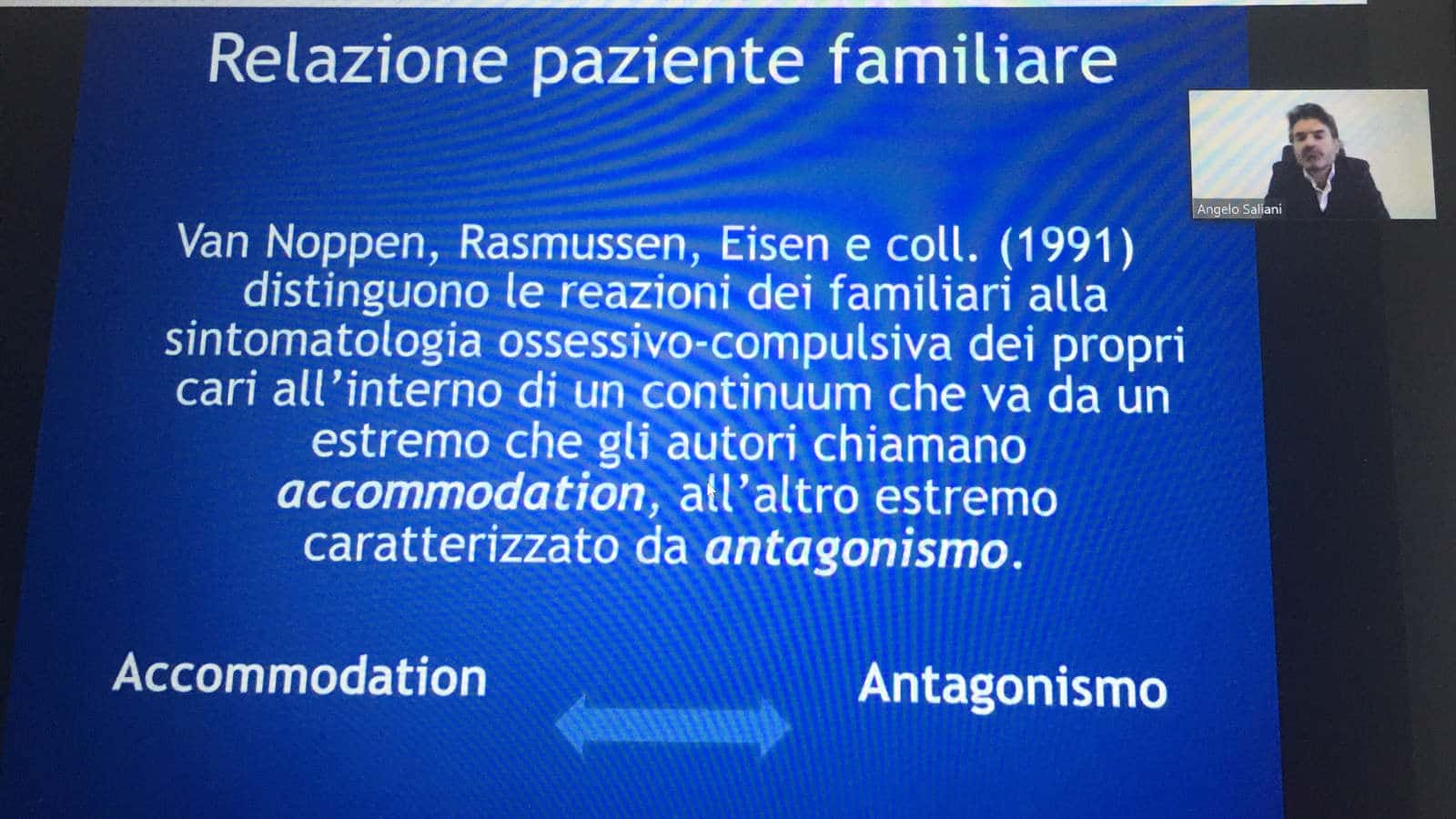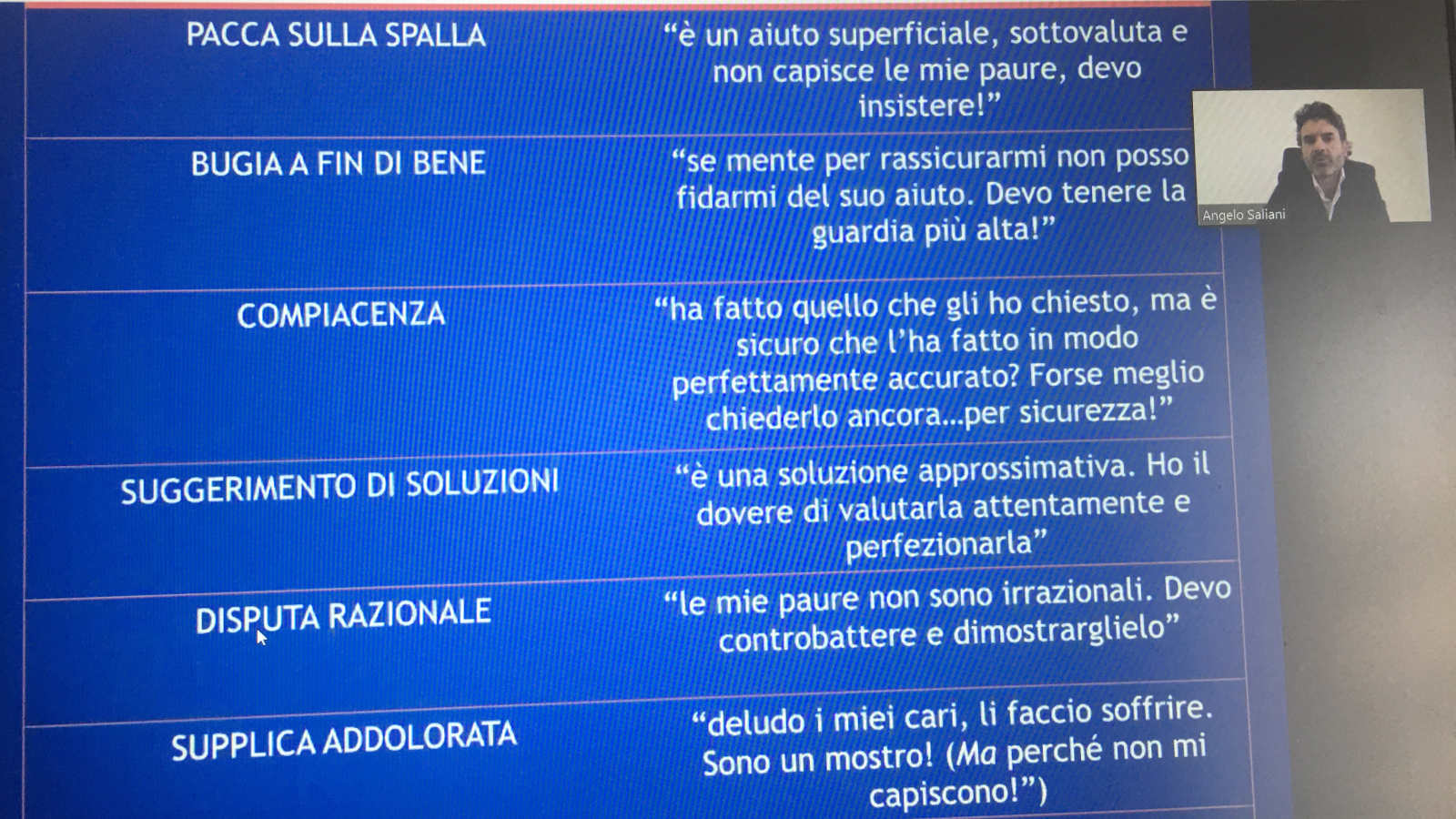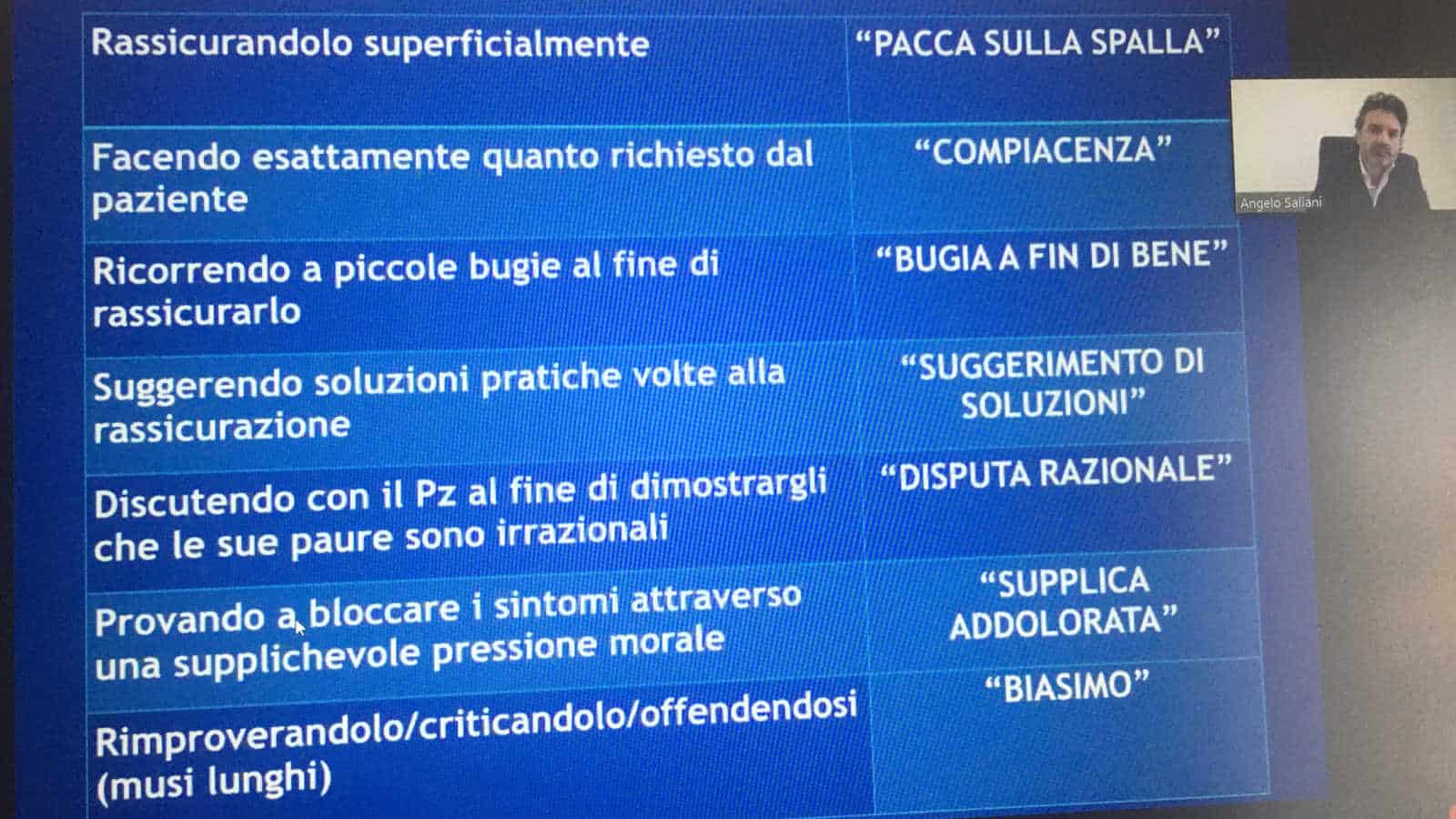Conscious Project: Systemic Path for the Rights. Il trattamento dei Sex Offenders presso la Casa Circondariale di Cassino (FR)
Il progetto Conscious è stato reinterpretato in termini di trattamento clinico-sanitario ed è stato adattato al contesto intramurario del carcere di Cassino (FR) affrontando le diverse sfide di un trattamento sanitario di questo tipo nei confronti dei sex offenders.
Abstract
A differenza di molti altri Paesi, che hanno sviluppato programmi trattamentali volti a prevenire la recidiva nei soggetti autori di reati a carattere
sessuale, in Italia, malgrado l’adesione formale del Paese alla Convenzione di Lanzarote che ne sollecita l’implementazione, questo non è avvenuto: la legislazione italiana ha però inasprito le pene per gli autori di reati sessuali introducendo la legge 69/2019, nota come “Codice Rosso” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 173/2019 ed entrata in vigore dal 09/08/2019. È un provvedimento volto a rafforzare la tutela delle vittime dei reati di
violenza domestica e di genere, inasprendone la repressione tramite interventi sul Codice Penale e sul Codice di Procedura Penale con conseguenti pene più severe per gli autori di reati a carattere sessuale. Il Progetto “Conscious” (ispirato al programma trattamentale del C.I.P.M. – Centro Italiano per la Promozione della Mediazione Giulini e Xella, 2011) propone invece un approccio al problema del tutto nuovo per l’Italia.
Il progetto, finanziato dalla Comunità Europea, per il 2019-2020, coordinato dalla UOC ASL Frosinone Dipartimento di Salute Mentale e delle Patologie da Dipendenza, ha permesso l’attivazione del trattamento all’interno della Casa Circondariale di Cassino (FR), un carcere attivo dal punto di vista trattamentale, ma dalla struttura tradizionale, in cui gli autori di reati sessuali (o sex offender) sono reclusi in una sezione protetta. In questo contesto difficile e poco preparato all’intervento specifico sugli autori di reati sessuali, si è scelto di utilizzare un tipo di trattamento ispirato al Good Lives Model, che restituisce l’importanza che merita all’alleanza terapeutica tra utenti e operatori e concentra il focus sugli obiettivi da raggiungere oltre che sui rischi da evitare.
Questo lavoro illustra come il progetto Conscious sia stato reinterpretato in termini di trattamento clinico-sanitario e come tale programma sia stato adattato al contesto intramurario del carcere di Cassino (FR) affrontando le diverse sfide di un trattamento sanitario di questo tipo nei confronti di una utenza non solo “protetta” ma “ibernata” ed esclusa da interventi di prevenzione della recidiva e di miglioramento del livello di qualità della vita, non solo all’interno del carcere ma anche all’esterno, dopo la fine della detenzione. Il Progetto Conscious rappresenta un esempio di modello di rete intersistemico, che unico in Italia, ha evidenziato possibilità di replicabilità anche in altri contesti; in particolare verrà evidenziata l’imprescindibilità di un sistema sanitario che tutela le vittime e che pone il grande tema della presa in carico e trattamento dei reati sessuali da parte dei servizi della sanità pubblica.
1. Introduzione
I reati a sfondo sessuale rappresentano, nell’immaginario collettivo, l’azione umana più riprovevole e pericolosa per la società civile perché mina le basi stesse di essa, ovvero la tutela dei più deboli; tali elementi si acuiscono se le vittime sono minori e quindi ancora più indifesi e quando a volte le pene non corrispondono a ciò che emotivamente l’atto richiama in ognuno di noi. Nel fotografare il fenomeno l’ultima rilevazione Istat, pubblicata nel 2018, stima che siano 8 milioni 816mila (43,6%) le donne fra i 14 e i 65 anni che nel corso della vita hanno subito qualche forma di molestia sessuale e che siano 3 milioni 118mila le donne (15,4%) che le hanno subite negli ultimi tre anni. Circa 1 milione 173 mila donne fra i 15 e i 65 anni hanno subito ricatti sessuali sul posto di lavoro nel corso della loro vita lavorativa. Accanto ad un aumento delle campagne di comunicazione e di interventi a tutela delle vittime si evidenzia un vulnus che richiama stereotipi sociali stratificati e rigidi e che riguardano la possibilità di trattamento degli autori di violenza sessuale al fine di garantire una maggiore protezione alle vittime evitando il fenomeno conosciuto con il nome di vittimizzazione secondaria. Ma chi sono i sex offenders? Quali sono le strutture di personalità e il modo in cui leggono e si rapportano con il mondo esterno?
In questo articolo vogliamo descrivere come l’attuazione di un progetto europeo, che ha visto come principale attuatore un’Azienda Sanitaria pubblica, ha consentito un avvicinamento ad un ambito per gli operatori finora inesplorato e una sfida e un’opportunità di crescita oltre che la sperimentazione di un’offerta terapeutica pubblica molto rara nel suo genere.
2. I Sex offenders
Riprendendo un articolo di Carabellese e ed altri (2012) utilizziamo una frase di Krober del 2009 che ci sembra sempre attuale:
La vera caratteristica del sex offender è in primis una: la non uniformità (Kröber, 2009).
Contrariamente a quello che potrebbe comunemente pensarsi a riguardo, infatti, i sex offenders non costituiscono una tipologia omogenea di individui. Diverso il loro modus operandi, il tipo di comportamento sessuale tenuto, le motivazioni sottese al reato, l’età in cui commettono la loro prima – e talvolta unica – aggressione sessuale. Diversa, inoltre, la vittima, per età, sesso, tipo di relazione (intrafamiliare o non) con l’autore (Carabellese ed altri, 2012)
Gli studi effettuati sulle cosiddette condotte parafiliache (Fornari 1999, Holmes 2002) evidenziano inoltre come l’eziopatogenesi sia quanto mai complessa e non può essere ricondotta a fattori solo unicamente esterni, ambientale e sociali, o solo unicamente intrapsichici; le diverse posizioni, da un lato quella psicologica e dall’altro quella criminologico giuridica complicano l’approccio sia teoretico che clinico e trattamentale a tali comportamenti.
Queste due posizioni, partendo da presupposti diversi, determinano approcci spesso molto diversificati ed esperienze di intervento che in Italia oltre ad essere poco puntiformi difficilmente dialogano.
Tale elemento, riportato all’esperienza del Progetto Conscious, evidenzia la necessità, nell’avvicinarsi a questo campo, di mantenere una visione non riduzionista nell’approccio al tema della trattabilità e rappresenta altresì una guida per gli operatori che nell’ipotizzare un trattamento con gli autori di reato sessuale si trovano a dover rinunciare a categorie classificatorie definite.
L’esperienza di Conscious rappresenta inoltre la sintesi ed integrazione tra le due posizioni precedentemente esposte evidenziando la necessità da parte di un ente pubblico, quale un’azienda sanitaria, dell’occuparsi di un aspetto della salute individuale e collettiva finora poco identificato, poiché principalmente declinato negli aspetti emozionali e di governo del sistema attraverso le azioni di sostegno diretto alle vittime.
3. Clinica e Nosografia: alcune questioni
Il tentativo di classificare e distinguere i comportamenti sessuali devianti da ciò che nelle rappresentazioni sociali del termine può essere definito “normale” ci porta ad evidenziare come i sistemi di classificazione difficilmente riescano ad esaurire una complessità così articolata di atti tanto che spesso risulta difficile effettuare una diagnosi secondo i criteri di frequenza, intensità e durata. L’abuso sessuale, ad esempio, non rientra tra le patologie inserite nel DSM5 a differenza della pedofilia; la conseguenza è che i comportamenti dei sex offenders non possono essere inquadrati clinicamente se non nel capitolo dei Disturbi Parafilici con una forte limitazione relativamente alla varietà dei comportamenti che si riscontrano nella realtà clinica.
Nello specifico per quanto riguarda la Pedofilia, Il DSM 5 l’annovera tra i disturbi parafilici e ne descrive le caratteristiche come fantasie, impulsi sessuali, o comportamenti ricorrenti e intensamente eccitanti sessualmente, che implicano attività sessuale con uno o più bambini prepuberi (di età fino ai 13 anni o inferiore).
Questi aspetti devono produrre un disagio clinicamente significativo o una compromissione in campo sociale, lavorativo o in altra area significativa per il soggetto che deve avere una età minima di 16 anni e avere almeno 5 anni in più del bambino oggetto delle fantasie, degli impulsi e degli atti.
Come illustrato bene nel testo Buttare la chiave? a cura di Giulini e Xella (2011);
Vi sono molti studi e molte riflessioni che pongono problemi rispetto ai criteri così definiti:….non è chiaro cosa significhi il termine ricorrente che si applica alle fantasie, agli impulsi e ai comportamenti; non si comprende se chi abusa di un minore una sola volta sia un pedofilo o no…..inoltre è problematico il criterio di disagio clinicamente significativo soprattutto in relazione alla dimensione della negazione: se non c’è alcuna coscienza di colpa e la condotta risulta egosintonica, non si capisce se i soggetti debbano essere considerati pedofili oppure no, se debbano essere considerati o meno affetti da disturbo psichiatrico
Altri due elementi di criticità risultano essere: il limite di età dei tredici anni …
molti molestatori scelgono vittime puberi ma ugualmente molto giovani
e
il tema degli autori di reato sessuale che appartengono alla fascia di età tardo adolescenziale e per i quali, secondo il DSM V, non può essere fatta diagnosi di pedofilia (ivi, pag. 5)
Da un punto di vista clinico la complessità non risulta minore in quanto la maggior parte degli autori di reato sessuale presenta disturbi di personalità o tratti di essi tra cui i più frequenti sono il disturbo antisociale, il disturbo narcisistico e il disturbo borderline di personalità; quello che ci preme evidenziare sono le caratteristiche ricorrenti che accomunano tali quadri clinici e cioè la incapacità di empatizzare e di decodificare le proprie emozioni e quelle degli altri, l’impulsività, l’instabilità come la caratteristica ricorrente nelle azioni e nelle relazioni, un deficit generalizzato nelle abilità sociali e di metacognizione; non dimentichiamo inoltre come molto spesso nella storia di vita e di sviluppo degli autori di reato sessuale troviamo condizioni di abbandono, neglect, abusi sessuali e violenza, sessualizzazione precoce e in età adulta consumo di alcool e droghe: detto in termini più generali, una storia di infanzia non protetta.
4. Il quadro normativo italiano
Da un punto di vista giurisdizionale l’elemento indicante il cambiamento culturale nel nostro paese è rappresentato dalla legge 66/96 che modifica il concetto di reato sessuale da reati contro la moralità pubblica a delitti contro la persona. Si prende atto quindi del grave danno causato alle vittime di questi reati e se ne inaspriscono le pene. Con la legge 296/98, si introduce l’extraterritorialità, cioè la possibilità di punire gli autori di reati contro minori commessi all’estero (il cosiddetto ‘Turismo sessuale’) e lo sfruttamento di minori a scopo di produzione di pornografia minorile – reato letteralmente ‘esploso’ con la diffusione di Internet.
Per questo stesso motivo, con la L. 38/2006 viene creato il CNCPO (Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online), un reparto della Polizia Postale con il compito di individuare, anche utilizzando agenti sotto copertura, produttori e fruitori di pedopornografia e, – purtroppo molto raramente – di individuare i bambini vittimizzati.
La stessa legge vieta ai condannati per reati sessuali contro minori ogni occupazione che li ponga a contatto con bambini.
Per finire, il cosiddetto “Codice Rosso” (L.69/2019) inasprisce ulteriormente le pene per i reati sessuali (la pena passa da un minimo di 5 a un massimo di 10 a un minimo di 6 e un massimo di 12) specie quelli contro minori di 14 anni, caso in cui viene aumentata di un terzo. Viene introdotto anche il reato di revenge porn, cioè di diffusione di immagini a contenuto sessuale senza il consenso dell’interessato.
A questo intento di crescente tutela per le vittime non corrisponde però, a differenza di quanto accade in altri Paesi, una corrispondente attenzione per la prevenzione di tali reati, prevenzione che passa, oltre che da un auspicabile cambiamento culturale, da un’azione sugli autori che non può e non deve limitarsi alla pura e semplice carcerazione. In primis, perché la Costituzione Italiana (art.27) prescrive che la pena non sia fine a se stessa, ma miri alla “rieducazione del condannato”, in secondo luogo, perché le persone detenute per reati sessuali vivono la carcerazione (come vedremo più oltre) in uno stato di “ibernazione penitenziaria” (Giulini, Vassalli, Di Mauro 2003), fatto di isolamento e inattività, che collude con le loro difficoltà relazionali di base e le accentua. Infine, si tratta di detenuti che un giorno usciranno: e nessun tipo di monitoraggio, supporto o controllo può essere attualmente messo in atto.
Vi sono in realtà, nella legislazione italiana, alcuni cenni alla possibilità di trattamento per questi rei: già nella legge 296/98 si ipotizza un “recupero dei responsabili di tali delitti”, con la previsione di un Fondo ottenuto dai proventi delle attività sanzionate, riservato in prima battuta alle vittime e in via residua al trattamento dei rei che “ne facciano apposita richiesta”. Anche la legge 262/2012 (che recepisce la Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale del 25/10/2007) prevede che i rei di questi reati possano sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno, e che la partecipazione a tale trattamento è valutata ai sensi dell’articolo 4-bis, comma 1-quinquies, della presente legge ai fini della concessione dei benefici.
E infine, il “Codice Rosso” indica la che per gli autori di reati sessuali e di violenza di genere,
la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati.
Purtroppo, a fronte di queste sia pur minime aperture la pratica è molto diversa: l’attuazione di programmi di recupero è compromessa dalla mancanza di fondi destinati allo scopo e alla carenza di personale formato per questo compito. Il trattamento degli autori di reato sessuale, come vedremo più oltre, ha un effetto marcato di riduzione della recidiva (che viene almeno dimezzata) e quindi di protezione della società, ma deve essere erogato secondo linee guida ormai chiaramente stabilite e validate dalla ricerca a livello internazionale.
5. L’esperienze di trattamento
L’idea che la devianza sessuale potesse essere oggetto di trattamento nasce negli anni ’70 del secolo scorso negli Stati Uniti e in Canada, all’inizio su una base nettamente comportamentista: se ogni comportamento umano è frutto di apprendimento, è possibile ‘correggere’ l’interesse sessuale deviante attraverso un ri-condizionamento degli impulsi. Ad esempio associando lo stimolo sessuale deviante (visivo o uditivo) a stimoli sgradevoli, come un odore pungente o disgustoso.
In realtà le cose, purtroppo, non sono così semplici perché, come abbiamo detto più sopra, i sex offender sono un gruppo eterogeneo, e un trattamento ‘taglia unica’ non può dare i risultati sperati. La ricerca degli ultimi trent’anni si è dunque focalizzata sull’individuare le caratteristiche che rendono efficace un trattamento, dove ‘efficace’ sta soprattutto per ‘in grado di massimizzare l’effetto sul rischio di recidiva con il minimo dispendio di risorse’. Così come accade anche in Europa, l’opinione pubblica (e la politica, che spesso ne segue gli umori) non accetta facilmente che un’istituzione governativa impieghi risorse nel trattamento di soggetti universalmente percepiti come perversi e incurabili se non vi è una ragionevole probabilità che tali trattamenti raggiungano lo scopo per il quale sono nati.
Molto presto, quindi, si sviluppa la ricerca sull’efficacia di tali trattamenti. Andrews e Bonta avevano enunciato, già nel 1990 (Andrews, Bonta e Hoge, 1990) il principio Risk-Need-Responsivity (RNR) che sarà rielaborato in ricerche e studi successivi (Bonta 1996; Andrews, Bonta, 2003, 2007). Secondo questo principio, i programmi di prevenzione della recidiva, per essere efficaci, devono essere differenziati in base a:
- Rischio: ogni autore di reato deve ricevere un trattamento di intensità proporzionale al rischio personale di commettere di nuovo un reato;
- Bisogni: i fattori, o bisogni criminogeni, devono essere individuati chiaramente e il trattamento dev’essere mirato su di essi;
- Responsività: la possibilità di imparare dal trattamento va massimizzata attraverso l’impiego di programmi strutturati, di tipo cognitivo-comportamentale, che si sono dimostrati i più efficaci, commisurati alla motivazione, alle capacità e alle risorse dei soggetti.
In altre parole, il principio RNR consiglia di impiegare nel modo migliore le risorse disponibili, indirizzandole soprattutto a persone ad alto rischio di recidiva, concentrandosi sui fattori personali che determinano tale rischio, utilizzando strategie trattamentali di comprovata efficacia e tenendo conto delle differenze individuali.
Va qui sfatato un mito molto diffuso: cioè l’idea che i sex offenders abbiano un’altissima probabilità di tornare a commettere lo stesso reato. In realtà, il tasso di recidiva di questi autori di reato è significativamente più basso di quello dei criminali comuni. Studi effettuati in Paesi dove esiste un controllo dell’autore di reato sessuale anche dopo il rilascio dal carcere ci dicono che il tasso di recidiva medio si attesta sul 17/18%.
Perché, allora, la percezione pubblica del rischio di recidiva è così elevata? (dal 60 all’80%, secondo alcune ricerche); perché i casi che arrivano a conoscenza della pubblica opinione sono quelli più gravi, con grande diffusione mediatica: ancora una volta, dobbiamo ricordare che i sex offenders non sono tutti uguali e che è essenziale, per una prevenzione efficace, individuare che è veramente a rischio.
Perché il principio RNR abbia un senso, bisogna quindi aver chiaro:
- Quali sono i fattori effettivamente collegati alla recidiva.
- In che misura un soggetto presenta tali fattori.
Da allora, i programmi a diffusione nazionale nei vari Paesi hanno un’impronta cognitivo- comportamentale e mirano a ridurre le credenze pro-reato (distorsioni cognitive), a migliorare l’adattamento sociale, a riconoscere la propria responsabilità, a controllare l’impulsività e le tendenze devianti. La ricerca ci dice che programmi di questo tipo arrivano a ridurre della metà il rischio di recidiva.
Nel corso del tempo, a una impostazione molto tecnica e standardizzata, mirata essenzialmente alla prevenzione della recidiva, si è aggiunta una sempre maggiore attenzione alla motivazione personale al cambiamento e alla relazione terapeutica. Si afferma l’idea, ben nota in psicologia generale, che mirare ad un obiettivo positivo, a ottenere qualcosa cui si tiene, è molto più motivante e coinvolgente, anche ai fini di un’alleanza di lavoro, di quanto non sia mirare ad evitare qualcosa. Il focus del trattamento deve includere quindi il raggiungimento di obiettivi personali positivi, che di per sé sono anche fattori protettivi rispetto alla recidiva perché permettono di avere una vita migliore. Il Good Lives Model di Ward (Ward e Beech, 2006; Ward e Gannon 2005, Ward e al., 2013) introduce questo importante cambiamento, che attualmente è stato implementato nella maggioranza dei programmi tratta mentali. Va da sé che una maggiore attenzione alla persona implica un’attenzione alla relazione: di qui l’importanza che a condurre il trattamento siano operatori motivati, con buone capacità relazionali e che possano usufruire di una formazione continua ( Marshall e al. 1999,2006).
In Italia, fino ad oggi gli unici interventi trattamentali sono stati realizzati ad opera di associazioni del privato sociale, non collegate fra loro. Tra queste il C.I.P.M. (Centro Italiano per la Promozione della Mediazione) è l’unica ad avere una rete disseminata sul territorio italiano e ad implementare programmi, che, pur nelle differenze di contesto, hanno molti punti in comune tra loro. I programmi del C.I.P.M. si ispirano alle linee guida internazionali e per questo motivo sono diventati, come vedremo più oltre, il punto di riferimento di Conscious.
Centrale, in questa impostazione, è il concetto di ‘rete’: la collaborazione con le Istituzioni – direzione e personale di polizia penitenziaria, area educativa, UEPE, Magistratura di Sorveglianza, Avvocati, Polizia di Stato, ecc. – è cruciale per il buon funzionamento del trattamento, che dovrebbe proseguire anche fuori dal carcere (come in effetti avviene nelle sedi C.I.P.M. di Milano e Roma) creando un vero e proprio “campo trattamentale”, ossia un insieme di luoghi, persone, istituzioni e programmi di intervento che, tutti insieme, costituiscono l’ambiente del trattamento (Giulini e Scotti, 2014) e il punto di riferimento cui rivolgersi nelle situazioni critiche.
6. Il Progetto Conscious
Il progetto europeo Conscious, cofinanziato dal Programma Rights, Equality and Citizenship Programme of the European Union (2014-2020), condotto dal Dipartimento Salute Mentale e Patologie da Dipendenza della ASL Frosinone, in partenariato con il Garante dei Detenuti del Lazio, con l’European Network for the Work with Perpetrators of Domestic Violence e con il Centro Nazionale Studi e Ricerche sul diritto della Famiglia e dei Minori, ha l’obiettivo di contrastare la violenza di genere intervenendo sulla riduzione del rischio di recidiva per gli autori di violenza. Conscious è sostenuto, oltre che dalla Casa Circondariale di Cassino e di Frosinone, dal Provveditorato del Lazio, Abruzzo e Molise (P.R.A.P) del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, dal Tribunale di Sorveglianza di Roma, dall’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Frosinone (UEPE) e dall’Ordine degli Avvocati di Frosinone. Il Network è aperto alla partecipazione di ogni attore pubblico e privato impegnato sul tema. Il progetto è attivo da ottobre 2018 si concluderà a Dicembre 2020 dopo una sospensione dovuta all’emergenza COVID-19. La prima riflessione rispetto al progetto riguarda il ruolo dei servizi sanitari nel trattamento degli autori di violenza di genere; perché il sistema sanitario pubblico dovrebbe interessarsi a questo tema? Dall’analisi dell’evoluzione del fenomeno che abbiamo descritto precedentemente abbiamo verificato come in molti paesi europei il servizio sanitario si occupa da molto tempo delle donne vittime di violenza. Gli studi clinici e le organizzazioni sanitarie hanno evidenziato i disturbi, le patologie ed i danni fisici e psichici nelle persone che hanno subito violenza. In Italia, ad esempio, con il cosiddetto Codice Rosa, le singole aziende sanitarie strutturano percorsi di ascolto e protezione delle vittime a partire dal triage di Pronto Soccorso. Maggiori resistenze e minore attenzione è invece rivolta agli autori di violenza. Da questo nasce la prima riflessione che ha dato origine al progetto: occuparsi solo delle vittime non garantisce la tutela della salute della collettività; buttare la chiave di una cella, per usare una metafora, non garantisce la non reiterazione del comportamento; anzi il carcere congela le emozioni e i pensieri in un luogo e tempo sospeso che rischia di deflagrare in ulteriori agiti violenti. Se la tutela della salute prevede interventi di prevenzione, tra cui la prevenzione della violenza di genere, significa allora che il sistema sanitario deve occuparsi anche degli autori di violenza poiché ciò equivale a realizzare un’importante azione di prevenzione della recidiva e della vittimizzazione secondaria e quindi di prevenzione di ulteriori danni per la salute delle vittime e della collettività.
6.1 Gli Obiettivi
L’ obiettivo generale del progetto è la sperimentazione e modellizzazione di una rete di cooperazione intersistemica. Nessuna istituzione o organismo può da solo realizzare una politica di prevenzione della violenza. Pertanto l’interesse non è stato esclusivamente quello di garantire i trattamenti specialistici per i perpetretor, quanto di definire e stabilizzare accordi e funzionamento del lavoro congiunto di molte istituzioni ed organismi pubblici, del privato sociale e della società civile. Le parole chiave del progetto Conscious sono sintetizzabili in: modello, rete, cooperazione, inter-sistema. Gli stakeholders rappresentano nell’impianto i veri protagonisti di progetto poiché costituiscono la rete di base necessaria al funzionamento del modello in sperimentazione. E’ una rete che abbraccia tutte le parti del sistema: l’Amministrazione Penitenziaria (attraverso singoli Istituti, Amministrazione centrale e sistema della probation) ed il Sistema di giustizia (con gli Avvocati e la Magistratura), ma anche la comunità nel suo complesso con la rete delle associazioni e il no profit. L’impianto teorico e il modello di trattamento sono stati appresi da CIPM Milano che vanta un’esperienza pluridecennale in questo campo. Il gruppo di CIPM ha fornito gli strumenti teorici e clinici garantendo la supervisione durante tutto il progetto. Questo approccio utilizza un tipo di trattamento ispirato al Good Lives Model, che sottolinea l’importanza della relazione con gli operatori da un lato, e concentra l’attenzione sugli obiettivi da raggiungere (oltre che sui rischi da evitare), dall’altro.
Gli obiettivi specifici sono sintetizzabili:
- Prevenzione della recidiva di sex offenders e autori di violenza domestica attraverso un modello di cooperazione inter-sistemica tra istituzioni socio-sanitarie, giuridico e penitenziarie.
- Incrementare le competenze professionali (personale sanitario, penitenziario, volontario) per la successiva realizzazione dei Programma di Trattamento dei perpetrator.
- Sviluppare nel contesto locale un modello di lavoro interistituzionale stabile nel tempo (Standardizzazione di metodi e procedure, valutazione impatto economico finanziario – studio di fattibilità per il trasferimento del modello intersistemico).
- Evitare che processi di esclusione contribuiscano a favorire recidive (attivazione di interventi sui perpetrator, internamente ed esternamente al carcere, per il loro reinserimento sociale).
6.2. L’esperienza di Conscious nella sezione Sex Offender del Carcere di Cassino
Prima dell’avvio del progetto Conscious presso il Carcere di Cassino, il detenuto autore di reato sessuale era impegnato prioritariamente nella ricerca di benefici di legge che gli permettessero di riottenere in tempi brevi la libertà, oppure, eventualmente, di scontare il residuo della pena attraverso forme alternative alla detenzione. Le sue principali attività potevano riguardare la terapia farmacologica, la scolarizzazione, qualche attività creativa (teatro, poesia, lavorazione artistica dei metalli, ecc…), gli incontri con l’Area Trattamentale e l’Area Sanitaria e con altre figure che entrano in contatto occasionale e circostanziato con il detenuto, quali Caritas, UEPE, Sportello Mediazione Culturale, Sportello Diritti Del Detenuto, Sportello Garante dei Detenuti.
L’approccio del Progetto Conscious sposta il focus attentivo del detenuto autore di reato sessuale. Questo approccio utilizza un tipo di trattamento ispirato al Good Lives Model, che sottolinea l’importanza della relazione con gli operatori da un lato, e concentra l’attenzione sugli obiettivi da raggiungere (oltre che sui rischi da evitare) dall’altro. In particolare, l’approccio usato nel progetto Conscious trae ispirazione dal programma PETRAAS, ideato in Québec dal gruppo di lavoro che fa capo ad André McKibben e all’Istituto penitenziario di Rocher-Percé (Mckibben, 2011), tradotto e adattato al contesto italiano da Carla Maria Xella per il C.I.P.M.
I suoi punti principali possono essere così riassunti:
- Gli autori di reati sessuali non sono diversi dagli altri esseri umani. Il loro comportamento deviante è il risultato di un insieme di fattori interagenti di natura neurobiologica, ambientale, familiare e di variabili intervenienti che hanno facilitato la scelta deviante. Infatti è di comune riscontro che nelle loro storie personali vi siano genitori e/o caregiver disfunzionali, segreti di famiglia più o meno censurati e relazioni precoci disturbate.
- Tra questi vi sono i fattori di rischio individuali, ma anche gli obiettivi personali che vanno a formare l’idea che ognuno di essi ha di una vita buona, soddisfacente e felice. Anche questi obiettivi non sono diversi da quelli degli altri esseri umani. I principali obiettivi, o beni primari, sono: Vita (abitazione, mezzi di sostentamento, salute, benessere), Relazioni, Conoscenza, Indipendenza e scelte personali, Competenza (sentirsi capaci in ciò che si fa), Comunità (sentirsi parte di un gruppo), Serenità mentale, Felicità e piacere, Spiritualità (dare un senso alla propria vita) e Creatività. Ciò che è diverso, ed inaccettabile, sono i mezzi che hanno usato per raggiungerli.
Al momento della presentazione del progetto sono stati contattati 54 candidati detenuti presso le Sezioni “Protetti” della CC di Cassino (FR) che hanno ricevuto una prima valutazione individuale. A seguito di ciò 24 detenuti hanno aderito all’iniziativa firmando il primo Treatment Agreement e di questi 12 hanno firmato il secondo Treatment Agreement per partecipare al Trattamento Intensificato.
Si sono tenuti 2 incontri di gruppo con cadenza settimanale e colloqui di sostegno individuale e di tutoring con cadenza quindicinale. Da notare che prima di arrivare a questa condizione ottimale si è dovuto lavorare sulla paura del giudizio, l’etichettamento, la fantasia del complotto (trattamento = ammissione di colpa = recrudescenza giudiziaria), la negazione del reato e l’autoproclamazione di innocenza a oltranza. Sono questi gli aspetti sui quali il detenuto autore di reato sessuale mostra maggiore resistenza. Primo momento indispensabile del progetto è stata la valutazione del profilo personale (e personologico) di ogni partecipante per l’individuazione e la valutazione dei fattori di rischio; si tratta della fase in cui un operatore tutor (nella nostra esperienza, uno psicologo) somministra un’intervista semi-strutturata, mirata all’individuazione dei fattori criminogeni, la STABLE 2007, e, quando possibile, compila uno strumento attuariale, lo Static 99R, sulla base del fascicolo penale del soggetto. Tali reattivi sono stati nuovamente somministrati al termine del trattamento (test- retest) per la valutazione del cambiamento.
In questo elaborato non parliamo semplicemente di reato, ma più appropriatamente di danno; questo sia perché il progetto mette al centro la persona, sia perché il fine ultimo è la ricerca di soluzioni idonee affinché la pena non risulti una fine (o fine a se stessa), ma rappresenti l’occasione per un nuovo inizio in una più ampia visione di giustizia riparativa. In questo modo il lavoro di gruppo ha spostato il focus attentivo dei partecipanti dalla dimensione reocentrica alla dimensione del danno, cambiando radicalmente il modo di percepire e percepirsi rispetto al reato e alla vittima.
Tutto questo è stato possibile anche perché il gruppo ha concepito la possibilità di una vita diversa, attraverso l’esercizio e lo sviluppo di adeguate abilità sociali e la sperimentazione di nuovi rapporti significativi, quelli con gli operatori appunto, pronti a trasmettere fiducia nella possibilità di alternative con la pensabilità di future azioni reali nelle loro vite quotidiane fuori dal carcere. Non sono mancati tuttavia momenti di scompenso emotivo del gruppo legati all’inatteso trasferimento di alcuni utenti in trattamento presso altri istituti, da una parte, e successivamente all’improvvisa sospensione delle attività di gruppo causa COVID-19, dall’altra.
Durante tutto il lockdown gli operatori del progetto si sono impegnati nel “mantenere” in essere il trattamento attraverso colloqui individuali di tutoring e sostegno psicologico, (nel rispetto delle norme anti COVID previste dal DPCM 04/03/2020), impedendo che gli utenti si sentissero abbandonati soprattutto in un momento così delicato come quello in cui stavano scrivendo la lettera che la vittima avrebbe scritto loro (esercizio dell’empatia). Ma proprio l’emergere di questi vissuti emotivi ha reso più forte la consapevolezza di quanto i legami all’interno del gruppo fossero diventati intensi, preziosi per persone che nella loro vita troppo spesso hanno sperimentato rapporti perlopiù disfunzionali, ambivalenti e privi di connotazione empatica. Da questi elementi si è partiti per rielaborare il senso della perdita, dell’attesa, del doversi mettere nuovamente/veramente in gioco dando importanza alla costruzione di relazioni sociali che fanno rete, la stessa che può proteggere e prevenire “il danno”. Grazie al lavoro svolto attraverso questo progetto, il carcere inizia ad essere percepito non più (non solo) come luogo di punizione/detenzione, ma come luogo di trattamento, crescita e trasformazione che intende favorire cambiamenti di interesse sociale, perché pone in primo piano la qualità della vita e la sicurezza della comunità, nella quale il detenuto sarà parte integrante ed inserito in nuovi (e rinnovati) rapporti sociali.
7. Riflessioni conclusive
I detenuti sex offenders vivono da sempre isolati, reietti e stigmatizzati dalla società, anche carceraria, che li definisce “infami”. Forse anche le istituzioni hanno inconsciamente colluso con questa “cultura del mostro”, un individuo da tenere lontano il più possibile dalla società “sana” perché autore di azioni spregevoli. Tali atteggiamenti discriminatori hanno generato nei confronti degli autori di reati sessuali deprivazione sociale ed ambientale e una difficoltà ad accedere a eventuali benefici di legge che, pur prescindendo dall’ostatività dell’art. 4/bis prevista per questo tipo di reati, rimangono inascoltati (perché ignorati), e/o malamente accolti, come se nell’esplicita ostatività espressa dal codice penale ci sia una implicita ed imperante ostatività del codice morale di chi, a vario titolo, li sorveglia e tratta con questo tipo di detenuti.
Il Progetto Conscious, ponendo al centro dei propri obiettivi l’integrazione di attività trattamentali e percorsi di rieducazione e reinserimento sociale, favorisce l’attribuzione di una maggiore dignità all’individuo/detenuto sia all’interno che all’esterno del Carcere. Inoltre, se da un lato il progetto Conscious promuove crescita e cambiamento nel detenuto, dall’altro si configura come un occasione per attivare cambiamenti e trasformazioni nello spazio più ampio delle Istituzioni, non solo detentive. La portata innovativa infatti, se da una parte mira a garantire trattamenti specialistici per gli autori di violenza di genere e sex offender, dall’altra getta le basi per poter creare un sistema, una rete, stabile nel tempo e che duri oltre la fine della detenzione stessa.
The research leading to this publication has received funding from the Rights, Equality and Citizenship Programme of the European Union (2014-2020) under the agreement n. 810588. This publication reflects only the author’s view and the European Commission is not responsible for any use that may be made of the information it contains.