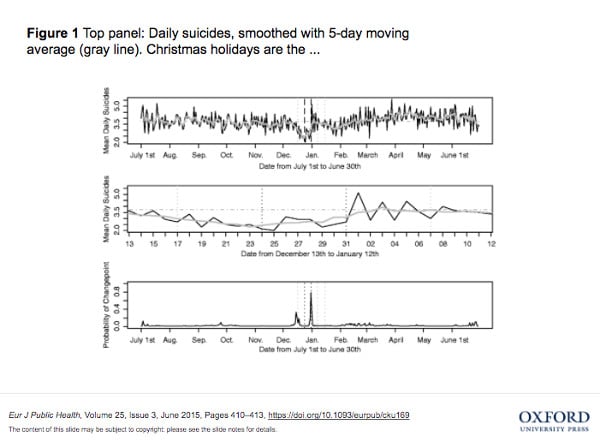Il piacere dell’assenza di dolore … Non fatto della stessa sostanza del padre
Il piacere e la dipendenza sono due concetti fortemente correlati tra loro, sebbene la differenza cruciale tra una persona dipendente da sostanze e non sia la manifestazione della crisi di astinenza.
Capacità e, spesso, bisogno di dividere e contrapporre idee e percezioni, nessuna esperienza umana può avanzare queste peculiarità quanto il piacere.
Nel tempo si è assistito al conflitto tra quanti lo definivano un male da evitare (soprattutto secondo la matrice cristiana), e quanti vedevano nello stesso il centro dell’azione, il fondamento dell’esistenza ideale (Lorenzo Valla nel Rinascimento, Hobbes, Leibniz, Kant).
Le differenti prospettive, riviste e ampliate, hanno continuato a contrapporsi attraverso la storia dell’uomo, sino ad arrivare alle più recenti enunciazioni della psicoanalisi di Sigmund Freud, per il quale è l’inconscio il luogo dei desideri e delle pulsioni ostacolato, solo parzialmente, dalla rimozione che il principio di piacere vorrebbe vedere appagati.
Anche un gesto semplice e banale può essere espressione del piacere, purché determini contentezza, benessere, piacevolezza nell’individuo. Lo stesso agisce a livello psicologico con evidenti ricadute fisiche: pertanto siamo in grado di distinguere ciò che è bello e gratificante, da ogni cosa che provoca dolore e sofferenza.
Non a caso si tende a ripetere esperienze piacevoli, piuttosto che esperienze noiose e insignificanti, ma quando la ricerca del piacere diventa ossessiva, l’uomo finisce per diventarne dipendente.
A tal proposito, pur non essendoci una piena condivisione di significato, per dipendenza si intende un’alterazione del comportamento che da semplice e comune abitudine diventa una ricerca patologica attraverso mezzi, sostanze e comportamenti che sfociano in una malattia. Tale condizione non fa riferimento soltanto all’abuso di alcool e di sostanze stupefacenti. Si può sviluppare una dipendenza patologica legata anche ad un comportamento.
Il piacere e la dipendenza sono due concetti fortemente correlati tra loro, sebbene la differenza cruciale tra una persona dipendente e non, sia la manifestazione della crisi di astinenza.
Se chiedessimo alla persona dipendente la motivazione (e la reiterazione) dell’assunzione o dello specifico comportamento, la risposta più sincera sarebbe legata al piacere (da intendersi anche come assenza di dolore o malessere).
Tutte le società hanno cercato di imporre un confine tra il piacere e la sua degenerazione, al fine di limitarne la caduta nel vizio, per usare un’espressione datata, o nella dipendenza patologica, preferendo un linguaggio più scientifico.
In verità, le moderne tecniche d’indagine sul funzionamento del nostro cervello ci dicono che molti comportamenti che consideriamo virtuosi (ad es. meditare o fare beneficenza), attivano lo stesso circuito neurale su cui agiscono le sostanze stupefacenti legali o illegali e che i confini tra il socialmente accettabile e il moralmente deplorevole non sono poi così netti, chiamando in causa fattori cari alle neuroscienze ma anche e soprattutto aspetti culturali, morali e giuridici che danno forma al nostro essere e alla nostra identità all’interno della società (Linden, 2012).
Non meno dirimenti sono i fattori soggettivi, strettamente connessi alla storia e all’immaginario personale (Abraham, 2002).
Dall’organizzazione narcisistica delle strutture infantili in grado di indebolire fino, in alcuni casi, ad eliminare la parte adulta della personalità dal controllo del comportamento di Meltzer, alla persona affetta da sindrome maniaco depressivo di Rosenfeld, dal concetto di attaccamento ansioso o immaturo di Bowlby alla sostituzione dell’oggetto d’amore con la sostanza di Kohut, dalla ricerca del piacere su base nevrotica di Adler e sino all’impossibilità di addivenire ad una precisa struttura di personalità del tossicomane di Bergeret, in molti hanno cercato di definire, catalogare, sintetizzare uno dei legami (consumatore-sostanza) più problematici e complessi.
Alcuni studiosi hanno individuato associazioni specifiche tra sostanza e dolore mentale. È stato ipotizzato che il consumo di cocaina possa essere associato a problemi depressivi e ipomaniacali, mentre i narcotici sarebbero utilizzati per difendersi dai sentimenti di rabbia, dal desiderio di una relazione simbiotica con la madre, spesso per alleviare la depressione (Blatt, 2006; Bowlby, 1980).
L’uso di sostanza può essere interpretato anche come automedicazione in chiave difensiva e adattativa e non esclusivamente regressiva come suggerito dal paradigma psicodinamico (Wieder, 1969; Kaplan, 1978; Milkman e Frosch, 1973).
Considerata la contestuale presenza di fattori genetici, fisiologici, neurochimici, psicopatologici, ambientali, socio-culturali è difficile e fuorviante rispetto alla possibilità di decodificare la tossicodipendenza rinunciare ad un approccio multidisciplinare e multiparadigmatico. Non cogliere la complessità dell’eziopatogenesi del fenomeno significherebbe essersi avvicinati, aver pensato, studiato, teorizzato ma certamente non aver davvero conosciuto l’area articolata e complessa delle dipendenze patologiche.
Il piacere come assenza di dolore. La nuova (vecchia) eroina
Inevitabilmente, si assiste come per qualsiasi altro mercato ad un’evoluzione dei consumi e delle sostanze. Se la cannabis oggi raggiunge una percentuale di THC al 20-25% a fronte di una presenza del 5-8% di qualche decennio fa, l’eroina ha visto un forte ritorno sulla scena del consumo sebbene con modalità di lavorazione, tagli e potenza differenti rispetto alla prima grande diffusione dei primi anni ’80.
Secondo il Dipartimento alla salute degli Stati Uniti, tre quarti dei tossicodipendenti del Nord America ha iniziato assumendo farmaci antidolorifici regolarmente prescritti dai medici.
Hydrocodone (vicodin®), oxycodone (oxycontin®, percocet®, percodan®, tylox®) e il potentissimo fentanyl (assunto per via orale, ma anche sniffato, iniettato o fumato) sono tutti farmaci antidolorifici che determinano nel tempo pervicaci dipendenze. Quando, poi, diventa complicato riuscire ad avere le regolari prescrizioni mediche il passaggio agli oppiacei di strada è pressoché inevitabile.
Il dolore può accompagnarsi al piacere: ma quanto l’uomo nella storia abbia cercato di evitarlo, al di là della sua utilità filosofico-morale, resta evidente.
Le persone non assumono droghe per ragioni inspiegabili, senza una motivazione più o meno consapevole o per mere questioni di immoralità: con l’uso di sostanze le persone cercano di procurarsi piacere.
Dissimulare, mistificare questa visione, non provare a comprendere ciò che sottende il ricorso a queste pratiche, non cercare di tradurre il fascino che le stesse esercitano significa precludersi la possibilità di comprendere in maniera più ampia, continuando a promuovere politiche inefficaci.
Forse non è casuale che oggi le droghe più diffuse negli Stati Uniti, peraltro avendo già varcato i confini degli stessi spingendosi sino al Canada e all’Europa, siano gli antidolorifici a base di oppiacei. Si stima che nel 2016 circa 11,5 milioni di americani abbiano fatto uso di prodotti di questo tipo, mentre nello stesso anno i casi di morte per overdose dovuti a eroina o oppioidi siano stati 42.249 a fronte dei 33.091 dell’anno precedente.
Tre aziende negli Stati Uniti hanno prodotto l’88% degli oppiacei: Mallinckrodt, Actavis Pharma e Par Pharmaceutical. Purdue Pharma è la quarta, e viene considerata responsabile di aver avviato la produzione di massa (Molinari, 2019).
Nell’opera autobiografica Confessioni di un oppiomane (1821), Thomas De Quincey definisce l’effetto prodotto come «l’abisso del divino godimento» (De Quincey, 1973, p. 48), una sorta di insperata felicità in grado di allontanare ogni affanno e tormento della vita quotidiana.
L’oppio non è la sostanza della prestazione, del desiderio sessuale, del desiderio di stare con gli altri, così come scrive Jean Cocteau (2006, p. 27): «fumare l’oppio è abbandonare il treno in marcia, e occuparsi d’altro che della vita, è occuparsi della morte».
Se questo è ciò che caratterizza l’effetto, in merito ai rischi e alle conseguenze, molto potrebbe dirsi a cominciare dalle stesse parole dell’autore francese che definisce l’astinenza come «un silenzio simile al pianto di mille bambini le cui madri non tornano ad allattarli» (ibid.).
Made in China sold in USA
Se l’industrializzazione della seconda metà del XIX secolo può essere vista come causa del primo grande boom degli oppiodi, quanto la società sta vivendo oggi in termini di deindustrializzazione, delocalizzazione, globalizzazione non sembra foriero di minore sperdimento.
Negli Stati Uniti la diffusione non è omogenea, preferendo la periferia al centro, le aree multietniche deprivate culturalmente e socialmente, le zone dove più forte si è avvertita la contingenza economica negativa degli ultimi anni con tutte le implicazioni che questa ha comportato in termini di occupazione e investimenti. Dopo l’11 settembre 2001, con il declino dei tre pilastri – Dio, patria e famiglia – del mito americano, la condizione umana sembra essersi ridisegnata radicalmente; e in Europa lo scenario sembra molto simile.
La contrazione delle spese per lo stato sociale, operata in termini di previdenza fino alla vera e propria sostituzione della stessa con una sorta di assegno d’invalidità con il quale coprire anche i costi per l’uso di oppiodi contro il dolore, a partire dagli anni Ottanta, ha aperto ad una forma anomala di ammortizzatore sociale. Acquisire farmaci per poi rivederli per strada è diventato così un modo per ottenere guadagni e possibilità di sopravvivenza. È un po’ ciò che accade nel nostro paese con la vendita di metadone di strada, che ha finito per determinare l’espansione del sommerso e la determinazione per la dipendenza di un suo nuovo status sociale. Se il lavoro manca, se le prospettive occupazionali non sono incoraggianti, chissà che per il sistema la vendita tra consumatori non sia preferibile ai furti, agli scippi, ai piccoli crimini predatori operati a danno della comunità? In altri casi non si spiegherebbe come in molte città le piazze e i luoghi di spaccio, pur noti a tutti, continuino ad operare quasi del tutto indisturbati.
L’interesse di chi vende è quello di potenziare il prodotto per soddisfare le aspettative del cliente, il guadagno è legato all’affidabilità e alla forza della merce. La regola aurea del proibizionismo, formulata nel 1986 dall’attivista americano Richard Cowan, è chiara: «più cresce la repressione contro le droghe ‘più le droghe diventano potenti’» (Sullivan, 2018, p. 59). Più sono rilevanti i rischi che i produttori corrono, più salgono i prezzi che i consumatori sono disposti a pagare chiedendo prodotti piccoli, maneggevoli e potenti e soprattutto che possano offrire garanzie rispetto a sostanze a basso costo e ad alta pericolosità (soprattutto dovuta al taglio). Forse è anche per questo che dalle amfetamine si è passati alle metamfetamine, dalla cannabis con thc al 10-12% si è arrivati a quella con una percentuale al 22-25%, sino al fentanyl, oppioide concentrato, cinquanta volte più potente dell’eroina. Un chilo di eroina può fruttare sino a 500.000 dollari, un chilo di fentanyl ne vale 1,2 milioni.
Il problema del fentanyl, per i trafficanti, è che è quasi impossibile da dosare correttamente. A causa della sua composizione microscopica bisogna tagliarlo con altre sostanze per poterlo iniettare, e tagliarlo significa giocare con il fuoco. Basta l’equivalente di pochi granelli di sale per toccare il cielo con un dito, ma qualche granello in più può uccidere (Sullivan, 2018, p. 59).
Il fentanyl è fabbricato in Cina e facilmente reperibile nel dark web.
Dal 2013 le morti per overdose unitamente a quelle da altri oppiodi sintetici sono aumentate di sei volte, superando quelle dovute a ogni altra droga. Per quanto riguarda l’Italia, secondo fonti ministeriali, nell’ultimo anno sono aumentati i sequestri del farmaco così come gli episodi di overdose.
Negli Stati Uniti, su richiesta del Center for Disease Control and Prevention, nel 2017, i medici hanno cominciato a diminuire le prescrizioni, precedentemente favorite da tutta una politica di incentivazioni operata da alcune case farmaceutiche, nonostante solo nel 2015 il governo americano abbia speso 504 miliardi di dollari per gestire l’epidemia da oppioidi. Scarseggiando l’offerta, si assiste ora all’inondazione sul mercato illegale di eroina e prodotti simili ad opera dei cartelli messicani della droga: dieci dollari a dose a fronte degli ottanta necessari per la pillola di oxycontin®. L’aumento delle prescrizioni, dunque, ha creato la domanda con una risposta del mercato immediata e massiccia fuori dalle prescrizioni stesse.
Per quanto riguarda il Vecchio Continente, lo scenario non sembra così differente. Se le droghe sono sempre più pure, ci sarebbe da chiedersi come mai i prezzi rimangono stabili. Alla domanda, Andrew Cunningham, alla guida dell’Unità sulle nuove sostanze dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (emcdda), ha risposto:
«È vero. Ma questo avviene per un semplice motivo di convenienza. Per quanto riguarda la vendita al dettaglio, la transazione si verifica solitamente per strada. Quindi è necessario fissare un prezzo tale che i soldi vengano scambiati in fretta. Da quanto ricordi, una dose di eroina viene venduta per 10 euro. Il prezzo rimane fisso, anche se la purezza aumenta o diminuisce. Non fanno salire il prezzo di pochi euro, perché se uno paga con una banconota da 20, si perde tempo per cercare il resto esatto attirando l’attenzione.» (Civillini, 2016).
È altra la strategia del mercato per fidelizzare il cliente e ampliare la platea dei clienti. Il consumatore non è il centro. È talmente ampio il possibile bacino di acquirenti che il consumatore è solo un numero. La partita (è il caso di dirlo) si gioca sulla sostanza. La sostanza è il centro dell’interesse del mercato.
A tal proposito vanno fatte delle debite precisazioni: negli ultimi mesi sui media nazionali si è letto e parlato di eroina gialla.
«L’eroina gialla, molto semplicemente, è cloridrato di eroina (o di grado 4 o eroina bianca) che presenta una sfumatura giallina, a causa della scarsità di solventi chimici in Afghanistan, che non consente di lavarla bene. È solo eroina bianca leggermente colorata perché un po’ più sporca.
Alla luce di ciò, non ha alcun senso insistere sul colore perché questo distrae dal vero problema: nocciola, bianca o giallina che sia, si tratta sempre di eroina e su questo occorre attirare l’attenzione, senza alcuna enfasi sul colore. Non è il colore a determinare la possibile pericolosità dell’eroina ed insistere sulla pericolosità dell’eroina gialla conduce, immancabilmente, a banalizzare tutte le altre forme di eroina.
La stessa enfasi, purtroppo, viene posta sull’aumentata percentuale di principio attivo, che è un dato costante in tutto il mondo da circa un ventennio. Nei primi anni del secolo, quando la mortalità per overdose da eroina era enormemente più alta, la percentuale media di principio attivo nell’eroina sequestrata era di gran lunga inferiore a quella odierna.» (Giancane, 2018).
È il caso di aggiungere che: «il grado di purezza dell’eroina è importante, ma non è il fattore più importante a condizionare il numero di decessi, in un’ottica di salute pubblica e quindi di grandi numeri; tanto è vero che in passato si sono raggiunti picchi di mortalità da overdose di circa 6 volte maggiori rispetto ad oggi (1566 eventi nel 1996) pur in presenza di eroina a concentrazione media intorno alla metà di quella odierna.
Ci sono dunque almeno altri due fattori di maggiore importanza nel modulare il rischio di morte.
Uno è legato a disponibilità e costo dell’eroina in una data area, ritenuto nella Letteratura scientifica il fattore di maggior peso, perché a maggiore accessibilità, dipendente da presenza e prezzo della sostanza, ovviamente corrisponde maggiore diffusione e quindi maggiore probabilità di incontro tra la sostanza e il soggetto che non ne ha tolleranza.
Questo dà senso all’attività di studio dei traffici, dei mercati e dei modelli di spaccio, così come al sequestro delle partite importate dovunque sia effettuata, e non solo dove si riscontrano concentrazioni più elevate del principio attivo.
Il secondo è la disponibilità, l’accessibilità e l’efficienza degli interventi evidence-based di terapia e di riduzione del danno (o del rischio, come qualcuno preferisce dire): diffusione di trattamenti oppioidi agonisti (ancor più se anche a bassa soglia), e prevenzione selettiva e indicata (es. drug checking anche autogestito delle sostanze, promozione di stili di consumo a minor rischio per esempio mai da soli, mai contemporaneamente, mai senza naloxone, mai somministrando tutto in una volta).
Questi interventi riducono la domanda di eroina e mitigano i comportamenti più rischiosi, come descritto da innumerevoli studi in tutto il mondo.» (De Bernardis, 2018).
La paura di ciò che non si conosce, la miopia con cui la politica si rivolge al fenomeno, unitamente al continuo richiamo alla pena e alla sua certezza, al risarcimento che il reo deve alla società, alla paura quotidianamente alimentata dai media, all’atteggiamento maturato in controtendenza all’espandersi dei crismi della globalizzazione rispetto a tutto ciò che è ‘altro’, sono elementi fondanti e condizionanti rispetto alle politiche sociali.
Ancora lontani dal comprendere che non è verso il dipendente patologico che deve orientarsi la ‘guerra’ alle droghe ma al non perdere mai di vista i quattro pilastri indicati per le politiche sulle droghe sanciti dai documenti dell’Unione Europea (vedi Strategia dell’UE in materia di droga 2013-2020), ossia: Contrasto al narcotraffico, Prevenzione, Cura e Riduzione del Danno.
Siamo tutti fisiologicamente alla ricerca del piacere così com’è nella natura dell’essere vivente, e per la nostra sopravvivenza non ci stanchiamo di inseguirlo ma siamo anche (chi più, chi meno) addolorati, neo-traumatizzati economici, alla ricerca di accoglienza e ascolto, ostaggi dei consumi e del narcisismo, in cerca di sollievo e, dunque, tutti potenzialmente a rischio.
Filosofi, letterati, teologi, sociologi (ben più importanti di chi scrive) si sono chiesti se il dolore potesse avere una sua utilità per l’uomo. A mio modesto parere potrebbe averlo purché il rimedio non sia così facilmente reperibile e sempre più a costo contenuto.
Conclusioni
«Fratello Gallione, tutti vogliono vivere felici, ma quando si tratta di veder chiaro cos’è che rende felice la vita sono avvolti dall’oscurità». Così si esprimeva Seneca (4 a.C.- 65 d.C.) nell’incipit del suo celebre dialogo De vita beata.
La dipendenza patologica è il desiderio che fa dell’assenza la spinta verso la ricerca della felicità.
È il desiderio che impone all’uomo il dolore. Il piacere che ne consegue è cessazione della pena, una sorta di non-dolore leggibile come piacere negativo. La sostanza (compreso il farmaco) mette inizialmente l’essere umano nella condizione di provare piacere e di desiderarne ancora, ma ciò che segue non è più piacere come nelle prime fasi dell’uso: ma il ricordo dello stesso e, con lo stabilirsi della dipendenza, il bisogno. A quel punto l’uso non è più piacere ma evitamento del dolore e più ancora della caduta nella sofferenza.
Sembra delinearsi la dialettica hegeliana del servo e del padrone, del pendio heideggeriano, del concetto lacaniano di manque, ossia della mancanza come propellente della ricerca, del desiderio.
Lo stesso Freud aveva sottolineato il fascino del piacere narcotico, ossia del doppio negativo: cessazione del dolore e sedativo al male di vivere.
Sia per Platone che per il padre della psicoanalisi, per interrompere questo circolo di esperienze cosiddette impure, di azioni anestetizzanti rispetto alla cura del mondo e degli altri, è necessario passare attraverso la realtà, sganciare il piacere dall’idea infantile dello stesso per entrare in una dimensione estetica, dal sensibile al bello, il pensiero e il ritorno al mondo.
Appetito insaziabile e piacere inaccessibile sono le dirette conseguenze di un meccanismo che non conosce fine né limiti.
Gli altri, le persone, la bellezza, l’impegno, il differimento, il sacrificio, la realtà sono questi i suggerimenti che filosofia, psicanalisi, e letteratura propongono come antidoto a quel vuoto incolmabile che può prendere tutti, ma soprattutto coloro che sono più esposti, portando con sé un bagaglio povero, una cassettina degli attrezzi (esperienze, percezioni, emozioni, interessi ecc.) scarna, un vuoto interiore che è assenza di senso e più ancora dell’ascolto del proprio autentico sé.
Chi accoglie e riconosce lacanianamente il proprio autentico e profondo desiderio (unico come ogni essere umano) può sperimentare degli insuccessi o delle privazioni, può doversi scontrare con frustrazioni, ma nel profondo è vivo, creativo, recettivo rispetto all’imprevedibilità della vita e alle sue possibilità.
Perché un soggetto si rende schiavo di un padrone folle (la sostanza) che lo distrugge? […] perché anziché sottrarci al male lo perseguiamo con accanimento? […] Si tratta di una sorta di intemperanza febbrile, di un’attivazione verso l’eccesso, di un rifiuto dell’equilibrio e della moderazione del piacere. L’essere umano non è un essere aristotelico, non si accontenta della via mediana, non è un ‘animale razionale’ ma come afferma Lacan, ‘un essere di godimento’, un essere che tende a oltrepassare il limite, a preferire il godimento alla difesa della propria vita. L’ideale del bene non è ciò che orienta la vita umana (Recalcati, 2012, pp. 97-8).
Dunque, il fine ultimo dell’azione umana è il perseguimento del piacere. Un piacere che non regala quasi mai soddisfazione. È possibile rintracciare questa constatazione anche nelle parole di Paolo di Tarso nella Lettera ai Romani (7,14-15): «La legge viene dallo Spirito, ma io sono nella carne, venduto al peccato […] non faccio quello che voglio ma quello che odio».
Di fatto, l’essere umano desidera il piacere, e non un piacere specifico. Sembra quasi di poter concludere, parafrasando Leopardi, che una certa povertà di stimoli, di strumenti, di occasioni, di capacità, aprano al piacere facilmente reperibile e di immediata fruizione delle sostanze psicotrope.
Eppure, anche nel momento di maggiore godimento, l’individuo continuerà a sentire l’assillo del desiderio non colmato. Questo assillo è di per sé fonte di dolore cosicché, anche quando non soffre di mali fisici, l’essere umano è in stato di sofferenza per la sua stessa richiesta inappagata. L’infelicità, dunque, non come momento occasionale, ma come condizione umana. La natura, dice Leopardi, ci ha creati così, la responsabilità dell’uomo non può che essere limitata.
Citando Goethe, Schopenhauer (1788-1860) nell’opera L’arte di essere felice intravede nella personalità la possibilità della felicità più alta. Assecondarla è ciò che l’uomo può mettere in pratica per garantirsela. Per fare questo è però necessario avere coscienza di sé, sapere con certezza ciò che si vuole ed evitare, in ragione delle esperienze fatte, di tentare ciò in cui non riusciamo, vuoi per inclinazione vuoi per limiti nostri. La conclusione è che «se abbiamo una volta per tutte conosciuto chiaramente le nostre forze e buone qualità, come pure i nostri difetti e debolezze […] sfuggiremo al più amaro di tutti i dolori, alla scontentezza di noi stessi, che è l’immancabile conseguenza di non conoscere la propria individualità» (Schopenhauer, 1997).
La fine del dolore è nel piacere o il piacere è esso stesso anelito del dolore per trovare possibilità di rinnovarsi in una eterna alternanza, in una sequenza senza soluzione di continuità.
Dolore e sofferenza. Il dolore fa parte del mondo fisico, la sofferenza di quello psichico. Due sfere diverse ma collegate tra loro e interagenti l’una sull’altra. Il dolore può venire localizzato in un punto, mentre la sofferenza tormenta tutto il nostro essere, ci logora, ci indebolisce, spesso ci degrada. […] Al dolore si perdona. Non così alla sofferenza. La sofferenza ci appare un’ingiustizia, una disgrazia, un torto immeritato: la nostra prima reazione alla sofferenza è di ribellione, di protesta. La sofferenza ci offende, anzi ci degrada (Kapuscinski, 2009).
Il piacere delle sostanze, spesso, dovrebbe essere letto alla luce di questa possibilità e più ancora come panacea a dolori cui non sempre si riesce a dare un nome. Le sostanze ben si prestano all’offerta di sollievo, che non è soluzione, se non temporanea e fittizia. In assenza di altre possibilità adattive, conosciute e praticate, restano il rifugio più facile e immediatamente praticabile. Nel tempo, però, anche la causa di nuovi e più pervicaci dolori, il tutto consumato tra ridondanti atti d’accusa nei confronti dell’uso di sostanze e continue sollecitazioni ad uno stile di vita totalmente orientato all’autoaffermazione, alla prestazione e all’ostentazione del benessere (finto o reale che sia) al dolore si oppone il piacere, alla sofferenza la possibilità di fuggire dalla memoria di sé.
L’imperativo dominante dei nostri giorni è quello riportato dalla voce del marchese De Sade: «Devi godere!». Secondo il pensiero di Georges Bataille in merito all’economia del dispendio, il corpo dell’uomo della contemporaneità è un corpo saturo, invaso dal godimento, accecato da un desiderio costante, incapace di piacere proprio perché schiavo del suo diktat e di una continua ripetizione compulsiva della sua ricerca senza la quale sembra trovare posto solo il dolore.
Se ancora oggi si prescinde da questo accostandosi al dipendente patologico allora la comprensione di ciò che agisce al suo interno è lontana dall’essere anche solo sondata.