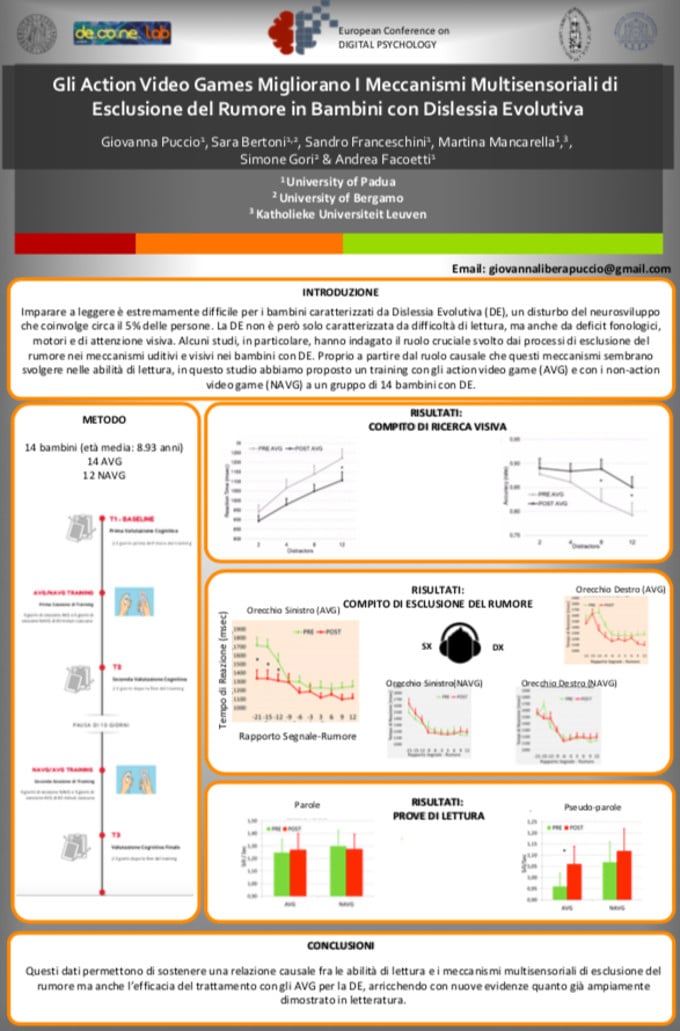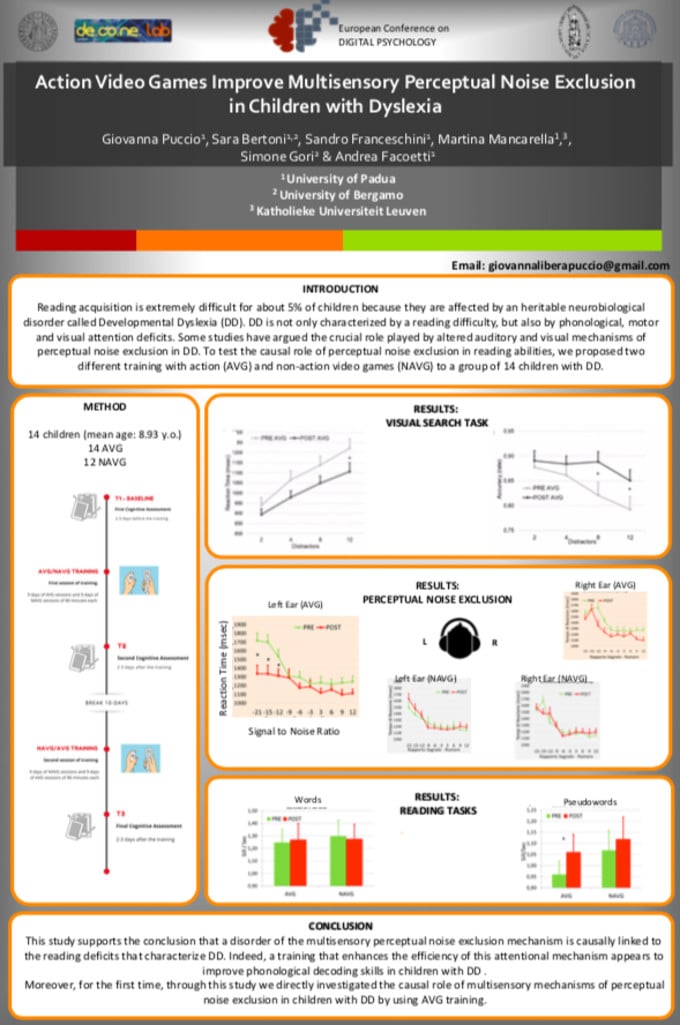I disturbi di linguaggio nella malattia di Alzheimer: correlati metabolici di errori semantici, fonemici e formali ad un compito di denominazione
Un recente studio (Isella et al., 2020) ha esplorato i correlati metabolici specifici degli errori semantici, fonemici e formali prodotti da pazienti con malattia di Alzheimer in un compito di denominazione di figure.
Maria Gazzotti – OPEN SCHOOL Psicoterapia Cognitiva e Ricerca, Milano
La malattia di
Alzheimer (Alzheimer’s disease, AD) è la forma più comune di
demenza, ha un esordio insidioso e graduale, che nella variante tipica riguarda principalmente l’ambito mnesico, e progredisce in modo inesorabile con un deterioramento che si estende coinvolgendo domini multipli delle abilità cognitive. L’ Alzheimer ha un’origine neurodegenerativa, con diffusa atrofia cerebrale dovuta a morte neuronale, riduzione dello spessore delle circonvoluzioni cerebrali, ampliamento di solchi e ventricoli e riduzione del peso cerebrale; si associano inoltre la formazione di grovigli neurofibrillari intraneuronali di proteina tau e di placche extracellulari di β-amiloide (Aβ) e un’insufficienza neuro-trasmettitoriale nel sistema dell’acetilcolina (Ropper & Brown, 2006; Bianchetti & Trabucchi, 2001; Brookmeyeret al., 2011).
Nonostante uno dei sintomi più tipici della malattia di Alzheimer siano i disturbi di memoria, fin dai primi stadi della malattia ha inizio un progressivo deterioramento del linguaggio che, secondo alcune evidenze, potrebbe essere utile per distinguere situazioni patologiche da mutamenti attribuibili all’età. Infatti, è stata dimostrata la presenza di sottili cambiamenti nelle abilità linguistiche in soggetti che in seguito svilupperanno malattia di Alzheimer già anni o decadi prima della comparsa della demenza vera e propria (Ahmed et al., 2013).
All’esordio i pazienti possono riferire sintomi come ‘perdita del filo del discorso’ o difficoltà nel recupero di parole, specialmente a bassa frequenza d’uso. Nel loro eloquio spontaneo si possono riscontrare un ridotto contenuto informativo ed un incremento nell’utilizzo di pronomi; i pazienti manifestano difficoltà nel recupero dei nomi sia nella comunicazione orale che nella scrittura, il loro vocabolario diviene limitato ed il linguaggio stereotipato. Mentre inizialmente la comprensione è preservata, con il progredire della malattia emergono difficoltà nella capacità di capire comandi complessi e peggiora anche il vocabolario, con sempre maggior presenza di anomie e parole passe-partout, fino ad arrivare ad una grave compromissione nella comunicazione (Luzzatti, 1996;Ropper& Brown, 2006).
Nei pazienti con malattia di Alzheimer la valutazione del linguaggio viene realizzata sia con specifici test cognitivi che attraverso l’esame dell’eloquio spontaneo.
In particolare, i compiti di denominazione rilevano deficit già nelle fasi iniziali di malattia. Silagie collaboratori (Silagiet al., 2015) hanno sottoposto soggetti con Alzheimer lieve o moderato e controlli sani ad un compito di denominazione di figure. Gli errori prodotti dai pazienti comprendevano principalmente parafasie semantiche ed anomie, il cui numero tendeva ad aumentare con il progredire della malattia, così come per le parafasie verbali; inoltre, nei pazienti in fase più avanzata, si riscontrava una maggiore varietà di errori commessi.
Diversi studi hanno indagato la correlazione tra le prestazioni in compiti di denominazione di figure e la distribuzione dell’atrofia alla MRI o l’ipometabolismo alla FDG-PET, mostrando il coinvolgimento della corteccia temporale ventrale anteriore sinistra, classicamente associata alla memoria semantica (Apostolovaet al., 2008; Melrose et al., 2009), ma hanno anche evidenziato il contributo di altre aree dell’emisfero sinistro che intervengono in fasi diverse del processo di denominazione: la superficie temporale dorsolaterale o mesiale, la giunzione occipito-temporale, il lobulo parietale inferiore e la corteccia frontale posteriore (Ahn et al., 2011; Zahn et al., 2004; Frings et al., 2011; Domoto-Reilly, 2012; Apostolova et al., 2008; Hirono et al., 2001; Teipel et al., 2006; Melrose et al., 2009).
Questi studi, tuttavia, hanno considerato solo il numero totale di risposte corrette. Lo studio di Isella e collaboratori (Isella et al., 2020) si è concentrato sui sottotipi di errore al compito di denominazione al fine di ottenere una topografia più fine dei livelli postsemantici e prearticolatori. Sono stati esplorati i correlati metabolici specifici degli errori prodotti da 63 pazienti con malattia di Alzheimer in uno stadio di malattia da lieve a moderato in un compito di denominazione di figure, con l’obiettivo di confermare, e possibilmente definire meglio, le mappe neurali dei deficit lessicali-fonologici nella generazione di parole. Le tipologie di errore prese in considerazione sono state:
- Errori semantici: parole reali con una relazione puramente concettuale con il target, che implicano un legame con il lessico e la consapevolezza dell’identità dello stimolo (es. cane per gatto).
- Errori fonemici: parole fonologicamente simili altarget, che implicano un accesso alla forma fonologica della parola ma non sono rappresentate all’interno del lessico (es. asparo per asparago).
- Errori formali: parole vere, la cui somiglianza puramente fonologica con la parola target denota consapevolezza della sua forma fonologica (es. cavolo per tavolo).
I modelli di produzione di parole ipotizzano un processo di rappresentazione ed elaborazione a più livelli e sottolivelli: l’attivazione del concetto nel sistema semantico è seguita del recupero della corrispondente voce lessicale e della forma fonologica della parola e dall’attivazione del programma articolatorio associato. Le fasi lessicali e fonologiche di questo processo sono state ulteriormente suddivise in un livello lessicale-semantico, uno lessicale-fonologico e uno postlessicale-fonologico, il cui contenuto è presumibilmente correlato, rispettivamente, al significato, alla struttura lessicale-fonologica e alle caratteristiche articolatorie fonologiche della parola (Schwartz et al., 2006; Dell et al., 2013; Indefrey, 2011; Indefrey e Levelt, 2004; Hickok, 2014; Rapp e Goldrick, 2006).
Il substrato neuroanatomico di questi processi e degli errori nel recupero delle parole non è ancora completamente definito.
Lo studio di Isella e collaboratori (Isella et al., 2020) ha esaminato gli errori commessi dai pazienti in un compito denominazione di figure, che è stato effettuato come parte di una batteria neuropsicologica che tocca i principali domini cognitivi (attenzione, memoria verbale a breve e lungo termine, capacità visuospaziali ed esecutive, fluidità verbale e comprensione del linguaggio, umore e comportamento), utilizzando un test standardizzato (Laiacona et al., 1993) composto da 80 stimoli appartenenti a 8 categorie: animali, frutta, verdura, parti del corpo, mobili, attrezzi, veicoli e strumenti musicali. Gli errori fonemici, semantici e formali sono stati classificati in base al consenso tra due valutatori.
Il punteggio medio nel test di denominazione di figure indicava solo un lieve deterioramento della denominazione, ma c’era una grande variabilità interindividuale. Gli errori più numerosi sono stati gli errori semantici, seguiti da quelli fonemici e per ultimiquelli formali.
La correlazione tra il metabolismo cerebrale FDG-PET e le prestazioni al compito di denominazione ha identificato vari loci di anomalie metaboliche nell’emisfero sinistro. La performance globale, cioè il numero di risposte corrette, correlava con la disfunzione della corteccia temporale ventrale, in accordo con le prove precedenti, che supportano un ruolo cruciale del giro fusiforme sinistro nel recupero semantico-lessicale (Grossman et al.,2004; Hirono et al., 2001; Teipel et al., 2005).
Per i tre tipi di errori considerati nello studio (semantici, fonemici e formali) è emerso uno specifico correlato metabolico: gli errori semantici sono risultati associati a ipometabolismo nel giro temporale medio posteriore sinistro e nel giro temporale inferiore posteriore, quelli fonemici a ipometabolismo nel giro sopramarginale sinistro e quelli formali a ipometabolismo nel segmento medio anteriore del giro temporale medio sinistro.
Nonostante gli errori fonemici e formali siano stati prodotti in piccole quantità, cosa che potrebbe aver influenzato l’affidabilità e la generalizzabilità delle correlazioni rilevate, SPM ha prodotto cluster chiari per tutte e tre le tipologie di errori.
In conclusione, i risultati dello studio delineano una mappa neuroanatomica degli errori prodotti da pazienti con malattia di Alzheimer nella denominazione di figure che associa errori semantici a neurodegenerazione in due aree della corteccia temporale posteriore sinistra che si suppone sottostiano a rappresentazioni visive e semantiche più generali, errori formali ad ipometabolismo nel giro temporale medio anteriore sinistro, che potrebbe quindi rappresentare il locus di processi lessicali fonologici, ed errori fonemici a degenerazione nel giro sopramarginale sinistro, sottostante alla memoria a breve termine verbale o a rappresentazioni pre-articolatorie.