All’origine dell’ Omofobia: Contesto Culturale e Attrazione Repressa.
– Rassegna Stampa –
 La teoria che dietro all’omofobia possa celarsi una particolare attrazione, seppur repressa, proprio per persone dello stesso sesso è supportata da uno studio pubblicato su Journal of Personality and Social Psychology.
La teoria che dietro all’omofobia possa celarsi una particolare attrazione, seppur repressa, proprio per persone dello stesso sesso è supportata da uno studio pubblicato su Journal of Personality and Social Psychology.
Secondo i ricercatori gli individui omofobici vivrebbero un forte conflitto interno tra la propria attrazione verso persone dello stesso sesso e l’imperativo a reprimerla a causa di un educazione familiare repressiva e autoritaria in questo senso; nel momento in cui queste angosciose preferenze e tendenze vengono riconosciute nel confronto con gay e lesbiche tale conflitto verrebbe esternalizzato, prendendo la forma di paura intensa e viscerale degli omosessuali, atteggiamenti omofobi e discriminatori, ostilità verso i gay e anche nell’adozione di idee politiche anti-gay.

Lo studio comprende quattro esperimenti separati, condotti negli Stati Uniti e in Germania, e ogni studio coinvolge una media di 160 studenti universitari. Sono state messe a confronto misure implicite ed esplicite di orientamento sessuale e omofobia e il tipo di atteggiamento genitoriale lungo un continuum da democratico ad autoritario.
I risultati forniscono nuove prove empiriche a sostegno della teoria psicoanalitica che la paura, l’ansia e l’avversione che alcune persone, apparentemente eterosessuali, hanno verso i gay e le lesbiche possano svilupparsi proprio dai loro desideri repressi; i risultati supportano anche la più moderna teoria dell’auto-determinazione, sviluppata da Ryan e Edward Deci alla University of Rochester, che collega lo stile genitoriale controllante alla scarsa accettazione di sé e alla difficoltà di valutare se stessi in modo incondizionato.
BIBLIOGRAFIA:
- Weinstein N. William R,S. DeHaan C,R. Przybylski A,K. Legate N. Ryan R, M. Parental autonomy support and discrepancies between implicit and explicit sexual identities: Dynamics of self-acceptance and defense. Journal of Personality and Social Psychology, Vol 102(4), Apr 2012, 815-832
- Ryan R, M. Deci E,L. (2000). Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being. American Psychologist



 Ci sono alcuni volti che sono di casa. Ci sono alcune persone che a forza di entrare e uscire e poi rientrare giorno dopo giorno in ambulatorio diventano così familiari che certe volte ti sembrano più vicini dei tuoi vicini, più intimi dei cugini, quasi qualcuno di famiglia e devi fare attenzione a non lasciarti troppo andare.
Ci sono alcuni volti che sono di casa. Ci sono alcune persone che a forza di entrare e uscire e poi rientrare giorno dopo giorno in ambulatorio diventano così familiari che certe volte ti sembrano più vicini dei tuoi vicini, più intimi dei cugini, quasi qualcuno di famiglia e devi fare attenzione a non lasciarti troppo andare.
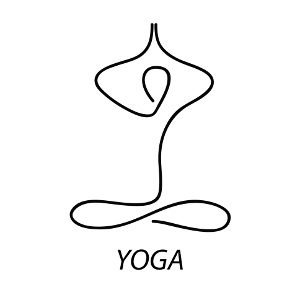 Ad oggi sono numerosi gli studi che integrano approcci corporei ad approcci più prettamente verbali, tradizione occidentale e tradizione orientale, vedendo il processo di cura come un processo sinergico. Un gruppo di ricercatori della Boston University School of Medicine, del New York Medical College, e del Columbia College of Physicians and Surgeons, ha condotto una review sui benefici fisici e psicologici del praticare Yoga. I risultati di questo interessante studio sono stati pubblicati sulla versione online del Medical Hypotheses.
Ad oggi sono numerosi gli studi che integrano approcci corporei ad approcci più prettamente verbali, tradizione occidentale e tradizione orientale, vedendo il processo di cura come un processo sinergico. Un gruppo di ricercatori della Boston University School of Medicine, del New York Medical College, e del Columbia College of Physicians and Surgeons, ha condotto una review sui benefici fisici e psicologici del praticare Yoga. I risultati di questo interessante studio sono stati pubblicati sulla versione online del Medical Hypotheses.
 Se fino ad oggi avete speso minuti preziosi davanti allo specchio interrogandovi sulle possibili reazioni al vostro abbigliamento, dopo aver letto questo post il tempo abitualmente dedicato a ciò non sarà più sufficiente poichè, parola di autorevoli ricercatori, il tipo di vestito indossato non solo influenza l’altrui pensiero ma anche il vostro.
Se fino ad oggi avete speso minuti preziosi davanti allo specchio interrogandovi sulle possibili reazioni al vostro abbigliamento, dopo aver letto questo post il tempo abitualmente dedicato a ciò non sarà più sufficiente poichè, parola di autorevoli ricercatori, il tipo di vestito indossato non solo influenza l’altrui pensiero ma anche il vostro.
 Parlare di impotenza (
Parlare di impotenza (


 Recensione di: UNA STANZA PIENA DI GENTE by Daniel Keyes
Recensione di: UNA STANZA PIENA DI GENTE by Daniel Keyes



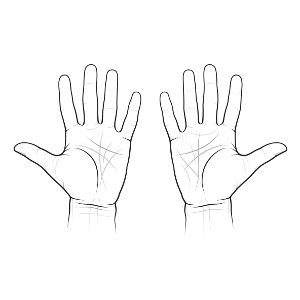

 Il suicidio di un paziente è sicuramente l’evento più drammatico nella vita professionale di uno psichiatra o di uno psicoterapeuta, e non è così raro se si considera che in tutte le nazioni il suicidio è attualmente tra le prime tre cause di morte nella fascia di etá 15-34 anni (WHO, 2004). Il fenomeno del suicidio è un problema complesso non ascrivibile ad una causa o ad un motivo preciso. Sembra piuttosto derivare da una complessa interazione di fattori biologici, genetici, psicologici, sociali, culturali ed ambientali.
Il suicidio di un paziente è sicuramente l’evento più drammatico nella vita professionale di uno psichiatra o di uno psicoterapeuta, e non è così raro se si considera che in tutte le nazioni il suicidio è attualmente tra le prime tre cause di morte nella fascia di etá 15-34 anni (WHO, 2004). Il fenomeno del suicidio è un problema complesso non ascrivibile ad una causa o ad un motivo preciso. Sembra piuttosto derivare da una complessa interazione di fattori biologici, genetici, psicologici, sociali, culturali ed ambientali.



 Con il disputing empirico il terapeuta chiama il paziente a riflettere su come egli immagina concretamente che avvengano gli eventi negativi, e su quali prove concrete e tratte dalla sua esperienza quotidiana si basano questi pensieri catastrofici.
Con il disputing empirico il terapeuta chiama il paziente a riflettere su come egli immagina concretamente che avvengano gli eventi negativi, e su quali prove concrete e tratte dalla sua esperienza quotidiana si basano questi pensieri catastrofici.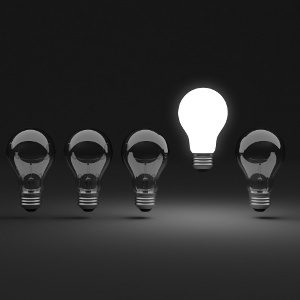

 C’era una volta un bambino nato in mondo strano, fatto di luci abbaglianti, suoni assordanti e odori nauseanti. Non capiva come mai quella che poi avrebbe imparato a chiamare “mamma” lo costringesse a indossare abiti che pungevano tanto da farlo impazzire e perché ci tenesse a riempirlo di baci che gli lasciavano le guance così appiccicose da non dormirci la notte. Col passare degli anni questi ed altri fastidi andarono diminuendo e così l’interesse verso l’ambiente circostante lo spinse a cercare di comunicare le proprie esigenze agli alieni che gli stavano attorno. Più cercava di esprimersi, però, più riceveva ulteriori punizioni. Un giorno, per esempio, decise di uscire di casa con mamma senza protestare perché con lui era cresciuta anche la curiosità di vedere cosa ci fosse là fuori. Purtroppo si ritrovò ingabbiato in una specie di sedia a quattro ruote che si muoveva producendo un insopportabile rumore metallico. Le vibrazioni delle ruote gli creavano un fastidioso prurito lungo tutta la colonna vertebrale e le luci al neon lo rendevano incapace di vedere altro. Poteva però sentire le mani, che immaginava essere della madre, accarezzargli i capelli ed aveva la sensazione che ad ogni gesto gli venissero strappate intere ciocche.
C’era una volta un bambino nato in mondo strano, fatto di luci abbaglianti, suoni assordanti e odori nauseanti. Non capiva come mai quella che poi avrebbe imparato a chiamare “mamma” lo costringesse a indossare abiti che pungevano tanto da farlo impazzire e perché ci tenesse a riempirlo di baci che gli lasciavano le guance così appiccicose da non dormirci la notte. Col passare degli anni questi ed altri fastidi andarono diminuendo e così l’interesse verso l’ambiente circostante lo spinse a cercare di comunicare le proprie esigenze agli alieni che gli stavano attorno. Più cercava di esprimersi, però, più riceveva ulteriori punizioni. Un giorno, per esempio, decise di uscire di casa con mamma senza protestare perché con lui era cresciuta anche la curiosità di vedere cosa ci fosse là fuori. Purtroppo si ritrovò ingabbiato in una specie di sedia a quattro ruote che si muoveva producendo un insopportabile rumore metallico. Le vibrazioni delle ruote gli creavano un fastidioso prurito lungo tutta la colonna vertebrale e le luci al neon lo rendevano incapace di vedere altro. Poteva però sentire le mani, che immaginava essere della madre, accarezzargli i capelli ed aveva la sensazione che ad ogni gesto gli venissero strappate intere ciocche.
 Mappato il gene che regola il centro esecutivo del cervello durante l’arco di vita – Febbraio 2012
Mappato il gene che regola il centro esecutivo del cervello durante l’arco di vita – Febbraio 2012