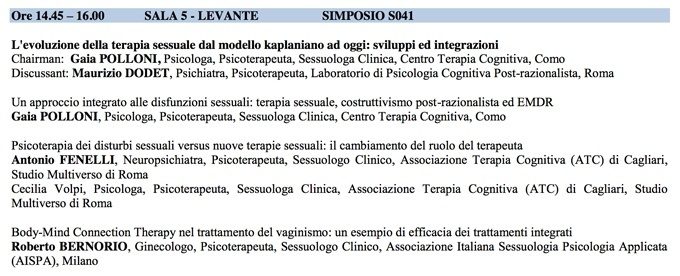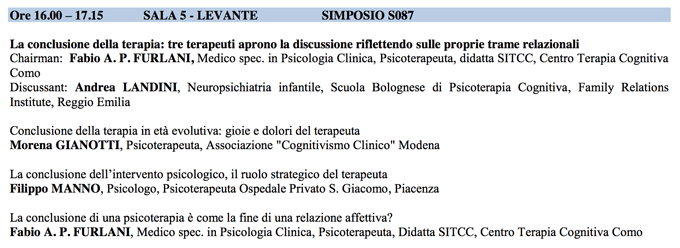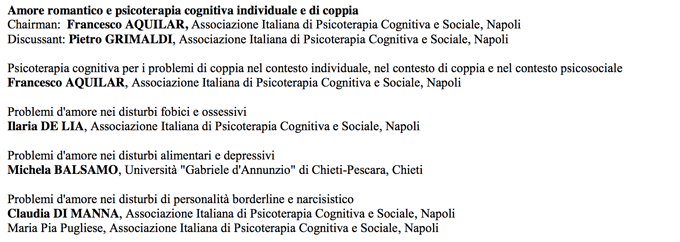Sindrome del sopravvissuto: la trappola della (non) responsabilità
Eventi di intensa tragicità – ci insegna la storia – tendono ad accompagnarsi alla nascita di una particolare tipologia di senso di colpa, definita appunto “del sopravvissuto”.
“Ha avuto la sensazione del sopravvissuto, il senso di colpa di chi resta?”
“Senso di colpa no, ma la sensazione molto comune di stare vivendo dei sentimenti e delle emozioni mai provati prima. E di sentirti impotente”.
Sono queste le parole che l’attore John Turturro usa per rispondere a un giornalista de “L’Espresso”, interessato allo stato d’animo, nonché psicologico, dell’attore dopo l’11 Settembre 2001. Turturro ha perso in quell’occasione quattro amici, è intervenuto in prima persona per prestare soccorso e, presumibilmente, ha manifestato una commistione di sintomi che potrebbero essere classificati come “post traumatici da stress”, primo fra tutti il senso di impotenza menzionato dall’attore stesso durante l’intervista.
Ma la domanda del giornalista si riferisce a ben altro, e viene fatta con cognizione di causa: “Ha avuto la sensazione del sopravvissuto?”.
Eventi di tale tragicità – ci insegna la storia – tendono difatti ad accompagnarsi alla nascita di una particolare tipologia di senso di colpa, definita appunto “del sopravvissuto”: esempio eclatante e noto a chiunque è quello dello scrittore ebreo Primo Levi, sopravvissuto ai campi di concentramento nazisti, ma morto suicida perché vittima di un intollerabile (e apparentemente ingiustificato) senso di colpa nei confronti di chi non è mai tornato a casa.
Il senso di colpa può essere descritto come “il dispiacere provato per aver compromesso il perseguimento di uno scopo a un soggetto X, per essere stati causa di un suo disagio o malessere” (Castelfranchi, D’Amico, Poggi, 1994). Ciò che caratterizza questa emozione, è il fatto che il soggetto si riconosce colpevole per il danno, ingiusto, causato all’altro; ma non solo: è sufficiente che il soggetto si ritenga colpevole di aver avuto l’intenzione o il desiderio di causare danno, portando il tutto a un piano ancor più astratto e scorporato dalla realtà (Mancini, 1997).
Questo aspetto di “scissione” tra realtà e intenzione concerne la fondamentale differenza tra il cosiddetto “senso di colpa da colpa” (Poggi, Bartolucci e Violini, 2000) e il “senso di colpa del sopravvissuto”.
“Per provare il senso di colpa del sopravvissuto non sono necessari alcuni ingredienti, tipici invece del senso di colpa da colpa: innanzitutto non serve che C (il Colpevole) assuma l’esistenza di un nesso di causa fra il proprio comportamento e il danno della vittima; non è neanche necessario che C assuma che avrebbe potuto fare diversamente e nemmeno di aver infranto una delle norme da lui stesso condivise. Per giunta C può essere onestamente consapevole di non aver desiderato il danno di V (la Vittima), addirittura può essergli chiarissimo l’avere una disposizione fortemente positiva verso V” (Mancini, 1997).
Nello specifico, la “colpa del sopravvissuto” risulta per il soggetto paralizzante per due motivi:
- Per il fatto di vivere una situazione di privilegio a spese di altri o nel confronto con altri che appaiono maggiormente danneggiati (Kubany e Manke, 1995);
- Per le azioni o inazioni che hanno aumentato il senso di minaccia alla propria sopravvivenza, ossia la percezione di non aver fatto abbastanza per prevenire la catastrofe e le sue conseguenze (Parson, 1986).
Dunque, che cosa genera questo forte senso di responsabilità? Perché un sopravvissuto all’olocausto, all’attacco alle Torri Gemelle, a un incidente o a un episodio drammatico che ha causato la morte di altre persone, può sviluppare un senso di colpa così forte da portare addirittura al suicidio?
“L’operazione cognitiva necessaria per provare senso di colpa del sopravvissuto è un semplice confronto tra le fortune del colpevole e quelle della vittima che, per generare senso di colpa, deve dare un risultato sfavorevole alla vittima. Il soggetto pone su un piatto della bilancia le proprie fortune ed i propri meriti e sull’altro quelli della vittima. Se la bilancia pende a favore del primo allora vi è senso di colpa” (Poggi, 1994). Insomma, quello che viene fortemente minacciato nel caso del senso di colpa del sopravvissuto è il senso di equità e di uguaglianza che si presume debba vigere tra gli esseri umani, e che impedisce di dare risposta alla domanda “Perché lui sì, e io no?”.
Riportiamo un caso clinico che meglio può spiegare questa attitudine (Bottelli, 2012): Francesca è una donna di circa 40 anni, che si avvicina al percorso terapeutico su suggerimento del medico di base, dopo aver sviluppato sintomatologia da attacco di panico, unitamente a un forte senso di vuoto e colpa dopo la morte (improvvisa e ravvicinata) di entrambi i genitori e della sorella minore (i primi, per tumore e a seguito di infarto, la seconda per un cancro al seno). Da notare, emerso nella raccolta anamnestica, un aneurisma avuto dalla paziente in giovane età, dal quale si è ripresa completamente nonostante la prognosi negativa.
“La paziente si vive come una sopravvissuta rispettoa i suoi familiari, risparmiata sia dal cancro, che dall’aneurisma. Ritiene di aver avuto la fortuna di ristabilirsi, al contrario della sorella e dei genitori. La paziente, durante questi anni, si è sentita molto responsabile dello stato di salute dei familiari e della loro gestione, come se l’esito delle cure dipendesse dai suoi sforzi. Di qui, il senso di fallimento e colpa nel non aver salvato la sorella e la madre e, quindi, di essere ingiustamente sopravvissuta”.
Nel caso specifico del senso di colpa legato a un evento traumatico, quale può essere, appunto, il caso della “colpa del sopravvissuto”, la terapia cognitiva comportamentale si rivela efficace, in quanto la colpa è originata essenzialmente dal modo in cui una persona valuta ed interpreta gli eventi.
La terapia cognitivo comportamentale per la colpa legata a un trauma comprende: (a) l’assessment; (b) esercizi di esposizione immaginativa; (c) correzione degli errori di ragionamento che conducono a conclusioni erronee associate alla colpa (rivalutazione della percezione di giustificazione, responsabilità e azioni commesse).
Nello specifico, poi, il terapeuta dovrebbe aiutare il paziente a distinguere tra cosa era in passato e cosa è ora, a diventare maggiormente consapevole dei pensieri e delle credenze sottostanti i sensi di colpa, ad esempio attraverso il self-monitoring. Egli, inoltre, conduce il paziente a formulare interpretazioni più realistiche della situazione: ad esempio aiutandolo a comprendere che l’evento traumatico era completamente al di fuori del suo controllo, e che egli ha fatto del suo meglio in quella situazione. Riducendo la colpa, quindi, si può anche lavorare con il paziente con l’obiettivo di favorire un incremento della self-compassion e dell’accettazione (Gilbert e Procter 2006). La self-compassion consiste in un’attitudine emotivamente positiva e funzionale che dovrebbe proteggere l’individuo dalle conseguenze negative del giudizio verso se stessi, dall’isolamento e dalla ruminazione. Il paziente può imparare ad essere, pertanto, più compassionevole e non giudicante nei confronti di se stesso, a percepire la propria esperienza come parte dell’esperienza umana più ampia, piuttosto che percepirsi come isolato e separato dal resto, e, infine, a sviluppare un atteggiamento mindfulness, ovvero una maggiore abilità nel controllare i propri pensieri e sentimenti, piuttosto che identificarsi eccessivamente con essi.
ARTICOLO CONSIGLIATO:
Trauma psicologico: la terapia migliore è quella somatica
BIBLIOGRAFIA:
- Bellelli, G., Gasparre, A. (2009), Emozioni morali e processi cognitivi: vergogna e colpa nelle esperienze quotidiane e traumatiche. Cognitivismo clinico, 6, 2, 141-160. DOWNLOAD
- Bottelli, V. (2012), Il caso di Francesca: Disturbo di Panico e SdC del sopravissuto. Psicoterapeuti in-formazione, N. 9, pp. 75-87. DOWNLOAD
- Gilbert, P., Procter, S. (2006), Compassionate mind training for people with high shame and self-criticism: Overview and pilot study of a group therapy approach. Clinical Psychology and Psychotherapy, 13, 353-379.
- Kubany , E.S., Manke, F.P. (1995), Cognitive therapy for trauma-related guilt: Conceptual basis and treatment outlines. Cognitive and Behavioral Practice, 2, 23-61.
- L’Espresso, Dossier sull’11 Settembre, Intervista a John Torturro (“Il mio amico pompiere”).
- Mancini, F. (1997), Il senso di colpa: un’analisi cognitiva. Psicoterapia, 9,12 – 27. DOWNLOAD
- Poggi, I., Bartolucci, L., Violini, S., (2000), Emozioni, un’arma per l’apprendimento. Articolo pubblicato per il Dipartimento di Scienze dell’Educazione – Università Roma Tre. DOWNLOAD