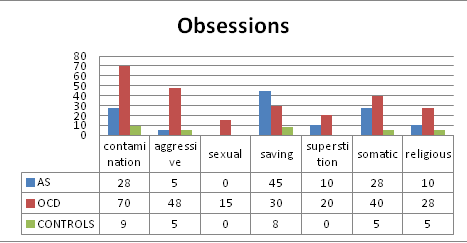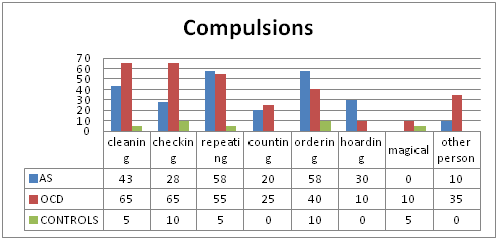Crea consapevolmente! Il legame tra la pratica di Mindfulness e la creatività
Sempre più spesso la creatività è un requisito per trovare lavoro, o per migliorare il proprio; e se ci fosse un modo per aumentare le nostre capacità creative? Alcuni ricercatori hanno ipotizzato che questo modo potesse essere la pratica di Mindfulness.
Marta Venturini – OPEN SCHOOL Studi Cognitivi Bolzano
Sempre più spesso essere creativi è un requisito per trovare lavoro, o per migliorare il proprio. Il saper trovare facilmente soluzioni creative a problemi di tutti i giorni in ufficio, a casa, a scuola può dare la cosiddetta “marcia in più”, e se ci fosse un modo per aumentare le nostre capacità creative, probabilmente un certo numero di persone desidererebbe quantomeno tentare. Alcuni ricercatori hanno ipotizzato che questo modo potesse essere la pratica di Mindfulness. Tuttavia, i punti di contatto tra pratica di mindfulness e creatività sono oggetto di studio molto recente. Allo stesso modo, anche l’influenza che la pratica di Mindfulness può esercitare sul pensiero creativo non è ancora del tutto chiara. Con il presente articolo vorrei offrire una breve rassegna di studi che hanno come argomento il collegamento tra pratica di Mindfulness e creatività.
Pratica di Mindfulness e creatività: quale punto di connessione?
Prima di iniziare, è bene introdurre alcuni concetti. La Mindfulness è ormai un argomento molto conosciuto e discusso all’interno della comunità scientifica, soprattutto da parte di esperti in psicologia e psicoterapia cognitivo-comportamentale, grazie al lavoro di Jon Kabat-Zinn, che nel 1979 concepì un tipo di intervento chiamato “Mindfulness Based Stress Reduction” (MBSR) e successivamente la “Mindfulness Based Cognitive Therapy for Depressive Relapse Prevention” (MBCT) (Zindel, Segal, Williams, & Teasdale, 2014).
Per quanto riguarda la
creatività, sembra non esserci, al momento, una definizione condivisa tra gli esperti nel settore. Horan (2009) propose la propria, come “
l’intenzione di trascendere barriere informative”. Secondo Torrance (1988), la creatività sarebbe invece l’attitudine a pensare fuori dagli schemi, a trovare soluzioni a problemi di varia natura senza utilizzare conoscenze pregresse (Torrance, 1988; in Sternberg, 2006). Infine, nell’enciclopedia
Treccani (versione online), la definizione di
creatività dal punto di vista psicologico verte sui concetti di pensiero divergente e di risoluzione di problemi attraverso l’insight. In ogni definizione vi è una componente intenzionale, originale, e chiaramente qualcosa che implichi produzione di nuovo materiale.
Il materiale creativo può essere reale, fisico, come un’opera d’arte, un racconto scritto, ma può essere anche un’idea, come nei casi di problem solving creativo e di insight. Tali processi di pensiero sono caratterizzati dal trovare soluzioni fuori dagli schemi, il primo, e trovare soluzioni per le quali apparentemente non si può dare una spiegazione razionale, il secondo (Ostafin & Kassman, 2012).
A partire da queste definizioni è possibile trovare un punto di connessione con la Mindfulness: la “mente del principiante”, alla quale Jon Kabat-Zinn sprona a tornare e che chi fa pratica di Mindfulness tenta di coltivare, è di natura simile a quella creativa, che trova soluzioni senza necessariamente utilizzare conoscenze già acquisite, quindi uscendo dagli schemi appresi attraverso l’esperienza: questo aspetto della creatività è definito dagli esperti “pensiero divergente” (Colzato, Ozturk, & Hommel, 2012).
Pratica di Mindfulness e creatività: gli insight problems
Uno studio grazie al quale è stato messo in luce il legame tra pratica di Mindfulness e creatività è quello realizzato da Ostafin & Kassman (2012). Gli autori introducono la loro ipotesi ricordando che uno degli obiettivi principali di chi fa pratica di Mindfulness è quello di diminuire il potere dell’influenza dei pensieri abituali sul proprio modo di agire. Dato che essere creativi significa soprattutto pensare fuori dai propri schemi abituali, si può ipotizzare che la pratica di Mindfulness possa facilitare la risoluzione di problemi poco ordinari, per i quali è richiesto pensiero creativo.
Ciò che è ritenuto come problema che richiede soluzioni creative è quel tipo di problemi chiamati “insight problems”, ovvero, come dicono gli autori, quei problemi che si risolvono con un “Aha!”. Questo tipo di soluzione creativa non è logica come nei problemi “non-insight”, quindi non viene raggiunta a piccoli passi attraverso la suddivisione del problema in sotto-problemi. Al contrario, chi risolve insight problems non è del tutto consapevole di come abbia trovato la soluzione.
Per il primo studio, gli autori utilizzarono la “Mindful Attention Awareness Scale” (MAAS; Brown & Ryan, 2003) per valutare la “consapevolezza mindfulness di tratto”, e tre problemi precedentemente utilizzati in letteratura per valutare la modalità di risoluzione insight. Inoltre, due ulteriori problemi vennero inclusi per valutare la capacità di risoluzione non-insight (per maggiori dettagli, vedere Ostafin & Kassman, 2012). Questa fase vide coinvolto un campione di studenti universitari, non meditatori e che non avevano partecipato a training di Mindfulness.
Sorprendentemente, i risultati confermano l’ipotesi che persone con una più alta consapevolezza di tratto fossero anche più creative nella risoluzione di problemi insight, ma non di quelli non-insight.
Nel secondo studio presentato nel manoscritto, Ostafin & Kassman (2102) decisero di introdurre una breve pratica di Mindfulness per il gruppo sperimentale, di valutare la “consapevolezza mindfulness” sia “di tratto” che “di stato”, ma anche di controllare una variabile che potenzialmente si inserisce nel rapporto tra Mindfulness e creatività. Tale variabile è l’associazione tra pratica e sentimenti positivi. Valutarono quindi i sentimenti positivi attraverso il “Self-assessment manikin” (SAM, Bradley & Lang, 1994; in Ostafin & Kassman, 2012). I partecipanti eseguirono inoltre gli stessi problemi presentati precedentemente.
I risultati replicarono il primo studio, aggiungendo un ulteriore miglioramento per il gruppo sperimentale che aveva fatto esperienza di una breve pratica di meditazione. La “consapevolezza mindfulness di tratto” risultò positivamente correlata alla capacità di risolvere problemi insight, indipendentemente dalla presenza di sentimenti positivi. Per quanto riguarda invece i problemi non-insight, la loro risoluzione non fu influenzata dalle misure di consapevolezza.
Diversi tipi di meditazione portano allo sviluppo di differenti aspetti del pensiero creativo?
Nello stesso anno, Colzato, Ozturk e Hommel (2012) studiarono la relazione tra la capacità creativa dei partecipanti, la meditazione basata sull’Attenzione Focalizzata, e quella basata sul Monitoraggio Aperto (Mindfulness).
Ipotizzarono che le due modalità meditative potessero mediare diversamente due aspetti del pensiero creativo: il pensiero divergente e quello convergente. Il pensiero divergente, già brevemente descritto, è il processo mentale più spontaneo per arrivare a soluzioni creative; il pensiero convergente, invece, si può avere quando viene risolto un problema grazie ad un ragionamento molto logico e focalizzato. Ad esempio, quando nei quiz televisivi viene presentata una lista di parole (“Orario”, “Agenda”, “Lavoro”) ed il partecipante deve trovarne una quarta che colleghi semanticamente le altre (“Appuntamento”).
Colzato et al. (2012) studiarono un gruppo di 19 persone, praticanti Meditazione con Attenzione Focalizzata o con Monitoraggio Aperto (Mindfulness). Il disegno sperimentale prevedeva che tutti i partecipanti prendessero parte a tre sessioni in tre settimane, ognuna delle quali poteva essere, in ordine casuale, di meditazione focalizzata, meditazione aperta o un esercizio di immaginazione (utilizzata come seduta di controllo o baseline).
In seguito, ai partecipanti veniva chiesto di completare due compiti: “Remote association task” ed “Alternate uses task”, che hanno come oggetto di studio, rispettivamente, il pensiero convergente ed il pensiero divergente. Il RAT è un test che si basa sulla capacità accennata precedentemente, ovvero di individuare un termine che collega concettualmente altri termini (ad esempio “granita”, “pattini” ed “acqua” sono collegati da “ghiaccio”). Il AUT invece prevede che al partecipante vengano mostrati diversi oggetti di uso quotidiano: lo scopo è trovare quanti più utilizzi possibili per uno stesso oggetto. In seguito alle 3 sessioni veniva misurata la percezione dell’umore (migliorato o non migliorato). Il RAT veniva analizzato in termini di risposte corrette, mentre per quanto riguarda l’AUT, venivano analizzati diversi aspetti delle risposte fornite dai partecipanti: Originalità, Fluenza, Flessibilità ed Elaborazione. La previsione degli autori era che la capacità di pensiero creativo convergente e divergente aumentassero, rispettivamente, in seguito a
Meditazione con Attenzione Focalizzata e con Monitoraggio Aperto (
Mindfulness).
Mentre per quanto riguarda il AUT, tre misure su quattro furono influenzate positivamente a seguito della Meditazione con Monitoraggio Aperto (Mindfulness), questo non si verificò per la Meditazione con Attenzione Focalizzata, che non cambiò significativamente la prova di RAT. Tuttavia, entrambi i tipi di meditazione influenzarono positivamente l’umore. Gli autori proposero che questa variabile potesse aver interferito con il pensiero convergente, in quanto è stato riportato in letteratura che l’umore positivo scaturito dalla meditazione (di qualsiasi tipo) agirebbe positivamente sul pensiero divergente ma non su quello convergente, che ne verrebbe alcune volte addirittura ostacolato.
Quello che si può dedurre dopo aver letto i due studi qui riportati (Ostafin & Kassman, 2012; Colzato et al., 2012) è che l’aspetto divergente del pensiero creativo sia effettivamente stimolato da modalità di meditazione di tipo aperto, non giudicante, come la Mindfulness. Quanto all’influenza che può avere il tono dell’umore in questa relazione, non c’è ancora consenso, ma dati neuropsicologici dimostrano che l’umore migliori progressivamente con la pratica di Mindfulness (Horan, 2009).
Neuropsicologia della meditazione e della creatività
Nel 2009 Horan pubblicò un interessante articolo riguardo ai parallelismi tra meditazione e creatività, dal punto di vista neuropsicologico. Questo articolo, oltre a fornire una spiegazione esaustiva delle componenti neurofisiologiche associate alla meditazione ed alla creatività, ci offre una base scientifica sul potenziale collegamento fra le due.
L’articolo in questione è relativo alle basi neuropsicologiche di diversi tipi di meditazione, tra i quali è inclusa la Mindfulness. Come scrive l’autore, chi fa pratica di Mindfulness assume un atteggiamento distaccato e non giudicante sui pensieri e sulle sensazioni che prova.
L’ipotesi sulla quale Horan basa la propria ricerca è che trascendenza ed integrazione siano meccanismi neuropsicologici che accomunano meditazione e creatività. Nella definizione kantiana, trascendentale sarebbe la conoscenza di qualcosa della quale non abbiamo mai avuto esperienza. Horan ritiene che lo slegarsi dalle limitazioni informative, e quindi trascendere idee e percezione, stia alla base della creatività (Horan, 2007). Le barriere informative verrebbero successivamente trasformate grazie all’integrazione di nuova conoscenza con quella che già esiste, all’interno di un contesto informativo noto.
Horan (2009) ci offre una rassegna di studi, pubblicati in letteratura, che si basano prevalentemente sull’uso dell’elettroencefalografia (EEG) come tecnica di registrazione di segnali neurofisiologici. Questi registrano e localizzano l’attività neurale associata al processo creativo o a diversi tipi di meditazione. La sua ipotesi è che sia nella creatività sia nella meditazione sia implicato un certo grado di intenzionalità a trascendere le barriere dell’informazione che noi abbiamo già, ed integrare queste esperienze di trascendenza con la realtà che viviamo. Attraverso la sua rassegna di letteratura l’autore vuole validare l’ipotesi secondo la quale la creatività sarebbe supportata dalla pratica di meditazione, in quanto entrambe sarebbero attività attentive.
Horan (2009) prende in considerazione diversi tipi di meditazione: Meditazione Mindfulness (sia Zen che Vipassana), Meditazione di Concentrazione e Meditazione Trascendentale (o Combinata). L’autore elenca una serie di cambiamenti nell’attività neurale dei meditatori, esperti e non esperti. Tra questi, è stata registrata una sincronizzazione delle onde alfa su gran parte della corteccia, che potrebbe essere la base neurale di quello stato di consapevolezza attento ma rilassato presente sia nella pratica di Mindfulness che nel processo creativo. Anche l’attività delle onde delta sembra giocare un ruolo importante sia nella Mindfulness che nella creatività, in quanto è stata associata alle reazioni emotive alle novità, tra le quali emerge soprattutto la sorpresa, ai momenti di insight creativo, ed alle attività che richiedono flessibilità cognitiva.
La flessibilità cognitiva, come riportato da Greenberg, Reiner e Meiran (2012), è associata alla creatività e può essere migliorata attraverso la pratica di Mindfulness. Attraverso il loro lavoro, gli autori dimostrarono che meditatori esperti erano meno “accecati dall’esperienza passata”, quindi trovavano più frequentemente la soluzione migliore, ovvero la più semplice, rispetto a non-meditatori al “Water jar task” (Luchins, 1942; Schultz & Searleman, 1998; in Greenberg et al., 2012). Allo stesso modo, anche persone non esperte, che però seguivano un training di alcune settimane, risultavano più cognitivamente flessibili rispetto al gruppo di controllo (Esperimento 2).
Come scrivono Ostafin e Kassman (2012), “le soluzioni di ieri potrebbero non applicarsi ai problemi di oggi”. La conoscenza pregressa non sempre aiuta a risolvere i problemi, e questo riguarda soprattutto gli “insight problems”.
Pratica di Mindfulness e creatività: l’importanza dell’atteggiamento da principianti
La potenzialità maggiore della pratica di Mindfulness risiede nel cambiamento rispetto al nostro approcciarci al mondo esterno ed interno. Assumendo un atteggiamento da principianti veniamo più facilmente in contatto con le novità proposte dal mondo, con curiosità ed apertura. Parafrasando una frase di Jon Kabat-Zinn (2014), chi ha una vita troppo legata alle conoscenze apprese in passato, difficilmente si farà stupire dalla dimensione dell’ignoto e farà un salto nella creatività, nell’immaginazione, nelle arti. La fissità della conoscenza pregressa agirebbe quindi come una sorta di paraocchi, o filtro, tra la nostra mente e l’esperienza. La centralità dello sforzo ad essere (o ritornare) principianti appare quindi un forte collegamento tra la pratica di Mindfulness e lo sviluppo di creatività ed immaginazione.
Negli studi che propongono una correlazione positiva tra pratica di Mindfulness e creatività, solitamente nella forma del problem solving creativo, è bene tenere sempre presente il fatto che la correlazione non significhi causalità. Potrebbe essere infatti che persone più creative siano più inclini alla consapevolezza sviluppata nel training di meditazione Zen, che assumano quasi naturalmente un atteggiamento da principianti nei confronti del mondo o che riescano ad integrare con poco sforzo la realtà esperita con il piano di conoscenza trascendentale.
Sicuramente il lavoro di ricerca in questo campo è solo all’inizio, ma sembra molto promettente e ricco di potenziali applicazioni sia in ambito quotidiano che in ambito clinico.