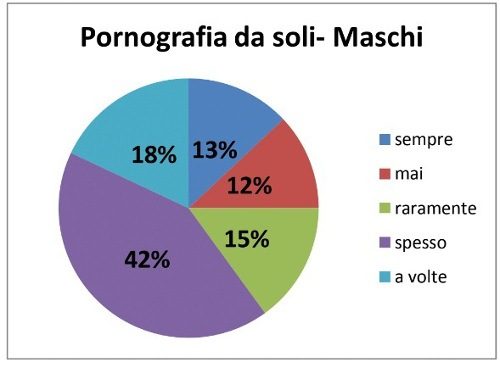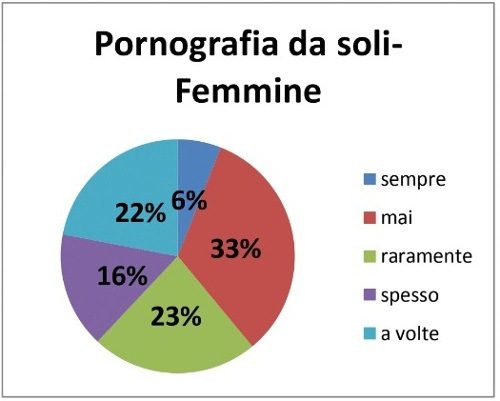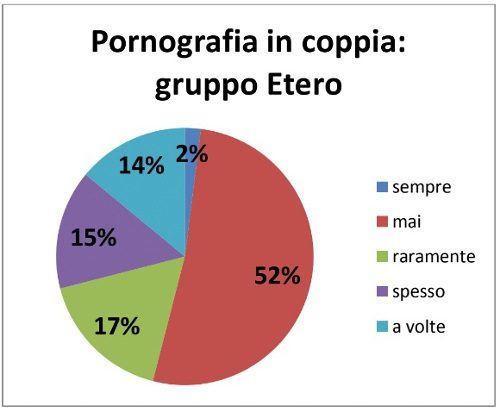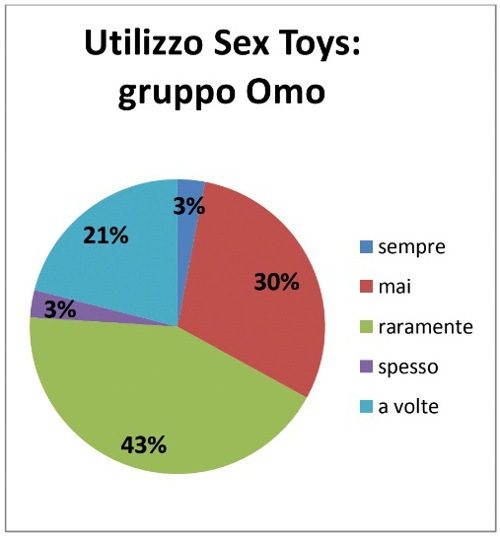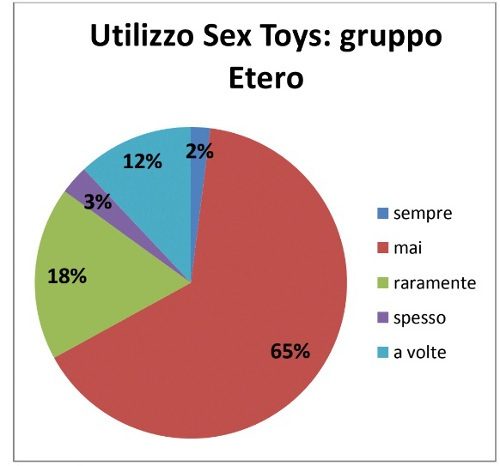L’era del cyber: le relazioni ai giorni nostri
Negli ultimi tempi, si è assistito ad una robusta diffusione di Internet e dei mezzi di comunicazione, in tutto il mondo. Questo fenomeno ha sicuramente portato a dei benefici e miglioramenti nel modo di comunicare perché ha permesso di superare le barriere imposte dal tempo e dallo spazio, fino ad arrivare ad un’infinita possibilità di accesso alle fonti di informazioni. L’altra faccia della medaglia è un cattivo o smodato uso di Internet e dei mezzi di comunicazione, assistendo a fenomeni psicopatologici legati, appunto, a questo uso cattivo della Rete.
Beatrice Mastrolorenzo
La tecnologia al giorno d’oggi
Ferma su un punto del marciapiede ad aspettare che un amico raggiungesse me e il mio ragazzo, il mio sguardo é caduto su una coppia di amiche, ad un tavolo, stavano facendo aperitivo. Mi sono messa ad osservarle, cercare di comprenderle, capirle. Due amiche che si vedono poco, che si raccontano qualcosa e che poi finisce sui social; entrambe con la testa china sui rispettivi schermi, sui loro black mirror per restare in tema.
Vi sarà sicuramente capitato di guardare la serie televisiva Black Mirror di Netflix, dove ogni puntata fa vivere in modo drammatico, a tratti grottesco, quello che ci accompagna nella vita di tutti i giorni: la tecnologia. Viene trattato sotto ogni aspetto il cambiamento che ha investito e travolto le nostre abitudini a suon di notifiche e di click, incentrato sul futuro ma partendo da quelle basi che fanno già parte del presente. Così, la serie televisiva Black Mirror, ci aiuta a darci un’idea delle conseguenze e dei traguardi che le nuove tecnologie possono (vogliono) raggiungere e tutto quello che hanno già, in qualche modo, realizzato. Oltre ogni scenario della mente, si potrebbe pensare, ma in realtà non fa altro che rappresentare quello che temiamo e che sappiamo possa accadere.
Tornando alla scena che stavo osservando della sera, le due ragazze sorridevano, senza scambiarsi il benché singolo sguardo durante i dieci minuti che sono rimasta lì, dall’altra parte della strada. Mi sentivo triste. Ogni tanto bevevano un sorso dai loro bicchieri dei cocktail, il piatto con il cibo era ormai dimenticato, magari prima fotografato e immediatamente postato. Quanti like? Quanti commenti?
Una scena così, una decina di anni fa, sarebbe stata fuori luogo e avrebbe attirato a sé gli sguardi giudicanti e indignati di tutti gli altri intorno. Immaginate un gruppo di scolari portati in visita a Roma, seduti sulle gradinate di Piazza di Spagna; meravigliosa, da contemplare, esplorare andando su e giù e scattare qualche foto. Ora, immaginate questi alunni che compongono una scena diversa: chi seduti e chi in piedi come pali, con la faccia sui loro cellulari di ultima generazione, intenti a scattarsi selfie, senza fare nessuna discussione costruttiva sull’arte e la storia con l’insegnante e magari anche lei è in un angolo a scrivere messaggi. Mi capita spesso, infatti, di vedere scolaresche così, ed è tutto normale, oggi, ma non dieci anni fa, quando le gite erano dei momenti per sapere di più, per mettere in pratica delle skills particolari che magari in aula possono venir facilmente soffocate. La gita era un modo per respirare un’aria più pulita, più fresca, per cantare le canzoni tutti insieme nell’autobus, per fare foto di gruppo, per riscoprire i legami tra alunni e maestri. Poi c’era lo svago quando si tirava fuori la colazione a sacco. La mia intenzione non è fare la nostalgica, però non posso fare a meno di notare le sostanziali differenze tra oggi e ieri quando mi capita di vedere quelle scene.
Le due ragazze intente a scorrere i post rifugiandosi in una realtà inconsistente, mi ha ricordato in modo vivido le fotografie di Antoine Geiger. Il suo progetto Sur Fake ritrae i suoi soggetti in momenti del tutto normali ma con una particolarità che a prima vista sconvolge: le persone fotografate da Geiger hanno la faccia letteralmente risucchiata dai loro smartphone. Le sue foto fanno percepire benissimo il confine così labile tra la normalità e la patologia, quella zona che sta fuori dalla media, da quello che è comune. Geiger ha un messaggio molto forte da trasmetterci, che a me è decisamente arrivato: torniamo a parlare, confrontarci, sorriderci, scherzare, discutere, litigare con le persone che fanno parte del mondo reale e smettiamola di stare attaccati ai nostri cellulari. Quindi il suo invito è quello di staccare il viso dallo schermo. Difficile al giorno d’oggi, considerando che un accesso ad internet non serve solo per scaricare qualche bella immagine o un bel film, ma anche per lavorare, trovare opportunità, studiare, informarsi, rimanere in contatto con persone significative e soprattutto con il resto del mondo.
La tecnologia fa parte della nostra vita.
Quanta tecnologia si usa durante il giorno, come quanta acqua si usa, insomma, ormai, a chi importa davvero? Nessuno di noi ci fa più caso. Si usa la tecnologia per tutto, cosa c’è da spiegare? A tutte le età, in tutti i luoghi. Ventiquattr’ore su ventiquattro è la “faccia” con cui interagiamo di più e in modo ininterrotto, rivolgendo lo sguardo solo lì, quando l’evoluzione ci ha regalato un sistema visivo che si apre fino a raggiungere 360°. Da bambina pensavo che un giorno avrei potuto provare ad allargare il mio sistema visivo, lo volevo più grande, perché così mi sembrava limitante. Adesso, non so a cosa potrebbe mai servirmi, perché tanto i miei occhi sono fissi, come ora, su uno schermo. Che sia grande, che sia piccolo, è un quadro che risucchia tutta la mia attenzione, il mio tempo, gli sguardi che potrei dedicare al resto del mondo fatto di persone come me, colori più realistici che superano quelli imposti dal sistema operativo di un computer di ultima generazione, odori, suoni, ricordi, idee, calore umano.
L’era digitale dell’ultima generazione e la dipendenza da internet
Siamo in quella che si chiama “Era Digitale”, dove le famiglie che hanno un accesso ad Internet da casa sono aumentate nel corso del tempo, perché Internet è utile per studiare, lavorare, svagarsi con un film o per reperire informazioni e quindi, in qualche modo, allargare i propri orizzonti culturali, anche a tempo perso. Secondo l’ISTAT, nel 2014 è aumentata la quota di queste famiglie, rispetto all’anno precedente, che passano dal 60,7% al 64%. Sicuramente l’accesso ad internet riguarda molto di più le famiglie con un minorenne, dove è più presente la tecnologia: l’87,1% ha un pc e l’89% ha un accesso ad Internet (ISTAT, 2014).
Negli ultimi tempi, si è assistito ad una robusta diffusione di Internet e dei mezzi di comunicazione, in tutto il mondo. Questo fenomeno ha sicuramente portato a dei benefici e miglioramenti nel modo di comunicare perché ha permesso di superare le barriere imposte dal tempo e dallo spazio, fino ad arrivare ad un’infinita possibilità di accesso alle fonti di informazioni. L’altra faccia della medaglia è un cattivo o smodato uso di Internet e dei mezzi di comunicazione, assistendo a fenomeni psicopatologici legati, appunto, a questo uso cattivo della Rete. I recenti studi hanno messo in luce la possibilità che si manifesti una vera e propria dipendenza psicologica, nota come IAD (Internet Addiction Disorder), termine coniato dallo psichiatra americano Ivan Goldberg: egli propose più di dieci anni fa, nel 1995, di introdurre nel DSM questo disturbo, proposta che diede avvio a numerosi studi, fino a rendere concreta l’osservazione che un uso eccessivo della Rete porta piano piano a delle difficoltà nella vita della persona, per lo più relazionali, tale da rimanere intrappolato in quello spazio virtuale (Jamison, 2000).
Ed ecco che oggi parliamo spesso di dipendenza da Internet, a scapito delle relazioni sociali e quindi del nostro sviluppo. Rinunciamo in qualche modo a noi stessi. In psicologia, si individua questa forma di dipendenza non esattamente come un disturbo specifico, ma come un sintomo che può essere legato ad altri quadri clinici. Si può parlare di dipendenza quando la persona spende la maggior parte del suo tempo e delle sue energie ad usare l’oggetto da cui non riesce a staccarsi, in questo caso internet, o comunque un cellulare, così da creare un comportamento disfunzionale nel resto delle aree della vita, come quella personale, relazionale e familiare, scolastica/lavorativa, affettiva.
L’idea dei telefoni cellulari – oggi smartphone – era davvero costruttiva, finché poi, un giorno, è successo qualcosa che ha permesso di oltrepassare un limite: la soglia dell’ossessione e, quindi, quella della dipendenza, del desiderio che cresce sempre di più. In psicologia, si usano concetti come craving, addiction, ossessione, dipendenze, discontrollo.
Il craving è l’esperienza soggettiva di un desiderio difficile da arginare, che si autoalimenta ogni volta che questo viene soddisfatto con l’oggetto agognato, che produce gratificazione e piacere. Il craving chiama in causa il circuito della ricompensa, centrale nei disturbi delle dipendenze patologiche e, quindi, anche nei trattamenti di questi disturbi (Kanavagh, Andrade & May, 2004).
Il termine addiction viene usato per definire il campo delle dipendenze patologiche, indicando una situazione di mancanza di libertà, sottomissione, un coinvolgimento così profondo del soggetto verso l’uso di un oggetto che è incapace di limitare quell’attività, una perdita di controllo via via maggiore che la dipendenza diventa sempre più seria. Il craving fa parte dell’addiction.
Oggi si parla di tante nuove addiction, come quella da tecnologia. Da cellulari. Da social network. Da internet. Da tutto quel che uno schermo può offrirci.
In realtà, il dibattito sulla possibilità di sviluppare o meno una dipendenza verso la Rete, così come per l’alcool o una droga, ancora non è chiuso. Infatti, molti studiosi riconoscono il fenomeno per cui abusando di Internet si può arrivare a produrre delle conseguenze negative, ma rifiutano di parlare di vera e propria dipendenza, sostenendo che alla base di questa idea ci sarebbe bisogno di ulteriori risultati scientifici e che parlare dell’uso eccessivo di Internet come un disturbo psichiatrico, potrebbe essere fuorviante per la clinica (Huang M.P. e Alessi N.E., 1996).
Brenner (1996) ritiene che trascorrere molto tempo davanti al computer ha come conseguenze, sintomi che non per forza portano allo sviluppo di una dipendenza, sintomi come una perdita del sonno e della fame, un’incapacità di gestire il tempo. Kymberly Young, dal canto suo, sostiene che i soggetti dipendenti subiscano delle conseguenze che possono essere anche gravi a causa dell’abuso di Rete, mentre i soggetti che sono normali utenti non manifestano nessuna interferenza nella vita quotidiana e considerano la Rete come una risorsa.
I problemi di cui l’autrice parla sarebbero nell’ambito relazionale e familiare, in quanto l’aumento di ore collegato alla Rete diminuisce quelle dedicato alle persone significative. Quindi lo spazio virtuale assume maggiore importanza fino ad estraniarsi sempre di più. Nell’ambito lavorativo e scolastico, l’eccessivo uso della Rete porta a distogliere l’attenzione da questi doveri e porta anche a un ciclo sonno-veglia meno regolare che invalida, quindi il rendimento lavorativo e scolastico. Non mancano le consulenze nell’ambito della salute perché tante ore davanti al computer possono portare a problemi di postura, ma anche disturbi del sonno, irregolarità dei pasti, mal di testa, occhi stanchi, etc. Possono presentarsi anche problemi finanziari se l’uso smodato della Rete consiste anche in gioco d’azzardo, partecipazione ad aste, commercio on-line, fruizione di materiale pornografico.
Nell’ultima versione del DSM (DSM-5) non è inclusa la voce “Internet addiction”, ma l’unico comportamento da dipendenza in fatto di Internet è il “gambling disorder”. Comunque sia il termine dipendenza da Internet o Internet addiction è un termine vasto che copre diversi comportamenti e problemi di controllo degli impulsi. Chi presenta i sintomi di dipendenza da Internet, di solito presenta anche altre forme di dipendenza.
Il senso di alienazione derivante dalla tecnologia
La nostra cara tecnologia ha messo in rilievo un suo aspetto, quello alienante. Aldilà della sua definizione, il fotografo Babycakes Romero ha reso bene l’idea con il suo fotoprogetto “Death of conversation”, ovvero morte della conversazione: i protagonisti dei suoi scatti sono concentrati sui loro cellulari, intenti a chattare, leggere, scorrere i post offerti dalla rete, e minimi contatti sociali tra di loro. Romero spiega che non ha nessun problema con la tecnologia, pensa, invece, che i cellulari ci rendano più facili degli aspetti della nostra vita, tuttavia “la gente ne sta abusando diventa sempre più chiusa”.
Il professionista Romero si esprime così: “Prima che le persone iniziassero ad utilizzare i telefoni cellulari erano più propense ad interagire fra loro, attività che ora non si rende più necessaria perché concentrati ad interagire con i propri dispositivi mobili”. Oggi possiamo evitare di instaurare una conversazione con chi ci siede accanto, potendo semplicemente illuminare lo schermo nero e cercare qualcosa di interessante, anche se effettivamente non c’è, evitando così l’arduo compito di pensare a qualcosa da dire all’altro. Paradossalmente, i telefoni cellulari stanno rendendo difficile la comunicazione, quando invece sono nati con tutt’altra intenzione: finalmente distanze accorciate, finalmente storie d’amore che superano gli ostacoli, finalmente qualcuno che ci cerca anche solo per sentire la nostra voce o scriverci un messaggino inutile – fondamentalmente. Poi siamo passati alle notifiche e all’astinenza che si prova quando la finestra di controllo dello smartphone è nuda e cruda. Adesso le notifiche sappiamo come averle perché basta qualche social network, postare delle foto e subito like e commenti arrivano da ogni parte del mondo, in tanti tipi di lingua, con tante e sconosciute intenzioni alla base, come la faccia che guardava la nostra foto. E siamo contenti, la giornata può continuare perché facciamo parte del mondo, della società, ognuno di noi può fare qualcosa, io, tu e gli altri, abbiamo una vita da mostrare a chiunque sia collegato.
Nella lagunare alienazione tecnologica, la buona notizia è che ci sono dei segnali di allarme che posso far pensare ad una possibile dipendenza da Internet. Vediamoli insieme:
– Isolamento dalla famiglia e dagli amici;
– Perdere il senso del tempo online;
– Avere difficoltà nel portare a termine dei compiti;
– Sensi di colpa legati all’uso di Internet;
– Sentire dell’euforia quando si è connessi.
C’è di più: Internet ha sicuramente le caratteristiche di immediatezza, facilità, ma l’uso così smodato e le conseguenze negative sono dovute anche ad altri fattori alla base: ansia, depressione, stress perché la Rete è usata come un modo per cercare di sentire meno disagio. Secondo alcuni studiosi chi sviluppa una tale dipendenza ha alla base una personalità propensa all’ impulsività, alla ricerca di nuove esperienze e alcuni tratti di aggressività (Ko et al., 2010; Park et al., 2012; Ma, 2012).
Ecco che un po’ è colpa di Internet e un po’ anche nostra; riflettiamo su questo punto.
Alla fine sono riuscita a staccarmi da quella coppia di ragazze che stavano trascorrendo la serata ognuna per i fatti propri, si potrebbe quasi dire che ognuna era in casa sua, ma per davvero. Ognuna aveva una sua home dove guardare notizie, ricevere messaggi, telefonate, dove poteva ridere e sorridere.
Poi è arrivato quell’amico che aspettavamo. Aveva due birre in mano e nessun posto per un cellulare. Il mio ragazzo era alle prese con una coppetta di gelato e il cucchiaino. Io ero semplicemente contenta di chiacchierare.