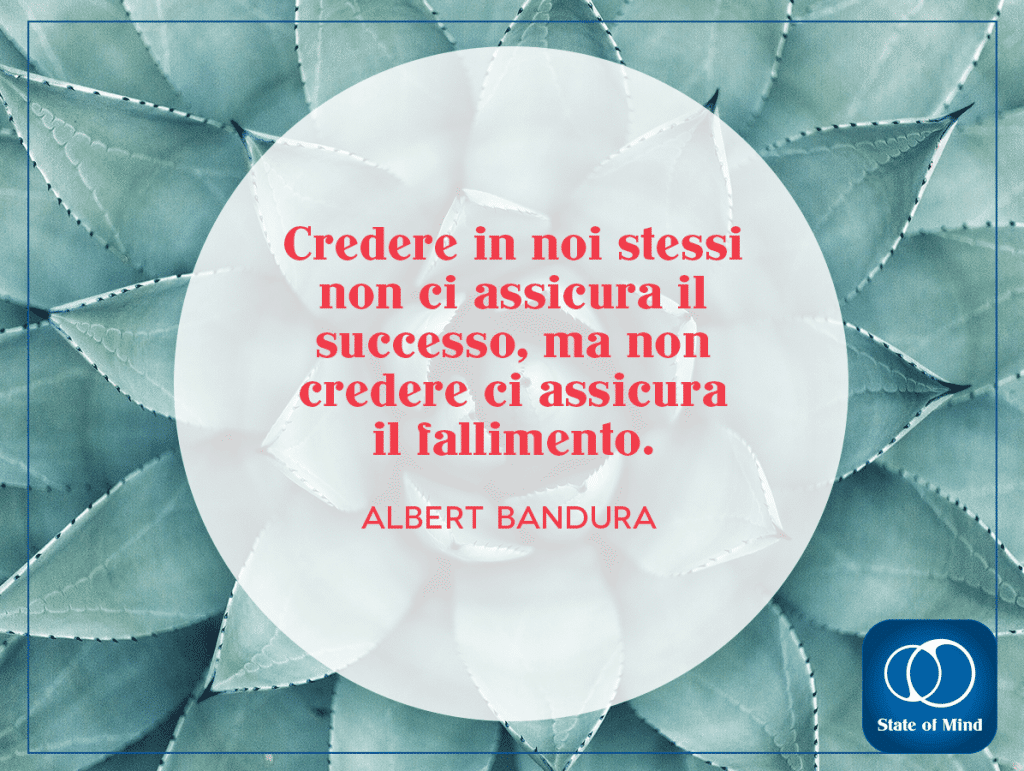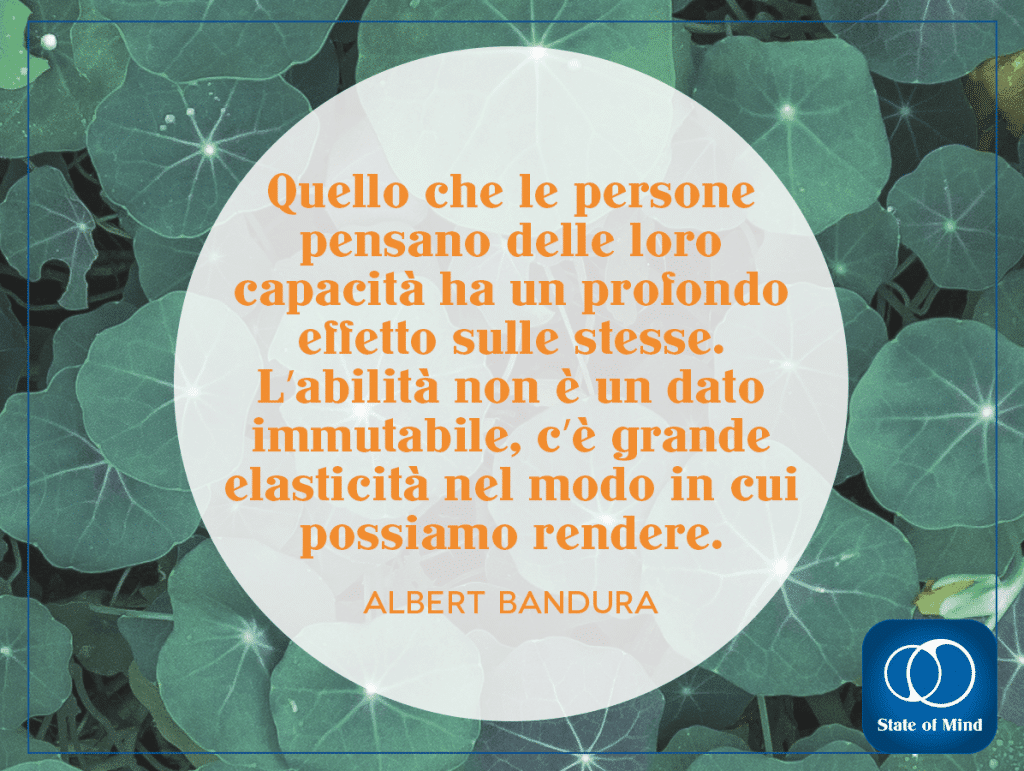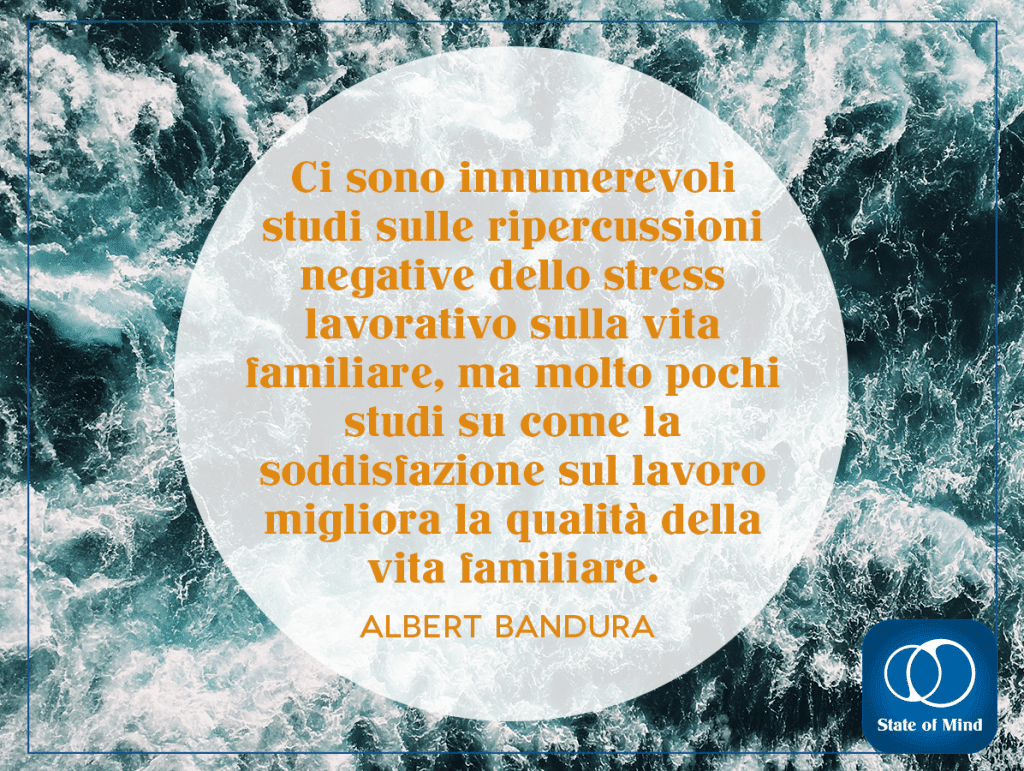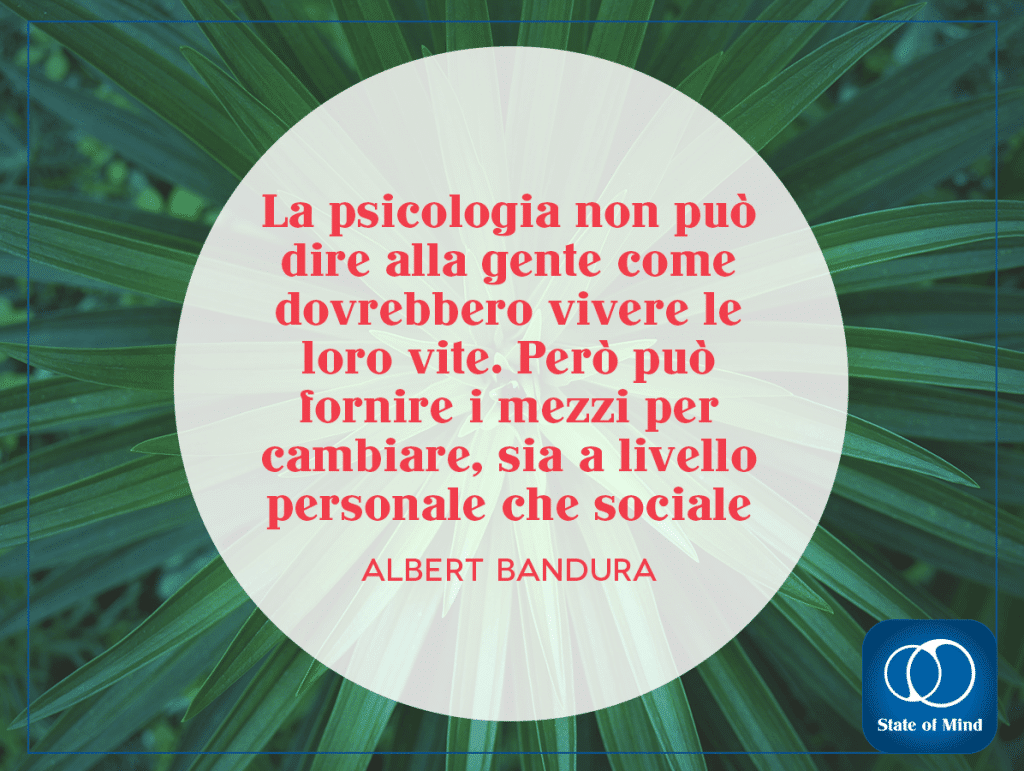Hellblade: l’esperienza della malattia mentale attraverso un videogame?
E’ possibile sperimentare la schizofrenia attraverso un videogame? Accendete la vostra consolle, e accomodatevi nella testa della guerriera Senua, in Hellblade. La Dott.ssa Viola Nicolucci ne ha parlato nella conferenza “Psicologia, Tecnologia e Trasformazione”.
Secondo voi un videogioco può insegnare? Federico Pucci, in un articolo sul sito dell’Ansa, esordisce dicendo:
[blockquote style=”1″]Che il videogioco intrattenga, emozioni, coinvolga, è noto: ma può anche insegnare? [/blockquote]
Ebbene si, un videogioco può anche insegnare. A volte il potere didattico dei videogiochi è per lo più tradizionale, come nel caso dell’ultimo “Assassin’s Creed Origins” in cui, grazie alla modalità Discovery Tour – Antico Egitto, si può usufruire di un’esplorazione interattiva dell’Antico Egitto ai tempi di Cleopatra. Altre volte, dal punto di vista psicologico, un videogioco può allenare una serie di skill, incrementare l’efficacia del processo decisionale, favorire lo svilupparsi dell’intelligenza emotiva o portare alla luce temi sensibili da discutere apertamente quali il suicidio, l’eutanasia, il bullismo e la ricerca di un’identità sessuale nell’adolescenza.
Di esempi, in quest’ultimo caso, ce ne sono diversi. Basti pensare a “Life is Strange”, videogioco prodotto dalla Dontnod e pubblicata dalla Square Enix. Ultimamente però la didattica dei videogiochi ha fatto un interessante passo in avanti. A tal proposito, vorrei cogliere l’occasione per parlarvi del lavoro della Dott.ssa
Viola Nicolucci (psicoterapeuta dell’Ordine degli Psicologi del Piemonte) che ho avuto l’onore di conoscere durante la conferenza
“Psicologia, Tecnologia e Trasformazione” tenutasi il 26 gennaio 2018 a Torino. Il tema del suo argomento si focalizzava su
Hellblade: l’esperienza della malattia mentale attraverso un videogame. Sperando di non tralasciare nulla cercherò di riportarvi fedelmente i concetti trattati dalla collega, avvalendomi delle risorse offerte dal Web al solo scopo di aiutarmi.
Cos è la Gamification? A cosa serve in un processo di comunicazione?
Prima di iniziare a parlarvi di “Hellblade: Senua’s Sacrifice”, vorrei introdurvi il concetto di “gamification”. Il termine deriva dalla parola “Game”, cioè gioco, anche solo per semplice divertimento. La Gamification, traendo vantaggio dall’interattività concessa dai mezzi moderni e dai principi alla base del concetto stesso di divertimento, rappresenta uno strumento molto efficace in grado di trasmettere messaggi di vario tipo. Il suo obiettivo è di applicare meccaniche ludiche ad attività che non hanno direttamente a che fare con il gioco; in questo modo è possibile stimolare e consolidare l’interesse attivo da parte degli utenti coinvolti sul messaggio che si vuole comunicare.
Per raggiungere questi obiettivi, il processo di communication design deve essere necessariamente ripensato per introdurre meccaniche e dinamiche di gioco, aggiungendo ai fattori tradizionali altri elementi trainanti (ancora, mutuate dal mondo del “gaming”) che possano attirare e ri-attirare l’interesse e l’attenzione dell’utenza su specifici contenuti.
Come si crea coinvolgimento? Ce lo spiega B.J. Fogg, padre della captologia
Anche in Hellblade le meccaniche e le dinamiche di gioco sono gli strumenti per “gamificare”: l’introduzione di concetti come punti, livelli, missioni e sfide incoraggia gli utenti ad investire il proprio tempo, spingendoli alla partecipazione, al coinvolgimento efficace, nonché aiutandoli a costruire delle relazioni all’interno del gioco. Perché la gamification funzioni sono essenzialmente necessarie due componenti: l’applicazione di dinamiche efficaci e l’uso delle giuste tecnologie. Ed in questo, B. J. Fogg, padre della Captologia (ovvero della scienza che studia i fenomeni che stanno nell’intersezione tra software e hardware da un lato, e i sentimenti e le attitudini umane scatenati dalla persuasione dall’altro) ci può spiegare parecchie cose. Grazie al modello sviluppato da Fogg, è possibile individuare tre fasi fondamentali: 1) fornire una motivazione, 2) fornire degli strumenti per partecipare, 3) offrire uno spunto da cui partire. Eccoli molto sinteticamente:
- Fornire una motivazione
Bisogna dare alle persone un motivo per partecipare: il meccanismo del gioco e della sfida è profondamente radicato nella mente umana ed è uno stimolo potentissimo; affinchè funzioni è fondamentale che i giocatori abbiano davanti a loro un premio, una meta, un obiettivo che ne attiri l’attenzione e ne aumenti la determinazione
- Fornire degli strumenti per partecipare
Perché la gamification funzioni è necessario che tutti i soggetti coinvolti abbiano a disposizione le stesse possibilità e gli stessi strumenti per andare avanti
- Offrire uno spunto da cui partire
Ogni attività di gamification che si rispetti ha bisogno di un momento di avvio che funga da momento zero da cui far partire la sfida. Se tutte le meccaniche del gioco non si attivano in maniera coordinata, il rischio è che i partecipanti perdano rapidamente l’interesse in ciò che stanno facendo.
In Hellblade Senua’s Sacrifice ritroviamo tutte e tre queste fasi. Senza anticiparvi nulla vi inviterei a leggere il prosieguo dell’articolo benchè ci sia ancora un elemento di cui vi voglio parlare: l’avatar. La possibilità di rappresentare visivamente il proprio personaggio sottende alcuni meccanismi motivazionali come un maggior senso di autonomia e un maggior legame di tipo affettivo con il gioco. Diversi studi sull’avatar hanno prodotto interessanti ricerche tra cui l’Effetto Proteus.
Qual è la malattia mentale di Senua, guerriera di Hellblade?
Trattare un tema così delicato come quello della schizofrenia non è sicuramente un’impresa semplice, e finora l’ha fatto il cinema, non il mondo dei videogame.
Il primo tentativo è “Hellblade: Senua’s Sacrifice“, uscito nell’estate 2017 su PC, PS4 e a breve anche per Xbox One. Il videogioco presenta marcati riferimenti alla mitologia norrena: da protagonisti del gioco vestiamo i panni di Senua, guerriera celtica affetta da una grave forma di schizofrenia, esiliata dal suo villaggio perché ritenuta responsabile di funesti avvenimenti e pestilenze. La mente già fragile della ragazza è ulteriormente penalizzata dalle torture psicologiche indotte dal padre, che fin da piccola la sottopone a dei riti druidici per “liberarla” dalla sua maledizione. Dopo il ritorno dall’esilio Senua vede il suo amato Dillion, l’unico in grado di comprendere i suoi deliri, crocefisso barbaramente dall’attacco dei nordici, come sacrificio agli Dei. Lo shock sarà così forte da aggravare ulteriormente le condizioni di Senua, portandola in un perenne stato di psicosi in cui sente delle voci. Almeno inizialmente, il viaggio di Senua attraverso il fiume dei morti, non sembra essere esplicitamente legato alle sue psicosi. L’obiettivo della protagonista è difatti quello di liberare l’anima del suo adorato riconsegnando la sua testa a Hela, la Dea norrena dei morti e sovrana di Helheim. Il gioco si apre con un avviso piuttosto esplicito: lo sviluppo del titolo è avvenuto con l’ausilio di esperti in psichiatria e la consultazione di pazienti affetti da turbe psichiche.
Quale esperienza si fa in Hellblade?
Avviando la partita, iniziamo finalmente a scivolare lungo un fiume, guidando lentamente una rozza canoa, nei panni della tormentata Senua. Immediatamente giungono alle nostre orecchie un nugolo di sussurri: voci che si accavallano, discutono fra loro, deridono, guidano o rimproverano la protagonista come se noi non ci fossimo. La stessa protagonista parla di sé in terza persona, restituendo un senso di estraneità e scarsa autocoscienza. Il primo guizzo narrativo prende forma quando Senua parla anche con noi, trattandoci proprio come una delle sue tante “voci”. In questo modo entriamo subito nella mente della ragazza, stabilendo un rapporto sempre più intimo e morboso con la sua psiche malata. Nel video presente qui sotto avrete conferma di quanto vi ho detto.
(Hellblade: Senua’s Sacrifice – Intro: Only Voices)
Sentire le voci nella testa di Senua
Le voci di Senua, ottenute sfruttando l’audio 3D binaurale al solo scopo di renderle davvero realistiche, sono la concretizzazione di tutte le sensazioni che le riecheggiano in testa, siano esse un sottile ma avvertibile desiderio di morte, l’entusiasmo per una nuova scoperta, la paura del fallimento o il timore che tutto sia un inganno. Di tanto in tanto Senua sembra parlarci direttamente, raccontarci le sue paure, e testimoniare un desiderio di vendetta alternati ad attimi di abbandono integrale.
In un certo senso, è come se stessimo assistendo a una seduta psichiatrica, registrando con spirito voyeuristico le reazioni di una paziente. E forse il “viaggio” di Senua rappresenta proprio questo: una lunga e faticosa lotta per esorcizzare la sua malattia fatta di visioni, suoni, correlazioni apparentemente impensabili, percezione alterata dei colori e della realtà, fino a momenti in cui la mente si “spegne” e in cui non c’è alcun appiglio cui aggrapparsi.
Quale guerra combattiamo? Dentro o fuori la nostra testa?
Verso la fine dell’avventura, giunta al cospetto di Hela, divinità infernale, descritta come una donna bruciata per metà, Senua rivedrà la propria madre, che fu messa al rogo perché soffriva della stessa forma di psicosi che poi svilupperà anche lei. Tuttavia ci sarebbe da chiedersi, però, se questo momento di catarsi con la figura materna sia stato raggiunto davvero attraverso una sfida fatta di prove e battaglie, oppure se il viaggio della protagonista sia avvenuto solo ed esclusivamente nella sua mente. A un certo punto una delle voci nella testa della ragazza dice chiaramente che “le battaglie più difficili sono quelle combattute nella tua testa”. Potrebbe darsi, allora, che lo strano balletto di fendenti e affondi della protagonista, sia in realtà soltanto immaginato. Molto spesso, durante gli scontri, non si ha un’inquadratura di tutti i nemici che stiamo affrontando. Nel caso in cui un avversario attacchi Senua da un angolo cieco, saranno le voci ad avvertirla – “attenta alle spalle!” -, così che sia possibile eseguire un contrattacco col giusto tempismo. Eppure, se le voci esistono solo nella testa di Senua, e lei non sta vedendo il nemico pronto a colpire, come possiamo esserne informati? L’unica prospettiva plausibile è che tutto esista davvero solo nella sua mente.
Durante la progressione esplorativa del gioco Senua allucina rune luminose, con colori e luci che sono amplificati o attenuati. Attraverso queste rune la protagonista si ritrova a risolvere dei veri e propri puzzle, che implicano l’utilizzo di un aspetto della sua malattia mentale per “vedere le cose in modo diverso”. Tale particolarità si riferisce ad un fenomeno psicologico creativo chiamato apofenia, ed è qualcosa in cui tutti ci impegniamo. Si ritiene però che le persone con disturbi psicotici siano più abili in questo tipo di processo creativo e vi s’impegnino involontariamente più frequentemente. Affine al concetto di apofenia vi è quello di pareidolia. Tuttavia, di questi due aspetti, ve ne riparlerò poi verso la fine.
Perchè non stigmatizzare la malattia mentale
Tra gli extra inclusi in Hellblade: Senua’s Sacrifice è disponibile anche un video da che approfondirà il profilo psicologico della protagonista Senua. Per garantire una rappresentazione accurata, il team ha collaborato con Paul Fletcher, uno psichiatra e professore di Neuroscienze della salute presso l’Università di Cambridge nonché pazienti affetti da turbe psicotiche. Intitolato Hellblade: Senua’s Psychosis, questo video spiega il decorso della malattia, le sintomatiche principali e soprattutto un concetto fuori dalle righe, ovvero che stigmatizzare la malattia mentale non solo è controproducente per i soggetti affetti (che possono essere anche amici o parenti), ma anche dannoso nei confronti della conoscenza stessa, poiché approfondire e cercare di capire una situazione diversa dalla nostra può farci aprire gli occhi su cose che credevamo impossibili. Insomma, uno sprono ad aprire la mente e a vedere la vita in maniera diversa.
(Hellblade: Senua’s Sacrifice | Senua’s Psychosis Teaser | PS4 & PC)
Cos è l’apofenia? Chi la sperimenta?
Per spiegarvi il concetto di apofenia, mi servirò dei contenuti presi dal sito di Capuano. L’apofenia è la percezione spontanea di connessioni significative tra fenomeni che non hanno alcuna relazione tra loro. Il termine fu coniato dallo psichiatra tedesco Klaus Conrad, che lo descrisse come l’osservazione immotivata di connessioni da una precisa sensazione di anormale significatività. Per Conrad, l’apofenia è parte di un modello evolutivo della schizofrenia che comprende quattro fasi: Trema, Anastrofè, Apofenia (o Apofania) e Apocalisse. Nel vocabolario del suo inventore, dunque, il fenomeno è strettamente collegato a una forma patologica. Oggi, però, si tende a usarlo in maniera più estesa e indipendentemente da condizioni psichiatriche. Capuano continua dicendo che
[blockquote style=”1″]…c’è qualcosa nella nostra mente che fa sì che tendiamo a rinvenire connessioni significative tra eventi fra loro indipendenti[/blockquote]
Questo qualcosa può assumere talvolta una dimensione patologica, come quando qualsiasi correlazione tra eventi è assunta come significativa. Una situazione che si verifica in alcuni casi di schizofrenia e paranoia.
Il concetto di
apofenia va tuttavia ben oltre. Esso ci dice che la nostra mente tende naturalmente e normalmente a “mettere insieme” ciò che è separato, ad attribuire significati a cose che non ne hanno. Sono state fornite varie spiegazioni per questo curioso fenomeno. Secondo il neurologo svizzero
Peter Brugger, gli esseri umani hanno la tendenza pervasiva a scorgere ordine nelle configurazioni casuali. Non solo, ma la propensione a vedere connessioni tra oggetti o idee senza alcuna relazione apparente tra loro accomuna fortemente la psicosi alla
creatività. Apofenia e creatività potrebbero quindi essere viste come due facce della stessa medaglia.
Sappiamo sempre riconoscere l’apofenia?
Con un esperimento realizzato da Naftulin, Ware e Donnelly nel 1973, l’autore ci dimostra un caso concreto in cui si tende a desumere un significato da parole o situazioni che ne sono privi. I tre autori dell’esperimento scrissero un discorso strampalato che aveva ad oggetto la teoria matematica dei giochi applicata all’istruzione medica. Il discorso era pieno di neologismi, frasi insensate e contraddittorie. Un attore, assolutamente incompetente in materia, ebbe l’incarico di pronunciare il discorso di fronte a una platea composta da undici educatori, psicologi e psichiatri ai quali l’oratore era stato presentato come un esperto della materia. La videoregistrazione del discorso fu poi presentata a un gruppo composto da undici psichiatri, psicologi e assistenti sociali e in seguito a un terzo gruppo composto da trentatré educatori e amministratori. Al termine del discorso, a tutti fu chiesto di riempire un questionario per valutare il livello di gradimento di ciò che avevano appena udito. Sorprendentemente, la maggior parte dei partecipanti ai tre gruppi attribuirono un elevato punteggio di soddisfazione all’oratore, sottolineandone le abilità verbali, la conoscenza degli argomenti trattati e la buona disamina degli stessi. Che cosa era successo? Nonostante la loro esperienza, i componenti dei tre gruppi erano stati condizionati più dalla prestazione recitativa dell’attore, dallo stile espositivo e dalle motivazioni e aspettative di apprendere che dal contenuto del discorso stesso. Insomma, un setting adeguato e uno stile accattivante possono dare agli individui l’illusione di aver appreso significati che invece non esistono.
Cos è la pareidolia?
La pareidolia è un processo in cui uno stimolo visivo o sonoro, vago e casuale, viene erroneamente interpretato come una forma riconoscibile. Uno degli esempi più classici è probabilmente quello delle osservazioni delle nuvole. Chi di noi non ha trascorso del tempo a guardare le nuvole provando ad assegnare una forma ad ognuna? Il nostro cervello divide il mondo in schemi e quotidianamente prova a interpretarli in tutto il mondo che ci circonda. Quando proviamo a risolvere un problema, abbiamo bisogno di trovare somiglianze con qualche problema in precedenza risolto e questo ci aiuta perché risparmiamo tempo. La ricerca delle somiglianze (pattern recognition) è anche ciò che ci permette di distinguere i volti, i suoni (voci). La pareidolia è una caratteristica intrinseca dell’evoluzione del nostro cervello e dei centri adibiti al riconoscimento. Noi esseri umani, facciamo fatica a vedere forme casuali, cerchiamo sempre di associare un senso, qualcosa che il nostro cervello riconosce. Dove c’è solo una macchia, un’ombra, vediamo forme, volti e tutto ciò che arriva dalla nostra immaginazione. Le illusioni ottiche dei dipinti di Salvador Dalì o perché no il test delle macchie di Rorscharch, sono due esempi in cui utilizziamo la pareidolia.

Tuttavia, qual è l’origine di questo processo? Le spiegazioni a questo fenomeno sono tante. Per esempio, Jeff Hawkins afferma che sia dovuto al fatto che noi esseri umani abbiamo la tendenza a stabilire degli schemi seguendo le nostre esperienze e le credenze. In pratica, il nostro cervello da un senso a ciò che vediamo dipendendo da ciò che abbiamo vissuto e dalle nostre aspettative. Carl Sagan ci propone al contrario un’altra teoria. Egli Afferma che sia dovuto ad una tecnica ancestrale di sopravvivenza, dato che in passato, distinguere i volti degli amici dai nemici era fondamentale per salvare la vita. Così, il nostro cervello si è andato perfezionando e attualmente sarebbe programmato per identificare volti umani usando pochissimi dettagli. Così potremmo riconoscere una persona a distanza, anche con poca luce.
Nel 2009 uno studio molto interessante appoggia la teoria di Sagan. In questo esperimento si è riscontrato che percepire volti umani in immagini confuse provoca un’attivazione della corteccia ventrale fusiforme, una risposta che si riscontra quando vediamo dei volti reali ma non quando vediamo degli oggetti. Gli scienziati ipotizzano che questa zona si è andata specializzando nel riconoscimento dei volti e agisce in modo praticamente automatico per, in seguito, dare tempo al cervello di percepire se il volto mostra ira e aggressività o se, al contrario, è un volto amico.
Dove troviamo pareidolia e apofenia in Hellblade?
In Hellblade Senua’s Sacrifice dove sono però evidenti la pareidolia e l’apofenia? Se visionerete il video di Youtube che vi ho postato verso la fine, soffermandovi esattamente al minutaggio 8:52 e al minutaggio 13:12, avrete ben chiaro dove appaiono questi due fenomeni di cui vi ho parlato.
Come potrete notare anche voi, in un primo momento, la protagonista riconosce un volto familiare all’interno della cascata dove è presente un volto roccioso. In seguito Senua riesce a trovare una relazione, un collegamento, tra una sua allucinazione visiva e un elemento della realtà. Quanto vi ho detto tuttavia è una mia riflessione personale che potrebbe essere, perché no, per voi alquanto opinabile.
(Hellblade: Senua’s Sacrifice Part 5 | Pareidolia)