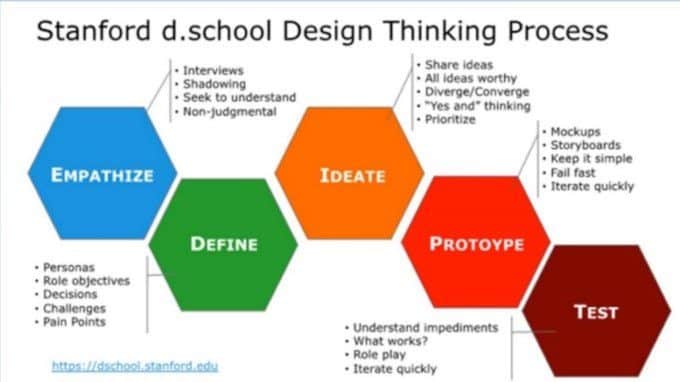Alla ricerca della sintonizzazione
Prerequisito indispensabile per una buona alleanza (e di una buona terapia) è la sintonizzazione tra terapeuta e paziente, tra due persone che interagiscono tra di loro. Intendo per sintonizzazione una forma di legame che va al di là dell’autoriflessività del terapeuta o del paziente, della comprensione dei bisogni dell’utente, del perseguimento di obiettivi comuni o della soddisfazione delle aspettative di entrambi i membri della relazione.
Si suggerisce l’ascolto di Something Stupid di Lola Marsh durante la lettura.
Si parla e si è parlato molto di
alleanza terapeutica e di come preservarla. Gli autori da citare sarebbero decine ma non è questa la sede. Tuttavia, prerequisito indispensabile per una buona alleanza (e di una buona terapia) è la
sintonizzazione tra terapeuta e paziente, tra due persone che interagiscono tra di loro. Intendo per
sintonizzazione una forma di legame che va al di là dell’autoriflessività del terapeuta o del paziente, della comprensione dei bisogni dell’utente, del perseguimento di obiettivi comuni o della soddisfazione delle aspettative di entrambi i membri della relazione. Va al di là anche delle classiche dinamiche di rottura e riparo della
relazione di cui tanto è ricca la letteratura. Una
sintonizzazione scarsa o assente tra terapeuta e paziente diventa un problema: “
Prima che per ciò che genera, per ciò che non genera: non genera le risposte adeguate a una serie di domande implicite poste dal paziente” (Salvatore, 2018). Ma allora che cos’è la
sintonizzazione e dove si trova? Come si acquisisce? La risposta è…42 (Adams, 1980). Scherzo (o forse no)!!!
La sintonizzazione è…
E’ più semplice “sentire” la sintonizzazione dentro di sé, piuttosto che spiegarla, è più facile “trovarla” che cercarla. Si è scritto tanto sulla sintonizzazione preriflessiva tra madre e neonato, tuttavia forme molto raffinate di connessione si possono trovare in qualsiasi tipo di relazione: tra amici, fidanzati, conoscenti, ma anche con lo sconosciuto in ascensore. A volte sono scambi che durano meno di mezzo secondo: uno sguardo di intesa, una risata assieme, una battuta, un semplice saluto, oppure un gesto di scuse. In ogni caso, sono sempre accompagnati da un correlato somatico positivo: calore alla pancia, muscoli distesi, postura aperta, sorriso, rilassamento, ecc. Sintonizzazione preriflessiva è: “La percezione immediata di essere simile all’altro” (Salvatore, Dimaggio, Ottavi, Popolo, 2017).
Si tratta di aspetti prosociali che non sono ragionati e sono anche difficilmente verbalizzabili, tuttavia capitano e ci fanno sentire bene. Esattamente come la famosa mamma sintonizzata (decantata dalla letteratura di psicologia evolutiva degli ultimi 60 anni) che gioca col neonato. Lei non lo fa di proposito, non decide cosa dire e come agire, lo fa e sa come farlo. Sono processi relazionali continui, spesso inconsapevoli, in cui ci si scambia e si comunica in modo sintonizzato (Stern, 2005). Winnicott parlava di “rispecchiamento” (Winnicott, 1971). Si tratta di un automatismo neurofisiologico che favorisce la sintonizzazione preriflessiva e profonda con l’altro (Rizzolati et al., 2002). Non vi è nessuna logica o inferenza, è una procedura automatica inconsapevole, preverbale e paraverbale che connette gli stati mentali dell’uno e dell’altro (Gallese, 2003). Sono connessioni sensomotorie, che permettono la co-regolazione emotiva e somatica dei partecipanti ma anche la loro postura, la gestualità, il grado di vicinanza o di distanza tra loro (Ogden, Fisher, 2015). Una sintonizzazione deficitaria o assente nei legami genitori-neonati, genitori-bambini e più in generale nei legami intimi, può portare ad avere relazioni affettive insoddisfacenti in età adulta. La persona può avere difficoltà a sintonizzarsi anche nelle relazioni più intime, non riesce a entrare in risonanza affettiva con gli altri, è assente quella condizione del sentirsi connessi e vicini agli altri, magari si riesce a comprendere gli altri ma se ne rimane distanti, provando sofferenza, senso di inefficacia e indegnità (Salvatore, Dimaggio, Ottavi, Popolo, 2017).
Con pazienti gravi o con scarsa capacità di sintonizzazione diventa perciò fondamentale creare un buon clima relazionale in seduta fin da subito, questo non è però cosa scontata da realizzarsi, è importante che il terapeuta trovi dei modi adatti per innescare e alimentare questa compartecipazione, parlando anche di altro: sport, musica, cinema o interessi comuni (Salvatore, Dimaggio, Ottavi, Popolo, 2017) e riconoscendo costantemente cosa accade nella “pancia” del terapeuta mentre il paziente è di fronte a lui. Il terapeuta capisce quando risulta più produttivo sospendere le sue pratiche terapeutiche cercando di sintonizzarsi con il paziente. Dialoga con lui all’interno di “nicchie di condivisione” relative a temi di interesse comune non inerenti la terapia (Liotti, Fassone, Monticelli, 2017). Operazioni del genere favoriscono la sintonia tra terapeuta e paziente, abbassano le difese e il disagio del paziente, favoriscono l’accesso a stati mentali interni positivi, innescano la curiosità e la cooperatività (Salvatore, Dimaggio, Ottavi, Popolo, 2017).
Momenti di significativa sintonizzazione reciproca possono anche diventare la causa principale del cambiamento in terapia (BCPSG, 2012). D’altronde è più che normale: si tratta di persone che non hanno mai esperito stati del genere, da neonati venivano allattati o cullati senza alcuna risonanza affettiva, da bambini giocavano da soli, da ragazzini non venivano incoraggiati nelle loro scelte o interessi e da adolescenti non capiti nei loro legittimi desideri esplorativi.
Dobbiamo essere noi terapeuti a far loro vivere e rivivere questi stati, spesso mettendo da parte le tecniche, le nostre conoscenze, gli ABC o altri strumenti che paradossalmente possono aumentare la distanza e l’invalidazione, dimenticare per un attimo gli anni di studi e i libri (“Il terapeuta troppo efficiente che diventa deficiente” cit. da supervisione individuale), modulando la nostra fretta di “guarirli” e semplicemente “stando” con loro in modo autentico e sentito. Un po’ bisogna esplorare i temi e gli argomenti comuni, altre volte invece è necessario che rilassiamo le spalle e ci lasciamo andare (e qui la disciplina interiore, gli schemi e l’autoriflessività del terapeuta giocano un ruolo fondamentale), senza cercare la risposta giusta o l’argomento ottimale, senza pensarci troppo. Una buona sintonizzazione quindi soddisfa almeno due obiettivi terapeutici: oltre a favorire momenti di condivisione emozionale profondi e sentiti (raramente sperimentati da pazienti con strutture di personalità così rigide e pervasive), favorisce in loro una migliore comprensione del proprio mondo interno, stimolando maggiore autoriflessività e la differenziazione. Queste due funzioni sovracorticali: condivisone emotiva e autoriflessività, diventano il punto di partenza di ogni cambiamento clinico.
Nelle oscure stanze, la sintonizzazione “in vivo”
Vediamo adesso cosa succede nello studio e come si manifesta questa sintonizzazione tra terapeuta e paziente durante il dialogo clinico. Faccio alcuni esempi reali esponendo ogni caso attraverso la ricostruzione dello schema di funzionamento dei pazienti seguendo il modello della Terapia Metacognitiva Interpersonale: TMI (Dimaggio, Montano, Popolo, Salvatore, 2013).
Diego, 45 anni, prima seduta, paziente con funzionamento narcisistico, molto spento e devitalizzato, desiderio di autonomia ed esplorazione, la procedura interiorizzata è: “Se mi espongo gli altri mi scoraggiano o ci rimangono male, quindi mi vedo bloccato, non supportato e provo un senso di oppressione e di colpa”. Le conseguenze (coping strutturatisi negli anni) sono il ritiro sociale e il dismissing. Esordisce dicendo che ha sempre pensato che lo psicologo che lo avrebbe preso in trattamento sarebbe dovuto andare anche lui dallo psicologo. Gli rispondo ironicamente che ci vado già da anni e lui mi sorride sorpreso. Parliamo del più e del meno e mi dice che guarda spesso in TV “Quattro Ristoranti”, con lo chef Alessandro Borghese. Lo lascio parlare ma mentre ascolto ho un desiderio forte di condividere con lui che a me piace tantissimo “Quattro Hotel” con Bruno Barbieri, sento l’impulso come quando a scuola la prof interroga un tuo amico, sai la risposta benissimo e la vorresti dire. Mi inserisco in una pausa, faccio questo piccolo autosvelamento e lui per mezzo secondo si illumina, mi rivela che in effetto lo preferisce a “Quattro Ristoranti” e ci rammarichiamo assieme del fatto che è finito. Commentiamo qualche puntata e gli faccio notare questo suo stralcio di rivitalizzazione, lo cogliamo e lo fissiamo e per un attimo ne rimane sorpreso. Ecco, questa è un cellula di cambiamento. Io ho sentito quello che sentiva lui, basandomi su quello che avevo dentro io, condividendolo, lui si è reso conto di questo aspetto vitale di se, sempre scoraggiato o ignorato da se stesso e/o dagli altri. Poi ovviamente ritorna al suo coping di chiusura e inibizione emotiva, non batte più ciglio al riguardo, nonostante fosse una delle sue trasmissioni preferite. Gli faccio notare questo suo cambiamento di stato e quasi si pietrifica, vorrei fargli notare anche questo ma per adesso preferisco non insistere, come primo colloquio va già bene così.
Paola ha 25 anni, schema borderline–dipendente: desidero cure, riconoscimento identitario, essere vista nella mia esistenzialità, l’altro mi rifiuta, non mi considera o è ambivalente, quando ciò accade avverto un vuoto indescrivibile e mi sento sprofondare, scomparire. Mi racconta che durante una vacanza con il suo ragazzo, lei parlava entusiasta di ciò che stavano vedendo (un monumento), si gira verso di lui e il suo volto è perso nel nulla, non la stava ascoltando, non ricordava nemmeno cosa lei aveva appena detto, litigata davanti al monumento. Mi dice che si è sentita insignificante, invisibile, come Amelie Poulain in una scena del film, nel bar, in cui lei si liquefa quando il suo corteggiatore non la nota proprio. Piange a singulti. La capisco, ma qui per un motivo diverso, stavolta mi identifico con il comportamento invalidante del suo ragazzo, riconosco le volte che capita anche a me di metterlo in atto involontariamente con mia moglie o con i miei figli, perché magari penso al lavoro, a qualche articolo (anche a questo) o ad altro. Ecco, davanti a me, ho la conseguenza reale di come ci si può sentire in certi momenti. Stavolta è il mio senso di colpa ad avvicinarmi a lei, mi sintonizzo con lei grazie a questo. Oltretutto, lo stato doloroso della paziente mi fornisce un’occasione preziosissima per incrementare la mia di autoriflessività riguardo questo mio modo di fare (spero raro) con la mia famiglia o i miei cari. Quante cose possono insegnarci i pazienti se stiamo un poco attenti.
Un paziente con schema
evitante, Davide 35 anni, ha uno stile di vita solitario e ritirato, mi fa tanta tristezza. Ricordo un periodo preadolescenziale in cui litigai con un amico caro e per settimane non volli frequentare nessuno, era anche estate, ero proprio depresso. Parliamo di musica, mi dice che gli piace il rock e dei gruppi musicali che nessuno ascolta. Spesso va ai concerti da solo. Lo dice alzando il capo diagonalmente e socchiudendo gli occhi, in questo gesto di mezzo secondo ci sono 35 anni di invalidazione, dalla famiglia, dagli amici o chissà da chi. Mi vengono in mente le volte in cui sono stato criticato o preso in giro per i miei gusti musicali (e non solo) e rivivo quelle emozioni di vergogna, umiliazione e tristezza, forse le stesse che prova lui in quel gesto che ha fatto. Gli dico che capitava anche a me quando ero metallaro, capellone e giravo in pantacollant, gli racconto che oscillavo continuamente tra vergogna, paura dell’umiliazione e rabbia.
Rabbia perché a me la mia musica piaceva, mi fa e mi faceva stare bene e loro non avevano il diritto di giudicare. In quel momento sorride un pochino e mi dice che capita anche a lui di provare
emozioni simili, riconosce la
vergogna del vedersi diverso, strano, manchevole rispetto agli altri, gli è capitato tantissime volte. Abbassa il capo e le spalle, in quel gesto rivedo le tante volte in cui io non mi sono sentito accettato e capito, non solo per la mia musica ma anche per altri motivi. Gli dico che in casi del genere io mi sentivo anche un po’ triste, riconosce in lui la tristezza, e il fatto che spesso si è sentito solo ed escluso dagli altri. Continuiamo a parlare di musica, mi cita i Green Day, non è il mio genere ma conosco bene un paio di dischi: “Dookie” e “American Idiot”. Gliene parlo, ci confrontiamo su alcuni brani e questi due dischi, lui non si smuove molto ma si vitalizza un pochino quando mi dice che effettivamente dopo “American Idiot” non hanno fatto più album decenti. Bene, ci siamo, stiamo in un rally, io pilota e lui navigatore o viceversa, siamo in fuga.
Schema narcisistico, Matteo ha 50 anni, mi dice che gli piace il cinema, ma non i soliti film di Hollywood o le commedie italiane attuali. Con tono sprezzante e un po’ altezzoso dice: “Mi piacciono quei film introspettivi indipendenti americani”. E qui sento un subbuglio nello stomaco, quante volte mi è capitato di soffermarmi su film intensissimi sconosciuti facendo zapping in TV, il cinema realista indipendente americano degli ultimi 20 anni. Quello che va da “Buffalo ’66” al Sundance Festival per intenderci (anche se ormai Hollywood ci ha messo il naso sopra), molti non sono veramente indie, ma di certo lontani dal mainstream. Dice: “Mi piacciono quei film in cui non succede niente ma succede tutto, dove non c’è morale, catarsi o soluzione, non ci sono messaggi sentimentali o pipponi intellettuali ma solo descrizioni di personaggi che si muovono sulla scena, senza alcuna differenza tra noi spettatori e loro, ad esempio…”. Rimango a bocca aperta e col respiro sospeso, due film mi ronzano in testa, aspetto col fiato bloccato e una linea di tensione che mi sale dalla pancia alla gola, come quando flirti la prima volta con una che ti piace. Attendo che faccia lui la prima mossa. Fuori i titoli: “Tre manifesti a Ebbing” e “Manchester by the sea”. Sono gli stessi che avevo io in testa. Mi commuovo (sul serio), vorrei abbracciarlo, mantengo contegno, ma condivido con lui il mio entusiasmo per questi film. Ripenso a come mi sono sentito mentre guardavo questi film, condividiamo emozioni e sensazioni e scopriamo che sono molto simili. Non è più borioso e antipatico adesso, gli faccio notare che lo vedo più rilassato, lui si sorprende e mi dice che è vero, si sente capito, per un attimo non ha avuto bisogno di proteggersi e di mostrarsi superiore agli altri, siamo due bambini in spiaggia a giocare con la sabbia.
Giovanni ha 25 anni, lo schema è il seguente: ho un desiderio di autonomia ma se faccio quello che veramente mi piace e vorrei fare gli altri ci rimangono male, saranno delusi da me e li faccio soffrire. Questo mi fa sentire molto in colpa e provo anche vergogna. Lavora 12 ore al giorno in un ambito che non gli piace. “Si Doc, se mi vado a prendere un caffè al bar con gli amici o dormo fino a tardi anche se è domenica, mi sento in colpa”. Ricordo qualche episodio in cui mi sono sentito anche io così, quasi come se potessi in qualche modo danneggiare i miei cari, farli soffrire o apparire ai loro occhi come un irresponsabile, la pecora nera della famiglia. Immagini dolorose di me che tentavo in tutti i modi di tenere lontane, anche se non vere, anche sacrificando la mia autonomia, anche se era estate e sarei voluto andare al mare con i miei amici ma i miei genitori volevano che lavorassi per guadagnare qualcosa, che i soldi non bastavano mai e la scuola costava. Certo che lo capisco. Lui continua a parlare, mentre io navigo nei miei ricordi con tristezza: “Mi vedo come un debosciato, un parassita, come…”. Indovinate chi mi cita? Mentre lui parla io già me lo rappresento in vestaglia, White Russian e capelli inzevati: “Il grande Lebowsky”, dice lui, io da sopra a lui: “Il drugo!!!”. Ed entrambi ridiamo mentre i nostri corpi si rilassano, la postura diventa morbida e ci sentiamo e posizioniamo più vicini. Commentiamo qualche scena del film. Io ho un piacevole calore alla pancia, siamo quasi commossi ma contenti.
Con Morgan (27 anni) dopo 20 interminabili minuti di seduta non succede niente, ma proprio nulla. L’atmosfera è grigia, i suoi occhi sono inespressivi e il volto è piatto. E’ chiuso in un mutismo coartato, io comincio a dissociare, mi perdo nei suoi occhi e la stanza gira, ho anche freddo. C’era un mio ex datore di lavoro con cui mi sentivo così, lo ricordo bene. Solo la sua presenza, mi faceva sentire giudicato e minacciato nel mio valore, anzi peggio, proprio come se non esistessi, forse così si sente Morgan con me adesso. Ha ragione a essere coartato, lo potrei umiliare, schiacciare o fargli del male. Ritorno in me, gli dico che ho un po’ freddo e che mi sembra che entrambi stiamo congelando, lui annuisce e dice che è vero, gli dico che deve essere molto “fastidioso” trovarsi in una stanza con una persona e provare sensazioni simili. Gli chiedo se gli è capitato altre volte, mi risponde freddo: “Ogni giorno”, e colgo un velo di tristezza nella sua voce. “Non deve essere per niente bello vero?” gli dico con voce calda. E lui: “E no…”. Lo sento molto più vicino adesso. Gli propongo di uscire da questo stato, è un bravo chitarrista, io un discreto tastierista, ho gli strumenti in sala d’aspetto. Che cosa stiamo aspettando? Dopo 3 minuti di musica la stanza è colorata e il calore avvolge entrambi.
Pazientina psicotica, Clara 20 anni, nonostante il disturbo piuttosto serio (ha spesso delle crisi di angoscia molto intense e dolorose) è una tipa molto fashion, legata alle frivolezze estetiche e ai dettami della moda. Truccata in modo abbondante, abiti e abbinamenti scelti con cura, microgonna e scollatura stile “femme fatale” o “Amici di Maria”, borsa che costa uno stipendio statale e risatine incontrollate a profusione. Io ultraquarantenne cerebrale, con pancia e calvizie avanzata, vestito alla meno peggio. Cosa possiamo mai condividere? Dove ci sintonizziamo? E invece cominciamo a ridere e a scherzare su quanto sono buffi e rompiscatole i bambini, raccontiamo aneddoti e scenette, lei dei suoi nipotini, io dei miei figli. Ridiamo di gusto per un buon quarto d’ora. Mette la mano davanti alla bocca e le lacrime, stavolta di riso, la struccano un poco, si è scomposta ma è contenta, come raramente forse le accade.
Ecco, tutto questo è per me “sintonizzazione” e perché è fondamentale per una buona terapia. Almeno per adesso, meglio non so descriverla.
(Grazie a G. Salvatore per i preziosi spunti e suggerimenti)