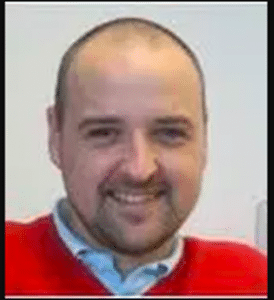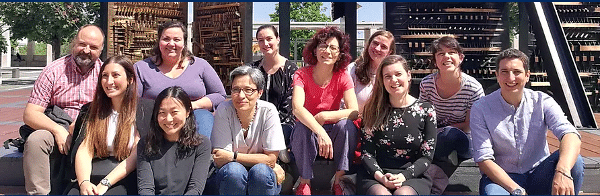I bias cognitivi rivolti alle policy del nudging
Tradizionalmente, per indurre un cambiamento comportamentale a livello individuale e collettivo, la scatola degli attrezzi dei policy-makers è dotata in primis di divieti, obblighi, sussidi, sanzioni, tassazione, politica dei prezzi. Grazie alla sostituzione di tali attrezzi – in parte obsoleti e non più competitivi nel costo – con altri di nuova generazione, si sta implementando in modo crescente il nudging.
E’ una policy di soft power per scoraggiare un’azione o il consumo di un bene/servizio (demerit good) – ovvero incoraggiarne altri (merit goods); in più, è una policy low cost fondata sulla moral suasion. E in tempi di conti pubblici critici, tale requisito non è di poco momento.
La celeberrima immagine è quella dell’animale adulto che dà una piccola spinta al cucciolo per aiutarlo a superare un ostacolo o a buttarsi in un’esperienza che lo spaventa, ma che lo premia nel lungo periodo per la sua stessa sopravvivenza.
La teoria del nudge di Thaler (Nobel per l’Economia nel 2017) ha contribuito al consolidarsi dell’economia comportamentale e a utilizzarla nell’analisi e valutazione delle politiche pubbliche. La batteria di strumenti comprende: i bias cognitivi – tra cui il framing effect – e la moral suasion, che sopperiscono alla mancanza di volontà dell’individuo, spesso inducendolo a scelte miopi di appagamento immediato a scapito di quelle (più costose) lungimiranti di lungo periodo.
Numerosi paesi infatti sfruttano positivamente taluni errori sistematici, persuadendo e incoraggiando tramite piccole, ma efficaci ‘spinte gentili’ (nudging), i soggetti verso comportamenti virtuosi sul piano individuale e per la collettività.
Anche il settore privato (ad esempio nel marketing) si avvale del nudging con successo.
La fortuna dello sviluppo delle politiche di nudge è collegata essenzialmente ad almeno tre circostanze: i) l’idea che noi siamo ‘Uomini’ e non ‘Econi’ (Thaler, Sunstein): soggetti fallaci, che si confondono, si contraddicono, dimenticano, le cui previsioni sono per lo più imprecise e distorte. Niente a che fare con l’onniscente e ottimizzante homo oeconomicus (l’Econe); ii) nel 2010, in UK, viene costituita un’unità di ricerca, il Behavioural Insight Team, volta ad attuare, validare e adattare politiche pubbliche basate sul nudging; iii) Sunstein, professore alla Harvard Law School di Economia comportamentale (applicazione dei concetti di psicologia cognitiva alla comprensione delle decisioni economiche), viene nominato dal Presidente Obama capo dell’Ufficio dell’Informazione e delle Regole. Secondo la sua linea, un governo otterrebbe buoni risultati ‘sospingendo’, suggerendo, più che imponendo. Le regole devono diventare l’opzione naturale per una collettività che le sceglie in quanto ritenute migliori e senza che ciò pregiudichi le libertà di scelta.
La filosofia su cui si fonda tale policy è il ‘paternalismo libertario’ di Thaler e Sunstein. Benché libertarismo e paternalismo siano ossimori (Sunstein e Thaler, 2003b), gli autori del nudging, Thaler e Sunstein, creano un ponte tra queste due sponde (Sunstein e Thaler, 2003a): da un lato, ‘paternalisticamente’, si decide che una scelta o un comportamento sia migliore per i singoli e per la collettività – tutelare la salute fisica, l’ambiente, risparmiare per la pensione, ecc. – e dall’altra, non si introducono obblighi né divieti. Se da una parte si spingono le persone a preferire le scelte migliori per loro, allo stesso tempo si lasciano inalterate tutte le opzioni loro possibili (da cui l’aggettivo ‘libertario’). Una leggera spinta verso un comportamento più virtuoso a beneficio dell’individuo e della società può mai essere etichettato pregiudizievole della libertà individuale? Una leggera modifica dell’architettura della scelta, infatti, non è equiparabile a una limitazione della libertà: il soggetto è stimolato a imboccare pattern decisionali che altrimenti avrebbe ignorato per i naturali limiti della razionalità, soprattutto quando si trova a operare in condizioni di incertezza.
Il ragionamento è soggetto a confusioni, cantonate – la maggior parte delle quali rientrano nell’ampia categoria dei bias cognitivi e a naïves semplificazioni. Basti pensare al mental accounting, termine coniato da Thaler per indicare che nella mente non tutti i soldi sono uguali e, di conseguenza, vengono posti in appositi cassetti mentali che aiutano il soggetto a decidere su come allocarli (nel cassetto A si trovano quelli destinati al ménage familiare, in quello B all’istruzione dei figli, nel D vanno quelli per il tempo libero, nel cassetto E i risparmi che si accumulano nel tempo, ecc.).
Ma non è solo la razionalità a essere limitata; lo è anche la volontà, pure nella capacità di autocontrollo. Nelle scelte intertemporali, miopi sul breve periodo vs quelle ottimizzanti di lungo periodo, l’individuo è portato a cedere al canto delle Sirene piuttosto che a essere un pianificatore lungimirante che fa rotta verso la strada di casa (Elstern, 2005).
A tale mix di cedimenti sia nella razionalità sia nella volontà un supporto viene appunto dal nudging. Uno dei temi più cari alla teoria dei nudge è l’opzione di default. Tali opzioni costituiscono scelte predefinite che divengono effettive quando il decision-maker non intraprende azioni per cambiarle. Consiste, quindi, nell’abilità dell’architetto strutturare una situazione o una modalità di vendita di un prodotto/servizio perché l’individuo privilegi la situazione di base senza che senta la necessità di scegliere e fare cambiamenti (status quo bias). Sulla base di tale bias, la strategia degli individui è ‘scegliere di non scegliere’. La situazione attuale viene presa come punto di riferimento (focal point), e qualsiasi mutamento (opt-out) viene considerato una perdita (di varia natura: costi fisici, cognitivi, di tempo, emotivi, ecc.).
Johnson e Goldstein hanno osservato le percentuali di donatori di organi nei paesi europei, rispetto alla popolazione, enucleando due categorie di paesi: uno – che sembrerebbe molto generoso – dove la quasi totalità dei cittadini è donatrice e un secondo – apparentemente più egoista – in cui, invece, i valori sono molto più bassi. Gli studiosi sono arrivati alla conclusione che l’architettura di un programma di policy riesce a dirigere le scelte di massa a beneficio dell’intera collettività e a gratificare (attraverso il rilascio di dopamina) il singolo donatore, con l’atto del futuro dono. L’architettura della scelta diventa quindi dirimente per la sanità pubblica e per il numero di vite salvate tramite trapianto di organi.
L’opzione di default è l’opzione di partenza e, quindi, la modalità in cui la donazione degli organi è strutturata. Nel gruppo dei paesi con i tassi più alti (l’Austria con il 99% della popolazione), l’opzione di default è quella del silenzio-assenso per cui si è automaticamente donatori e, in vita, si può semmai esprimere la volontà di uscire dal programma (sistema opt-out).
Nei paesi con i tassi più bassi (come la Germania, con il 12 per cento), invece, l’opzione di default è non donare, a meno che in vita si decida di aderire al programma di donazione (sistema opt-in).
La libertà è garantita in entrambe le situazioni, ma il risultato, di fatto, dipende da quale è l’opzione di default. In entrambi i casi la popolazione si appiattisce allo status quo (status quo bias), e quindi al default bias (le persone replicano le scelte passate, si comportano allo stesso modo e vengono prese dalla pigrizia persino quando le circostanze richiederebbero un cambiamento). Si può allora sfruttare in maniera strategica la tendenza al default, avvalendosi dell’umana e generalizzata tendenza a evitare scelte impegnative e pensieri spiacevoli; a risparmiare energia, all’inerzia. Di fatto, quando sono indecise, le persone aderiscono a quanto fanno gli altri (effetto gregge) o, semplicemente, a non far nulla.
Istituti finanziari del nord Europa hanno impostato i clienti come investitori etici. Se qualcuno desidera sottoscrivere fondi non etici, deve firmare una specifica lettera. In pratica, puntano sulla pigrizia dell’utente.
Il Massachusetts General Hospital, per migliorare la salute dei propri dipendenti, ha usato due accorgimenti presso la mensa: evidenziare con un segnale tipo semaforo il livello di benessere dei cibi in vendita (verde per le insalate, rosso per gli hamburger); mettere ad altezza occhi i cibi più salutari e abbassare il junk food. In due anni, secondo i dati della ricerca, vi è stato un calo del 39% nel consumo di cibo spazzatura.
In UK le utilities di luce e gas hanno inviato ai clienti lettere con frasi del tipo: 9 persone su 10 nel tuo quartiere pagano la bolletta con regolarità; il consumo della tua abitazione è superiore alla media del tuo vicinato. La ricerca dimostra che chi ha ricevuto simili pungoli ha pagato più velocemente il debito e ridotto il consumo elettrico.
Anche in questi due ultimi esempi è bastato cambiare il frame per ottenere risultati efficaci.
Altro esempio di nudging è ispirato alla Fun Theory (something as simple as fun is the easiest way to change people’s behaviour for the better). Per il loro interesse – fare moto – si invoglia all’azione le persone, vincendo la loro naturale pigrizia, puntando sul divertimento. A Stoccolma, nella metropolitana di Odenplan, proprio accanto alla scala mobile, è stata creata una bellissima scala dove i gradini sono configurati e disegnati come la tastiera di un pianoforte e i gradini, calpestandoli, emettono ciascuno una nota di pianoforte (Piano Stairs).
Tuttavia, le contestazioni sulle politiche pubbliche basate sul nudging non hanno tardato: il conduttore tv ultraconservatore Glenn Beck ha etichettato Sunstein l’’uomo più pericoloso d’America’: i suoi ‘buoni consigli’ sono una limitazione delle libertà individuali. Sugden ha criticato l’uso del nudging per le politiche pubbliche perché in qualche modo avalla e sfrutta i bias stessi e le ‘cascate informative’, processi per cui le scelte errate compiute da alcuni in anticipo, inducono altri soggetti a trascurare le proprie informazioni e valutazioni in base all’ipotesi che coloro che hanno deciso per primi, erano consapevoli di cosa stessero facendo. Oppure, un individuo che decide in ritardo tenta di evitare le conseguenze sulla propria reputazione dovute a scelte contrastanti da quella modale. Si tratta insomma di un effetto gregge che amplifica e rende collettivi i bias cognitivi. Perciò, le politiche di nudging possono finanche amplificare gli errori cognitivi compiuti da altri, lavorando contro altre importanti politiche, tipicamente di debiasing. Il ‘paternalismo liberale’ – con i suoi escamotage – rischia di trasformarsi in un sottile metodo di controllo intrusivo – e persino manipolatorio – della sfera economica nella libertà del cittadino di decidere cosa sia davvero meglio per sé.
Forse, più che di ‘pungoli’, ci sarebbe bisogno di porre le persone nelle condizioni di scegliere consapevolmente, sollecitando quello che Kahneman definisce ‘pensiero lento’, ossia il sistema di pensiero riflessivo, intenzionale e logico, che secondo gli esperimenti verrebbe attivato quando l’individuo pone attenzione, le/gli vengono forniti più elementi di giudizio e tempo sufficiente per operare la scelta.
Al di là del dibattito sul ruolo della libertà del cittadino, l’applicazione e la diffusione del nudge costituiscono una innovazione forte di evidence based policy, cioè del ricorso a policy validate empiricamente con approcci rigorosi.