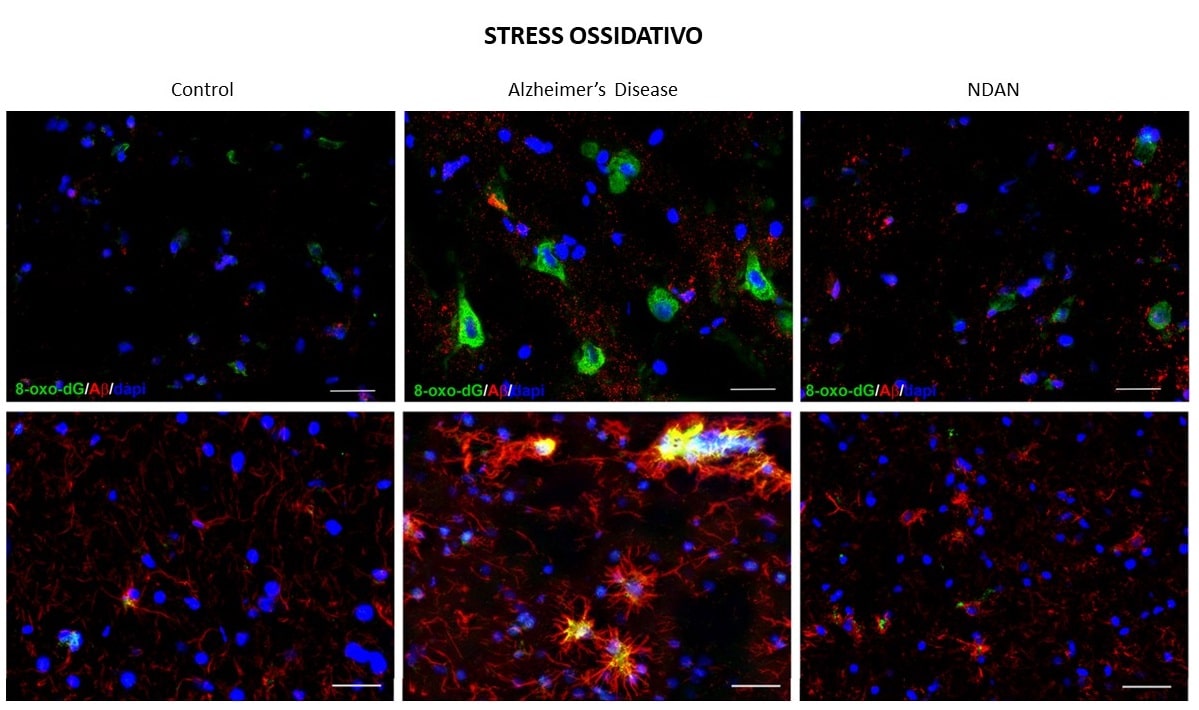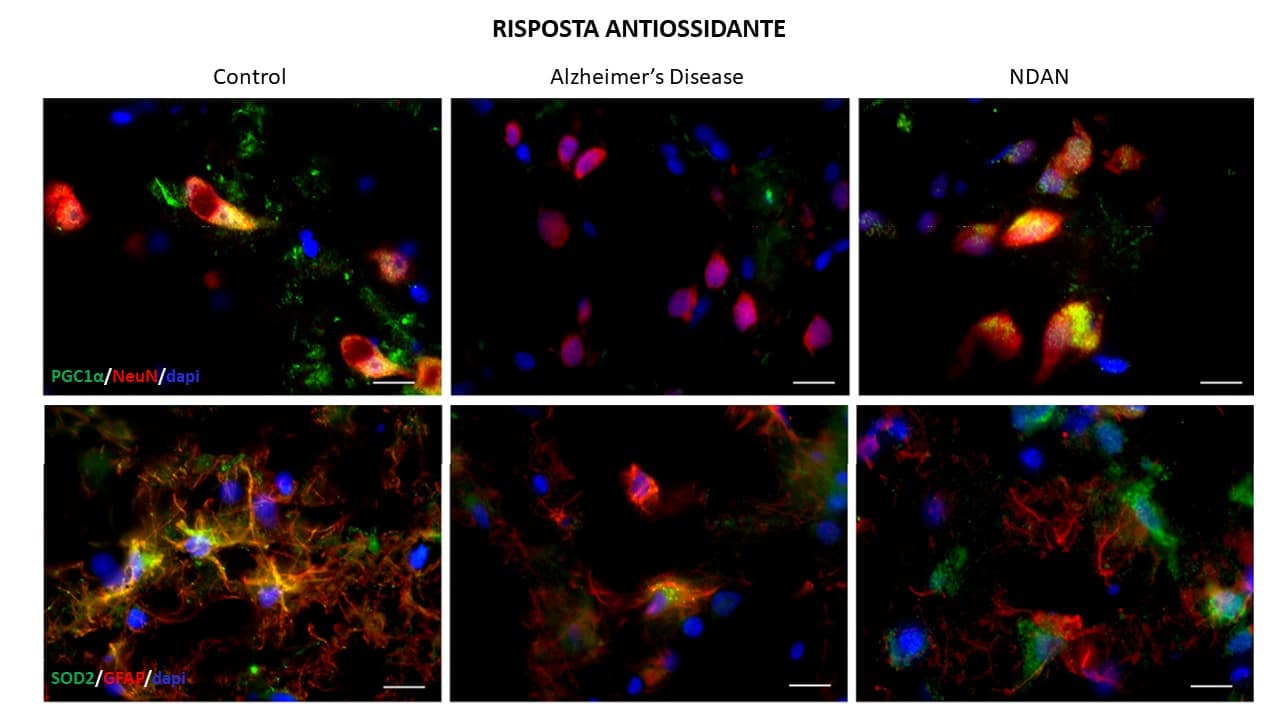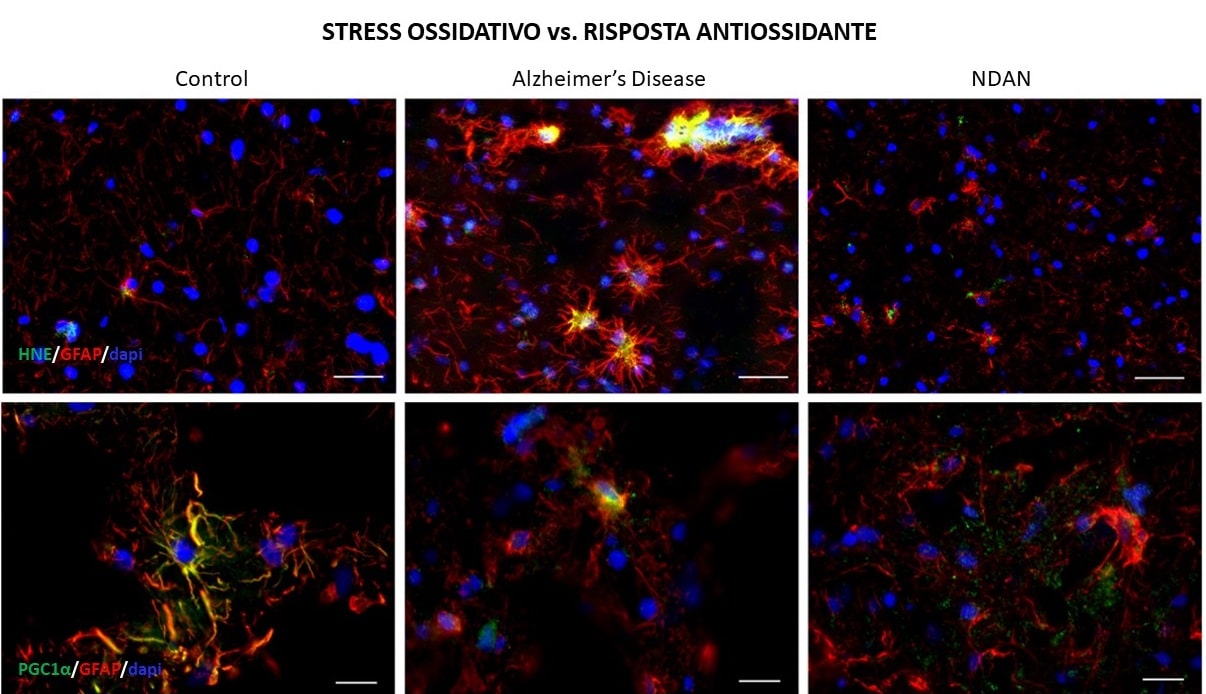La comunicazione degli occhi
Artisti e filosofi si sono spesso soffermati sulla comunicazione che avviene attraverso gli occhi, sulle informazioni riguardo alla persona che questi trasmettono, oltre che sui suoi pensieri e sulle sensazioni, fino a giungere alla conclusione che gli occhi sono lo specchio dell’anima.
Gli occhi riflettono il mondo interiore della persona e, a volte senza volerlo, questa ci dice molto di più quando guarda che quando parla. Così, spesso ci troviamo a cercare lo sguardo dell’altro per capire se quella che esprime è reale gioia,
tristezza o
paura, o per scorgere una menzogna ben mascherata con le parole giuste.
Molti ricercatori si sono per questo soffermati sulla comunicazione degli occhi, dimostrando come le loro caratteristiche, o meglio le variazioni di queste, diano a chi li guarda importanti informazioni circa la salute, l’eccitazione, le emozioni che il soggetto sta provando, oltre a generare una maggiore o minore attrazione sessuale nell’osservatore.
Nell’esperimento di Caryl, fatto nel 2009, il ricercatore si è soffermato sulle preferenze che gli uomini e le donne hanno verso la dimensione delle pupille di persone del sesso opposto. Questo lavoro infatti parte dalle indicazioni emerse in esperimenti e studi precedenti, come quello di Hess (1965), il quale dimostrò che gli uomini trovavano le fotografie delle donne più attraenti se le pupille delle stesse venivano ritoccate per sembrare più grandi.
Autori come Tombs e Silverman (2004) hanno confermato tale tendenza, mostrando tuttavia come la stessa generalizzazione non poteva essere fatta per quanto riguarda le preferenze delle donne. In quest’ultimo caso, difatti, la situazione appariva più complessa in quanto chiamava in ballo altre variabili che potevano orientare la scelta delle donne per un viso o per un altro.
In due esperimenti Tombs e Silverman notarono che le donne tendevano a preferire visi di uomini con una dimensione media delle pupille. Questi infatti arrivarono ad ipotizzare che una maggiore grandezza delle pupille indicava livelli di arousal maggiori a livello sessuale, e che quindi tale caratteristica fosse interpretata dalle donne come il segnale di un uomo tendenzialmente possessivo, geloso o promiscuo. Qualche donna appariva fortemente attratta dall’ampiezza delle pupille dei visi presentati nell’esperimento, dichiarando inoltre di preferire il genere di uomo che stereotipicamente veniva definito nelle relazioni sentimentali come ‘bad boy’.
Da questo esperimento i ricercatori conclusero che il giudizio delle donne non era semplicemente mediato dalle caratteristiche fisiche degli stimoli, in questo caso la grandezza delle pupille, ma anche da circostanze transitorie e dall’orientamento socio-sessuale. Come emerso in questa e in altre ricerche (Simpson & Gangestad, 1991; Caryl, 2009) le donne sembrano reagire alla grandezza delle pupille degli uomini come se queste corrispondessero ad un’alta qualità della relazione.
Nell’esperimento di Caryl, rimanendo in tema del giudizio delle donne in base alla grandezza delle pupille, si è voluto indagare su quanto le loro scelte fossero influenzate dalle variazioni dei livelli di fertilità, dallo status relazionale e dall’orientamento socio-sessuale delle stesse.
Partendo dai lavori che dimostrano come la donna nel periodo di maggiore fertilità del ciclo mestruale preferisca nell’uomo alcune caratteristiche piuttosto che altre, come i tratti del viso più mascolini (Penton-Voak et al., 1999; Roney & Simmons, 2008; Welling et al., 2007) e un tono della voce più profondo (Feinberg et al., 2006; Puts, 2005), mentre nei periodi di minore fertilità sia più incline verso caratteristiche quali la salute e l’affinità, sono state misurate le oscillazioni delle preferenze delle donne in merito all’ampiezza delle pupille in base al ciclo mestruale. Le preferenze appena elencate, analizzate nel periodo di massima fertilità della donna, sono state indicate come criteri che designano, a livello adattivo, il maschio con migliori geni (Garver-Apgar, Gangestad, & Thornhill, 2008; Waynforth, Delwadia, & Camm, 2005). Questo esperimento voleva così osservare se anche la grandezza delle pupille fosse una caratteristica sensibile alla variazione della fertilità nella donna.
Ciò che è emerso è interessante, in quanto è stato osservato che durante la fase follicolare, che va dal sesto al quattordicesimo giorno del ciclo mestruale e rappresenta il periodo di massima fertilità, le donne del campione tendevano ad avere un maggiore incremento dell’indice LPP (preferenza per pupille grandi). Tale risultato era ancora più evidente tra le donne impegnate in una relazione sentimentale, rispetto a quelle single. Nelle prime sembra infatti che le variabili di fertilità abbiano un impatto significativo sull’indice LPP, mentre nelle donne single ad avere un impatto maggiore sull’indice LPP è il loro orientamento socio-sessuale e non il loro livello di fertilità. Le donne che invece assumevano contraccettivi ormonali non mostravano alcuna variazione di preferenza per la grandezza delle pupille nelle diverse fasi del ciclo mestruale.
Tale risultato sembra andare nella direzione della mixed mating strategy, secondo la quale le donne per ragioni adattive tenderebbero ad adottare una strategia mista che permetta loro di generare una prole con i geni migliori e nello stesso tempo poter contare sulla protezione di una relazione stabile. Secondo tale teoria infatti la donna con un partner può voler ricercare rapporti occasionali al di fuori della coppia con uomini migliori del proprio partner per migliorare le caratteristiche della prole, pur conservando la relazione con l’uomo più adatto a crescerla (Thornhill & Gangestad, 2003). Tale teoria sembra supportata dal fatto che, come quest’esperimento ci dimostra, le donne impegnate in relazioni durature mostrano una maggiore oscillazione nella preferenza dei criteri di buoni geni precedentemente esposti, se confrontate con donne single (Havlicek, Roberts, & Flegr, 2005).
Ma non è solo l’ampiezza della pupilla ad aver richiamato l’attenzione nell’ambito della ricerca. Ricercatori come Provine (2011) si sono focalizzati sul giudizio che le persone davano ai visi delle persone che riportavano una sclera, la parte bianca dell’occhio che circonda l’iride, rossa o arrossata.
Gli occhi rossi sono principalmente il risultato di una dilatazione dei vasi sanguigni superficiali della congiuntiva, la membrana trasparente che protegge la sclera. Gli occhi rossi sono un sintomo facilmente visibile e possono essere legati ad un ampio ventaglio di patologie, che va da quelle più leggere quali irritazione, congiuntivite, a disturbi più gravi, includendo anche l’effetto da uso di sostanze stupefacenti quali ad esempio la marijuana (McLane & Carroll 1986).
L’esperimento di Provine ha cercato di capire come le persone con gli occhi arrossati venivano percepite dagli altri. In linea con precedenti lavori scientifici, i quali dimostravano come gli occhi con una sclera bianca fossero associati a criteri di bellezza e sinonimo di salute (Symons 1979; Etcoff 1999; Thornhill & Gangestad 1999; Langlois et al. 2000; Sugiyama 2005; Johnston 2006; Rhodes 2006; Little et al. 2007), Provine ha dimostrato che i visi con gli occhi rossi, presentati durante l’esperimento, erano associati sia da donne che da uomini a peggiori livelli di salute e ad emozioni negative, specialmente alla tristezza. Mentre tali risultati sono emersi in egual misura sia nel campione composto dalle donne, sia in quello degli uomini, questi due gruppi tendevano a differire sul discorso dell’attrazione. Se si può notare una significativa correlazione tra visi con gli occhi rossi e bassa attrazione da parte delle donne, questa correlazione, seppur presente, appariva assai più debole nei giudizi degli uomini.
Se consideriamo inoltre che gli occhi con una sclera bianca, oltre a funzionare come criteri di salute, sono anche associati alla giovinezza, in quanto l’invecchiamento comporta, tra le altre cose, anche l’ingiallimento della sclera (Broekhuyse 1975; Watson & Young 2004), ci appare abbastanza evidente come le persone possano esprimere la loro preferenza verso visi che riportano un colorito più bianco della sclera.
A conferma del fatto che gli studi rivolti alla comunicazione e al grado di preferibilità che le persone hanno verso gli occhi degli altri si siano focalizzati sulla totalità delle componenti manifeste di questa parte del corpo, vediamo come autori come Peshek (2011) e Brown e colleghi (2017) abbiano dedicato i loro studi all’anello limbale. L’anello limbale è quel cerchio scuro che si trova intorno all’iride e ne disegna i confini. Questo può essere poco distinguibile nelle persone con gli occhi scuri, in quanto tende a confondersi con l’iride, ma è facilmente visibile nelle persone con gli occhi più chiari.
L’esperimento di Peshek ha dimostrato che solitamente, anche se a volte in modo automatico, le persone, se messe di fronte ad immagini di visi, tendano a preferire quelli che riportano un anello limbale più scuro e definito rispetto agli stessi visi a cui era stato alterato il colore dello stesso verso tonalità più uniformi all’iride.
Anche Brown (2017) ha voluto vedere l’effetto che un’alterazione della tonalità dell’anello limbale poteva provocare nella percezione e nel giudizio dei rispondenti; in questo caso è stato preso un campione di 150 persone. Oltre ad esserci la stessa generale tendenza nei partecipanti a preferire visi con un anello limbale più scuro, è emerso che le persone facevano corrispondere tale caratteristica alla salute.
Tuttavia vi sono state delle variazioni in base al genere dei rispondenti: le donne sembravano infatti quelle più influenzate da tale caratteristica, mentre gli uomini difficilmente sembravano dare la stessa attenzione nel loro giudizio. Interessante è il fatto che le donne più interessate ad una relazione breve e occasionale tendevano a giudicare i visi degli uomini con un anello limbale più scuro come più attraenti.
Ma qual è il motivo di tale preferenza?
Sembra che l’anello limbale sia collegato con la salute in quanto è stato studiato come questo tenda ad essere più scuro e definito nelle persone giovani (Peshek, 2013) ed in persone che hanno un cuore ed un sistema circolatorio sano. Un colore dell’anello limbale meno definito, o più simile se vogliamo al colore dell’iride, sembra essere associato, tra le altre cose, a bassi livelli di accumulazione di fosfolipidi, caratteristica connessa ai disturbi cardiovascolari in una persona (Ang et al., 2011; Fernandez et al., 2009).
Tutti questi esperimenti ci hanno mostrato che tutte le caratteristiche degli occhi che generalmente tendono ad essere associate a stati di salute migliore erano anche associati ad un grado di piacevolezza maggiore da parte dei partecipanti all’esperimento. Sebbene i gusti e le preferenze seguano sempre direzioni tanto soggettive quanto sociali, in base ai canoni di bellezza che una determinata società condivide in un determinato spazio e in un determinato tempo, sembra che la giovinezza e la salute siano criteri che non passano mai di moda, in quanto, a livello evolutivo, vengono associati ad una migliore fitness riproduttiva (Symons 1979, 1995; Etcoff 1999; Sugiyama 2005; Johnston 2006) e quindi tendono ad avere la precedenza tra le cose che soggettivamente si scelgono.