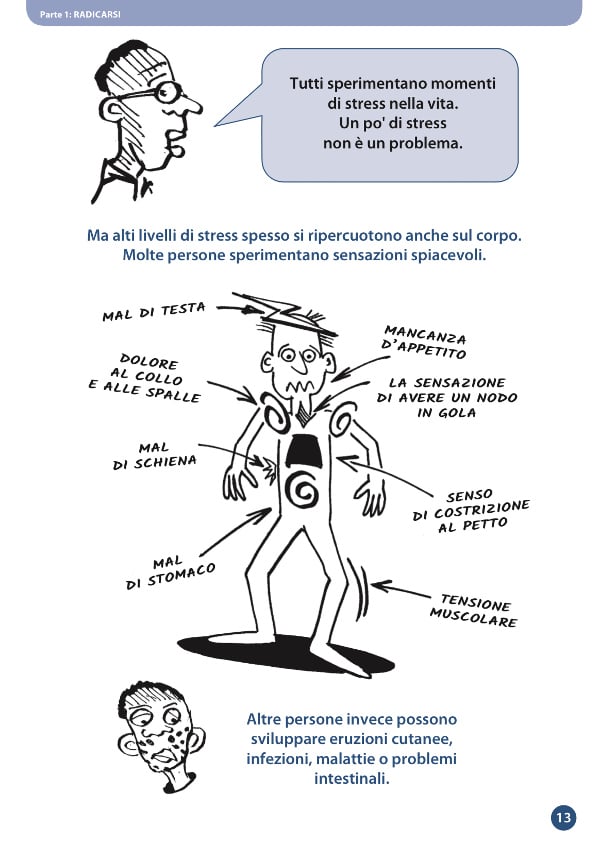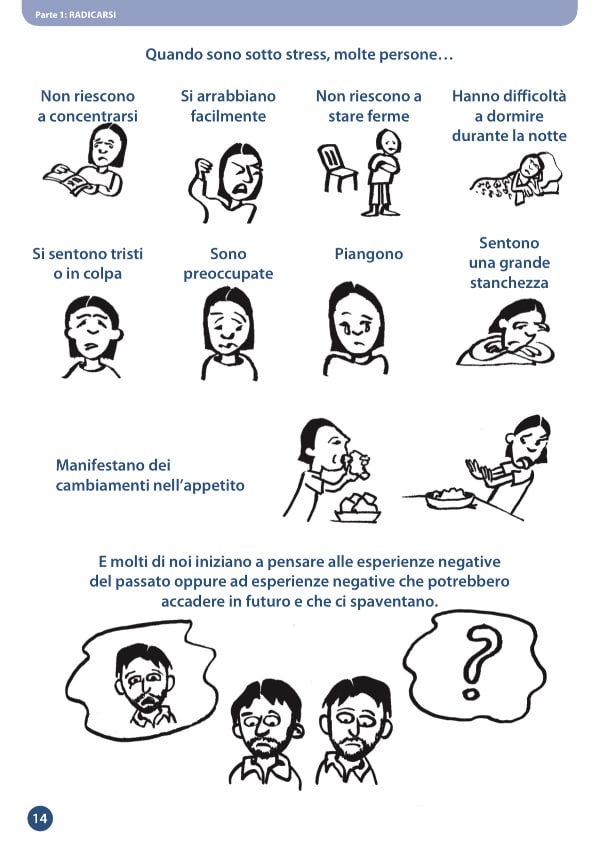La Terapia Metacognitiva (MCT) applicata al Disturbo da Stress Post traumatico
Prove preliminari da una serie di casi controllati, un trial non controllato e un trial pilota controllato e randomizzato (RCT) supportano l’efficacia potenziale della MCT nel trattamento del Disturbo da Stress Post-Traumatico (Wells & Colbear, 2012; Wells & Sembi, 2004b, Wells et al. 2008).
Elisa Petetta – OPEN SCHOOL Studi Cognitivi San Benedetto del Tronto
La caratteristica essenziale del disturbo da stress post-traumatico (DPTS) è lo sviluppo di sintomi tipici che seguono l’esposizione a uno o più eventi traumatici (DSM-5, American Psychiatric Association, 2013).
L’esposizione può essere diretta o indiretta attraverso l’esser venuti a conoscenza di un evento traumatico accaduto a un familiare o amico stretto, o attraverso l’esperienza ripetuta o estrema ai dettagli crudi dell’evento. Il DSM 5 distingue essenzialmente quattro domini per quanto riguarda il ventaglio della sintomatologia esperita individuando:
- sintomi di natura intrusiva (flashback, sogni, ricordi, immagini intrusive);
- sintomi di evitamento (di stimoli, persone, luoghi e situazioni connessi all’evento traumatico);
- sintomi cognitivi-affettivi (sentimenti di distacco verso gli altri, convinzioni negative su di sé, gli altri o il mondo, riduzioni di interessi o incapacità di provare emozioni positive);
- sintomi di iperarousal e reattività (ad esempio ipervigilanza, problemi di concentrazione e memoria o difficoltà relative al sonno).
La manifestazione clinica del DPTS è molto variabile, con individui in cui può essere predominante il rivivere con paura i sintomi emotivi e comportamentali, con alcuni che mostrano preminentemente sintomi di arousal e reattività, mentre in altri possono presentarsi anche sintomi dissociativi o varie combinazioni di questi pattern sintomatologici (DSM- 5, APA, 2013).
Nel panorama attuale per il trattamento del DPST ci sono alcuni interventi di comprovata efficacia.
Robuste evidenze empiriche sottolineano l’efficacia dell’esposizione, della terapia cognitiva focalizzata sul trauma e dell’eye-movement desensitation and re-processing (EMDR), (Bisson et al., 2007; Bradley, Greene, Russ, Dutra, &Wetsern, 2005). Questi ultimi rimangono i trattamenti di eccellenza raccomandati anche dalle linee guida Nice (National Institute of Clinical Excellence, 2005). Ognuno di questi approcci utilizza l’esposizione alle memorie traumatiche come una delle componenti principali all’interno dell’intervento. L’efficacia di questi trattamenti è supportata da un gran numero di studi che mostrano equivalenti livelli di esito senza evidenziare significative superiorità tra i diversi trattamenti (Bisson et al., 2007). Il trattamento erogato attraverso la procedura EMDR in particolare si basa sull’assunto che i sintomi esperiti dai soggetti con DPST siano causati da esperienze traumatiche memorizzate in maniera non elaborata, disconnessa dalle reti di memoria esistenti (Shapiro, 2001). Durante il trattamento EMDR al paziente viene chiesto di focalizzarsi sulle immagini, sulle cognizioni negative e sulle sensazioni corporee esperite connesse al trauma, e si concentra contemporaneamente sulla stimolazione bilaterale fisica operata dal terapeuta. L’ingrediente specifico dell’EMDR è costituito da movimenti oculari orizzontali che il paziente esegue seguendo il dito indice del terapeuta che si muove rapidamente da destra verso sinistra; i movimenti oculari guidati dal terapeuta faciliterebbero il processo cognitivo scatenato dal trauma e il corretto processamento delle memorie traumatiche nei circuiti neurali.
Sebbene l’importanza dei movimenti oculari bilaterali sia stato spesso evidenziata, esiste ancora una sostanziale controversia circa la sua specificità in termini di efficacia (Devilly, Ono, & Lohr, 2014; Lee & Cuijpers, 2013).
La terapia Metacognitiva (MCT; Wells, 2009) è uno tra i più recenti approcci al trattamento del DPST. L’obiettivo della MCT è quello di rimuovere quelle specifiche barriere che si contrappongono al processo di guarigione spontanea che occorre in seguito ad un evento traumatico. Il modello metacognitivo proposto da Adrian Wells si basa sull’assunto che i sintomi esperiti dai pazienti siano funzionali nel periodo immediatamente successivo all’evento traumatico. Sintomi come pensieri intrusivi, reattività eccessiva ed un generale incremento di arousal fanno parte di un processo interno di adattamento psicologico definito processo di adattamento riflessivo (RAP; Wells & Sembi, 2004a). Il RAP è responsabile della modificazione di cognizione e attenzione in modalità tali da sviluppare delle routines di controllo esecutivo per supportare l’implementazione di nuove strategie di coping.
Questo processo dovrebbe procedere normalmente senza ostacoli e l’individuo riuscirebbe a venir fuori dal ciclo dell’ansia mentre la cognizione torna a essere priva di quei meccanismi orientati al processamento della minaccia. Il modello metacognitivo di Wells si basa quindi sull’assunto che la maggior parte delle persone, a seguito di un evento traumatico, possieda la capacità di riadattarsi e, successivamente, non vada incontro allo sviluppo di particolari disturbi (Wells, 2009).
Questo processo di ‘guarigione spontanea’, tuttavia, può essere ostacolato o bloccato dall’attivazione di uno specifico stile di pensiero che conduce ad estendere oltre il processamento delle informazioni connesse al trauma e/o quelle di natura minacciosa. Questo stile cognitivo disfunzionale, definito sindrome cognitiva attenzionale (CAS), consiste in un pensiero ripetitivo che può assumere la forma di rimuginio e/o di ruminazione, perpetrati dal soggetto per cercare di trovare dei significati a quanto è accaduto, prevenire danni in futuro o colmare le lacune presenti nei ricordi. La CAS è costituita anche dal ‘monitoraggio della minaccia’, un processo di scannerizzazione dell’ambiente orientato alla ricerca di pericoli potenziali e finalizzato inoltre a cercare di rilevare, evitare o sopprimere pensieri ed emozioni disturbanti e angoscianti.
I sintomi del DPTS persisterebbero perché la CAS impedisce la flessibilità individuale verso stati di elaborazione privi di minaccia. In particolare a supporto di questo stile di pensiero ci sarebbero delle credenze metacognitive di natura positiva e negativa. Alcune meta credenze positive (ad es. ‘Analizzare i miei errori mi aiuterà a prevenire pericoli futuri’) supportano alcuni processi della CAS come il rimuginio, la ruminazione, il tentativo di colmare le lacune presenti nei ricordi e il monitoraggio della minaccia. Le meta credenze negative concernono l’incontrollabilità di alcuni processi di pensiero e il significato attribuito agli eventi cognitivi ( ad es. ‘Se continuo a pensare in questo modo potrei impazzire’), le quali contribuiscono alla percezione presente e futura della minaccia.
Il modello meta cognitivo applicato al DPTS suggerisce che il trattamento dovrebbe avere come obiettivo la destrutturazione della CAS (rimuginio, ruminazione e il monitoraggio della minaccia) e le meta credenze cognitive che sono a supporto di questi processi piuttosto che focalizzarsi sui contenuti delle memorie traumatiche o sull’utilizzo dell’esposizione prolungata col fine di rivivere gli episodi traumatici.
La MCT non impiega l’esposizione ai ricordi traumatici o la manipolazione delle immagini connesse al trauma né ha come obiettivo quello di disputare e ristrutturare i pensieri connessi all’evento. La MCT aiuta i pazienti a rispondere ai pensieri o alle immagini intrusive che sperimentano in una maniera diversa, la quale limita l’estensione dei processi di pensiero collegati all’evento traumatico, riducendo il rimuginio e la ruminazione connessi e rimovendo il monitoraggio della minaccia e le altre strategie di coping disfunzionali come gli evitamenti o la soppressione del pensiero.
L’efficacia della MCT per il DPTS è stata esaminata in diversi studi.
Prove preliminari da una serie di casi controllati, un trial non controllato e un trial pilota controllato e randomizzato (RCT) supportano l’efficacia potenziale della MCT nel trattamento del DPTS (Wells & Colbear, 2012; Wells & Sembi, 2004b, Wells et al. 2008).
Wells e Sembi (2004b) hanno trattato in maniera consecutiva sei pazienti con diagnosi di DPTS in base ai criteri richiesti dal DSM-IV, tramite uno studio a disegno A-B su casi singoli. I pazienti della ricerca erano tutti stati esposti a crimini volenti o sessuali e avevano sofferto del disturbo per un periodo oscillante tra i 3 e i 10 mesi. In tutti i soggetti dello studio è stata evidenziata un’ampia riduzione dei sintomi da stress post-traumatico, della depressione e dell’ansia. Attraverso la somministrazione dell’Impact of Events Scale (IES; Horowitz, Wilner, & Alvarez, 1979 ) si è potuto rilevare un livello medio di miglioramento dell’83% mentre quello documentato tramite il Penn Inventory (Hammarberg, 1992) è stato del 69%. Rivalutati poi con dei follow-up a 3 e a 6 mesi di distanza, e anche considerando un arco di tempo più esteso, nessun soggetto è risultato più affetto dal disturbo.
Wells et al. in un open trial del 2008 hanno voluto indagare l’efficacia della terapia metacognitiva per il DPTS cronico. Hanno somministrato il trattamento (con una media di 8,5 sedute) a 12 pazienti che manifestavano il disturbo da un lasso temporale compreso tra i 6 e i 39 mesi riscontrando dei miglioramenti statisticamente significativi nei sintomi da stress post-traumatico, nell’ansia e nella depressione. Ad un follow-up a sei mesi l’89% dei soggetti è risultato molto migliorato o guarito, secondo i punteggi ottenuti dalla IES.
In uno studio randomizzato Wells & Colbear (2012) hanno inserito casualmente i pazienti oggetto della ricerca in lista d’attesa o nel protocollo del trattamento. I soggetti della prima condizione hanno mostrato un miglioramento pressoché nullo mentre il gruppo che aveva ricevuto il trattamento (8 sessioni) aveva ottenuto punteggi più bassi a tutte le misurazioni con una riduzione statisticamente significativa della sintomatologia post-traumatica, della depressione e dell’ansia. In base ai punteggi ottenuti alla IES, l’80% dei soggetti trattati con il protocollo è risultato andare incontro a guarigione e il 10% a un significativo miglioramento, mentre nella condizione di controllo solo il 10% dei pazienti è risultato migliorato e nessuno è guarito. Inoltre, tassi di guarigione dal 60 all’80% sono stati ottenuti al follow-up di 6 mesi in base ai punteggi ottenuti attraverso la Postraumatic Stress Diagnostic Scale (PDS; Foa, 1995) e l’Impact of Events Scale (IES). Gli autori hanno evidenziato anche la buona tollerabilità al trattamento con solo il 10% di dropout. Questo studio dimostra l’efficacia della MCT confermando i tassi di recovery documentati precedentemente (Wells & Sembi, 2004b).
L’efficacia della terapia Metacognitiva è stata recentemente testata anche attraverso la comparazione con altri trattamenti.
Wells, Walton, Lovell e Proctor nel 2015 hanno condotto un trial parallelo controllato confrontando la MCT con l’esposizione prolungata (PE). I soggetti dello studio erano 32 pazienti con diagnosi di DPTS cronico. I partecipanti sono stati assegnati a 8 sessioni di terapia (MCT o PE) o a una condizione di lista di attesa di 8 settimane. Entrambi i trattamenti sono risultati efficaci laddove comparati con il gruppo in lista d’attesa, con una riduzione statisticamente significativa della sintomatologia post-traumatica, dell’ansia e della depressione. I tassi di guarigione sono risultati essere elevati in entrambi i gruppi che hanno ricevuto il trattamento, tuttavia i miglioramenti nel gruppo MCT sono stati più rapidi. Al post-trattamento la MCT è risultata superiore rispetto alla PE per quanto riguarda la riduzione sintomatologica (misurata attraverso la IES e la Post-traumatic Stress Diagnostic Scale – PDS) e superiore alla condizione lista d’attesa per quanto riguarda le misure oggettive di iper arousal rilevate attraverso la frequenza cardiaca dei soggetti.
Nel protocollo di studio per un trial parallelo randomizzato di superiorità di Nordahl, Halvorsen, Hjemdal, Ternava e Wells (2018) si sta confrontando per la prima volta l’efficacia della MCT con l’EMDR. Lo scopo principale di questo studio, sottolineano gli autori, è quello di testare l’efficacia di un trattamento, la MCT, che, contrariamente all’EMDR, non prevede l’esposizione come ingrediente specifico, sulla scia dei risultati ottenuti nello studio precedentemente citato (Wells et al., 2015) che la metteva a confronto con la PE.
Il non includere né l’esposizione né il rivivere le memorie traumatiche potrebbe essere un fattore vantaggioso, secondo gli autori, nel ridurre le avversità al trattamento, sia da parte dei terapeuti che dei pazienti.
Nel protocollo di studio verranno inclusi 100 pazienti con una diagnosi primaria di DPTS cronico i quali saranno assegnati a due condizioni, ricevendo 12 sessioni di uno dei due trattamenti. L’outcome primario sarà la gravità dei sintomi post traumatici misurata attraverso la Posttraumatic Diagnostic Scale (PDS) misurata al post trattamento (dopo 3 mesi). Gli outcomes secondari includono gravità dei sintomi trauma correlati (sempre valutati attraverso la scala PDS), i livelli di ansia e depressione e la valutazione delle credenze metacognitive misurate a follow up di 3 e 12 mesi. I risultati dello studio ci forniranno dati importanti sulla comparazione di efficacia della terapia metacognitiva confrontata con l’EMDR e la stabilità dei risultati nel tempo.