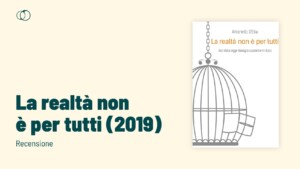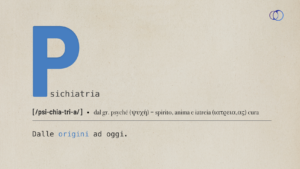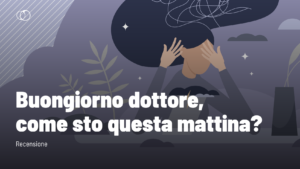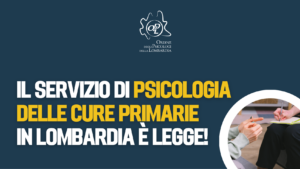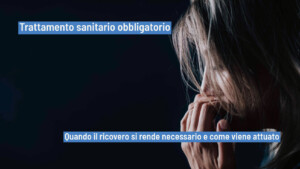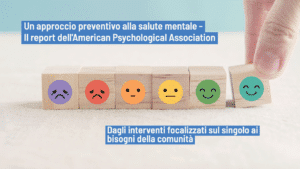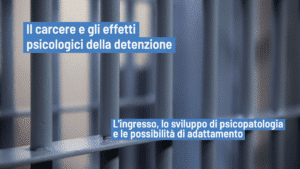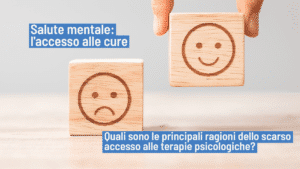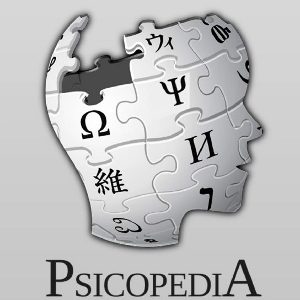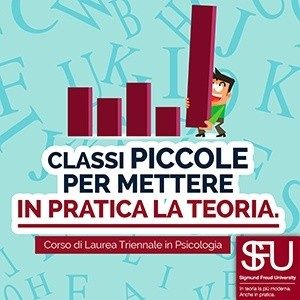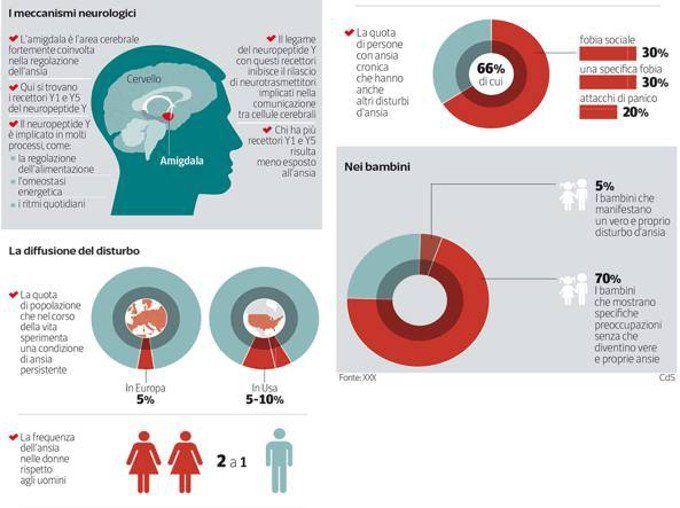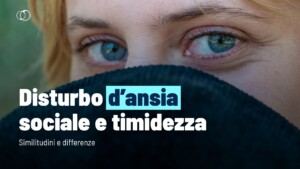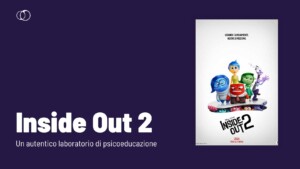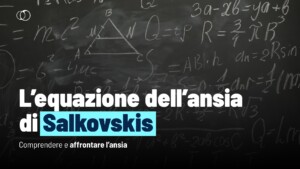Il Volontariato in Italia: come funziona questa attività?
Barbara Dardi
Fare volontariato è prendersi un impegno, una responsabilità; decidere se nella propria quotidianità si possono ritagliare alcune ore per dedicarle agli altri. E’ consapevolezza delle proprie emozioni e sentimenti verso gesti semplici ma determinanti per il benessere di alcune persone a cui è stato tolta l’opportunità di una vita serena e spensierata, ma non per questo necessariamente meno gratificante e soddisfacente.
Avere una visione chiara di cosa è il volontariato oggi, non è semplice. Se consideriamo il significato etimologico ed etico della parola, la realtà si discosta dalla definizione originaria. Per volontariato si intendono un insieme di attività a favore della collettività che mantengono 3 caratteristiche peculiari: la libera scelta della decisione di svolgere queste attività, la gratuità, ovvero il fatto di non essere retribuiti e il prodotto finale che rappresenta il beneficio ottenuto da chi lo riceve (Vitale, 2004).
Il volontariato è un comportamento prosociale, inteso come insieme di azioni volte a proteggere gli altri e favorire e mantenere il loro benessere fisico e psicologico. Fare volontariato è una decisione personale e intima, scaturita dalle emozioni profonde di aiuto verso coloro che si trovano in una situazione di disagio e che da soli non riescono a risolvere le proprie problematicità.
Fondamentali quindi risultano alcune caratteristiche personologiche di chi fa volontariato: essere altruista (interessarsi al benessere degli altri), provare empatia per le emozioni di chi ci si trova di fronte, avere una visione positiva del mondo e una propensione a trovare soluzioni alternative per risolvere i problemi, essere comprensivi e pazienti. Il volontariato costruisce dei rapporti sociali tra sconosciuti, puntando solo su una forte motivazione e uno slancio emotivo nell’aiutare gli altri, contrastando l’individualismo, l’egoismo, l’isolamento, l’antagonismo, il danneggiamento, i comportamenti distruttivi e aggressivi.
Questa forma originaria di solidarietà orizzontale è potuta mantenersi tale fino agli anni ‘90, momento in cui, grazie alla sua sempre maggiore diffusione, è diventata un settore determinante e di grande impatto, tale per cui è stato necessario varare delle normative specifiche che lo regolamentassero.
L’amministrazione pubblica ha iniziato a finanziare queste organizzazioni per svolgere servizi che non riusciva ad attivare, lasciandole libere (anche se non fino in fondo) di organizzarsi, gestire personale, tempi e modi di svolgere queste attività. In questo modo le organizzazioni di volontariato sono diventate vere e proprie aziende che fanno impresa, assumono dipendenti e vanno a contribuire in modo importante al capitale sociale dello Stato. La purezza, quindi, legata alla definizione originaria, viene a mancare (Vitale, 2004).
Secondo la legge quadro su volontariato 266/91 – art. 1 comma 1 ”…per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà”. E poi – art.3 comma 3 “…devono essere espressamente previsti l’assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti… i loro obblighi e diritti”. Art. 3 comma 4: “ …possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività da esse svolte”.
Nel grande gruppo del settore del volontariato italiano sono quindi presenti organizzazioni diversificate, dalle piccole associazioni presso comuni, ospedali e altri enti, fino alle grandi istituzioni con strutture organizzative complesse. Le organizzazioni composte da soli volontari sono in diminuzione, mentre aumentano quelle dotate di personale remunerato (www.istat.it). Spesso le piccole associazioni sono composte da familiari di persone che hanno subìto un incidente o soffrono di una qualche malattia, assumendo un profilo di gruppo di auto-mutuo-aiuto in cui supportarsi reciprocamente perché nella stessa situazione.
A Padova esiste un’associazione onlus che si chiama “Marcellino Vais”. E’ un centro diurno per disabili fisici e psichici fondato nel 1992; svolge attività pomeridiana con laboratori di vario genere (arte, falegnameria, teatro, musica, ecc.). Vengono organizzati eventi di intrattenimento, spettacoli teatrali, pranzi di solidarietà e gite a tema.
Il nome prende spunto da un ragazzo affetto da poliomelite, Marcellino Vais, che negli anni ’80 ha rivolto il suo impegno nello sport gareggiando in carrozzina, diventando più volte campione italiano di atletica leggera e creando una squadra di pallacanestro arrivata fino in categoria A1. Sulla base di questi principi di tenacia, coraggio, solidarietà ed entusiasmo, l’associazione vive solamente grazie all’impegno costante di volontari non retribuiti, che si sono succeduti nel tempo. Portare avanti l’associazione però è complicato, perché le spese fisse sono tante e le entrate sono poche.
L’associazione non è convenzionata col SSN e si appoggia solo sul contributo delle famiglie dei disabili e sulle varie donazioni. Il centro è diventato però una “seconda famiglia” per gli ospiti, perché accogliente, intimo e sempre con un’atmosfera positiva e speranzosa, nonostante la drammaticità che possa portare con sè una disabilità.
Alcuni ospiti e alcuni volontari sono presenti da tanti anni proprio per questa forma di affetto e dedizione che caratterizza il gruppo, testimoniando l’importanza della presenza non solo fisica di queste strutture sul territorio, ma la fondamentale essenza emotiva, spirituale ed empatica di chi dedica il proprio tempo e le proprie energie verso queste persone. I volontari sono persone esterne alla famiglia degli ospiti, accentuandone ancora di più il carattere di gratuità e solidarietà pura, spontaneità e sincerità di affetti.
Come bene testimoniano i dati istat rispetto ad un decennio fa dove i settori in cui si svolgeva volontariato erano prettamente quello sanitario e sociale, adesso le persone sono più impegnate nelle organizzazioni con finalità ricreative e culturali. Il volontariato si sta dirigendo verso settori più “facili”, allontanandosi da situazioni problematiche che richiedono un maggior impegno emotivo. Per il Marcellino Vais risulta quindi difficile reperire i volontari. Ma anche gli ospiti.
Anche se i dati confermano un incremento di chi fa volontariato anche in modo personale tramite donazioni o attività singole (non appoggiandosi ad associazioni) tante sono le condizioni esterne che possono intralciare la presa di decisione. E’ difficile per un giovane disoccupato, appena uscito dalla scuola o dall’università, impiegare il tempo in un’attività che non dà stipendio. Alcuni giovani lo fanno per una questione di esperienza e formazione, con la speranza che poi l’associazione decida di assumerlo. Inoltre non riescono a dare la continuità nel tempo perché appena capita un’occasione lavorativa devono necessariamente abbondonare . Ma dall’altra parte ci troviamo anche degli over 60enni che sono in pensione, ma che spesso hanno l’impegno di aiutare i figli e i nipoti nella gestione familiare, economica e pratica. Quindi spesso capita che una persona voglia fare volontariato ma non può per questioni personali.
Inoltre, spesso la famiglia del disabile che non può usufruire del servizio pubblico (per varie motivazioni), non sceglie nemmeno una struttura privata, tenendo il parente a casa. Questo significa privare il disabile di determinati stimoli educativi e sociali che un’organizzazione appositamente strutturata potrebbe dare, ma soprattutto enfatizza le problematiche di gestione della persona in casa, aumentando la probabilità di intaccare l’equilibrio tra i membri della famiglia.
Soprattutto se la disabilità è medio grave o grave, i genitori o i familiari che hanno a carico il disabile si trovano a dover far fronte a problematiche di cura e accudimento totale, 24/24 ore, sacrificando la propria vita. Il sostegno e l’appoggio domiciliare pubblico è molto limitato e le famiglie si ritrovano intrappolate in casa senza alternative.
Rispetto agli anni ’90 in cui la struttura conteneva il massimo numero degli ospiti che era consentito e vantava di almeno una trentina di volontari che si turnavano, soprattutto giovani, negli ultimi anni i numeri si sono fortemente abbassati. I volontari sono scesi considerevolmente e l’età media è aumentata ( sopra i 60 anni) e gli ospiti, ognuno con le proprie situazioni familiari, sono diminuiti, rimanendo i pochi affezionati. Dopo aver cambiato diverse sedi, dal 2004 si trovano in quella attuale; le spese sono aumentate, comprese quelle fisse come l’affitto, i consumi e il gasolio per il pulmino privato che ogni giorno fa il giro e passa a prendere a casa gli ospiti e li riporta la sera. Pulmino regalato da Dario Fo nel 1997 quando ha devoluto in beneficienza il ricavato del premio nobel alla letteratura. Giusto per rendere più difficoltoso il proseguire delle attività l’ente che inizialmente ha concesso l’edificio gratuitamente completamente da ristrutturare a spese dell’associazione, una volta ultimati i lavori e vedendo che era stato trasformato in una struttura accogliente, ha iniziato a chiedere l’affitto.
Dal punto di vista educativo e formativo, gli standard richiesti si sono innalzati per garantire un servizio di qualità elevata; lavorare con i disabili non significa più “far compagnia”, ma si prevede un percorso consapevole, mirato a degli obiettivi di miglioramento e cambiamento, per favorire un benessere fisico, psicologico e sociale, verso una migliore qualità di vita e integrazione nella società. Questo può avvenire solo con personale professionale formato, competente. E’ necessario quindi un intervento di potenziamento di alcuni aspetti salienti per rendere l’associazione completa. Avere la presenza costante di un professionista che svolga il ruolo di gestione e supervisione dell’intera organizzazione è impensabile proprio per i costi troppo elevati, anche se i volontari e le famiglie ne riconoscono la necessità per poter proseguire.
A questo punto l’associazione è arrivata ad un bivio: mantenere le caratteristiche iniziali con cui è sorto il centro, nonostante l’alta concorrenzialità e la variabilità dell’offerta sul territorio, andando a far leva sull’esperienza ventennale e l’essenza pura di ciò che significa fare volontariato, oppure trasformarsi in un’azienda che eroga servizi sociali e modificare la motivazione di base, ovvero lo spirito caritatevole che muta in un reddito da percepire.
Fare volontariato è prendersi un impegno, una responsabilità; decidere se nella propria quotidianità si possono ritagliare alcune ore per dedicarle agli altri. E’ consapevolezza delle proprie emozioni e sentimenti verso gesti semplici ma determinanti per il benessere di alcune persone a cui è stato tolta l’opportunità di una vita serena e spensierata, ma non per questo necessariamente meno gratificante e soddisfacente.
Tutte le persone hanno il diritto di vivere nel miglior modo possibile ed è un dovere comune, sociale, collettivo, creare le condizioni e le situazioni per offrire questa possibilità. Non tutti hanno una propensione ad entrare in contatto con coloro che mostrano “diversità” rispetto a se stessi e alla norma; la paura della diversità nasce dalla non conoscenza e dalla percezione della propria incapacità di farci fronte a particolari situazioni che possono capitare. Ma il volontariato ha molte sfaccettature, ci sono molti modi di metterlo in pratica, basta trovare quello più adatto a sè.
ARTICOLO CONSIGLIATO:
Lo Psicologo? Una risorsa preziosa, purchè sia gratis
BIBLIOGRAFIA: