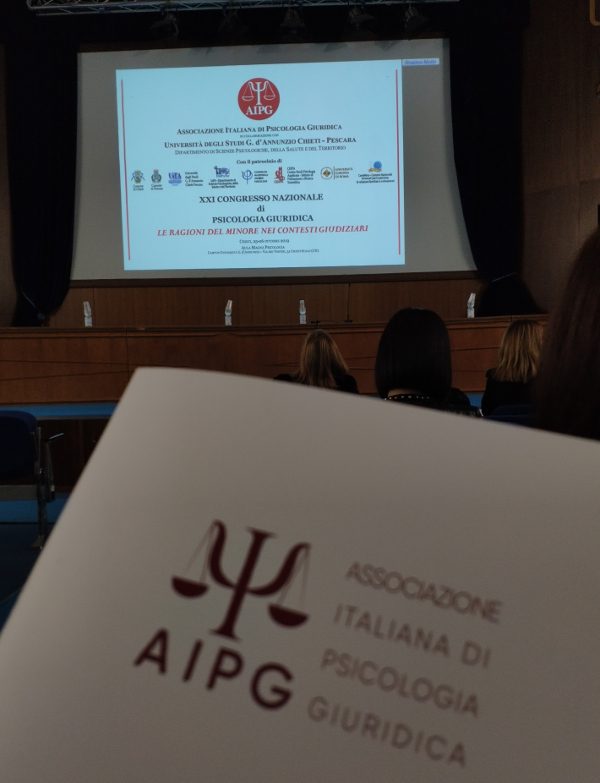L’eredità del Trauma e della Dissociazione: corpo e mente in una nuova prospettiva – Report dal 7° Congresso Biennale della Società Europea per il Trauma e la Dissociazione (ESTD)
Si è tenuto a Roma, dal 24 al 26 Ottobre 2019, il 7° Congresso Biennale della Società Europea per il Trauma e la Dissociazione (ESTD), dal titolo “L’eredità del Trauma e della Dissociazione: corpo e mente in una nuova prospettiva”
Dopo una prima giornata dedicata ai workshop precongressuali e all’apertura ufficiale dei lavori con la lettura magistrale di Michela Marzano “Dal ‘Cogito Ergo Sum’ alla fragilità della condizione umana: le contraddizioni dell’esistenza”, prende il via il 7° Congresso ESTD.
Esperti da tutto il mondo si sono riuniti nella Città Eterna per confrontare e condividere le proprie conoscenze ed intuizioni sul trauma e la dissociazione e poterne migliorare il trattamento. Il filo conduttore del congresso è stata l’esplorazione dei nuovi e stimolanti risultati inerenti la relazione corpo mente nella dissociazione, con un focus particolare sulla connessione tra trauma, dissociazione e corpo.
Il Congresso si apre con l’intervento magistrale di Kathy Steele sulle sofferenze intrecciate e il Sé incarnato di paziente e terapeuta, una lezione per il terapeuta che si occupa di Trauma e che, oltre a prendersi cura del paziente, deve prendersi cura di sé. In linea con quanto affermato da Michela Marzano, è fondamentale ricordarsi che il terapeuta, così come il paziente traumatizzato, è una incarnazione di corpo e mente, un’unità delle parti in continua costruzione “quello che sono qui oggi è diverso da quello che sarò tra 5 minuti o tra 5 anni”. Importante quindi che il terapeuta sia radicato nel suo corpo e capace di integrare le proprie sofferenze con il proprio vissuto e accettare il paradosso del dolore “più cerchiamo di evitare il dolore più soffriamo, più cerchiamo di accoglierlo meno sofferenza avremo”. Un accento posto quindi sulla accettazione della vulnerabilità, fallibilità, umanità del terapeuta come fulcro per un ingaggio incarnato con il paziente e requisito fondamentale per lavorare con il trauma e la dissociazione. Un terapeuta incarnato come ci insegna Steele è un terapeuta compassionevole, connesso, vulnerabile e resiliente, è un terapeuta che abbraccia le proprie negatività e che nel lavoro con il trauma è focalizzato sul processo piuttosto che sul contenuto.
Ci si addentra poi nella complessa relazione tra Trauma e Dissociazione con l’intervento di A.Laddis, E Nijenhuis, J. Rydberg e A. Schimmenti che propongono una relazione causale tra lo stress derivante dal trauma e la dissociazione, concludendo che i due fenomeni co-occorrono. Condividono con la platea la consapevolezza che per arrivare ad una evidenza scientifica si ha bisogno di avere una definizione più chiara, più “ristretta” e condivisa di trauma e di dissociazione. Ciò richiede di distinguere cosa differenzia lo stress legato al trauma dagli altri tipi di stress e cosa differenzia la dissociazione correlata al trauma da altri fenomeni simili. In particolare Schimmenti propone una digressione della relazione tra trauma e dissociazione da un punto di vista teorico ed empirico, evidenziando come spesso i terapeuti tendono a considerare la dissociazione solo correlata al trauma mentre di fatto troviamo sintomi dissociativi anche in disturbi del sonno o in presenza di deficit metacognitivi e di difficoltà di autoregolazione. Vengono quindi riportati vari studi che mostrano come la correlazione tra trauma e dissociazione sia “dose-effetto” per cui si evidenzia la necessità di indagare in modo approfondito il ruolo dell’attaccamento nel trauma e nella dissociazione. E, aggiunge Rydberg, è necessario crearsi una propria definizione di trauma e dissociazione comprendendo ciò che significa quella esperienza per quello specifico paziente, sottolineando come la dissociazione può intervenire per evitare, in una situazione traumatica, la decomposizione della personalità.
Da qui si delinea in modo sempre più chiaro la difficoltà diagnostica cui il clinico si trova di fronte a causa di questa elevata comorbilità e per il fatto che molto spesso il paziente presenta una seri di sintomi dissociativi che però non rappresentano il problema per cui arriva in terapia. S. Boom e I. Michalopoulos cercano, nella prima parte del loro intervento, di far chiarezza nella diagnosi di disturbo dissociativo e disturbo psicotico proponendo anche le diverse implicazioni per il trattamento. Attraverso la condivisione di video di sedute di terapia discutono somiglianze e differenze tra pazienti con disturbo dissociativo (DID) e pazienti con disturbo psicotico e mostrano come i due disturbi possono essere differenziati da un cluster di sintomi dissociativi e dalla qualità di questi sintomi, includendo anche i sintomi di Schneider. Ovviamente possono essere presenti anche diagnosi combinate. Nella seconda parte del workshop si focalizzano sugli interventi per il trattamento dei sintomi “psicotici” nei pazienti con DID che sono molto frequenti in base alla loro esperienza clinica in soggetti che hanno subito abusi organizzati e che sono stati vittima di estreme coercizioni. Fondamentale quindi una corretta diagnosi per individuare il trattamento più adeguato al caso specifico, nonché l’utilizzo di un linguaggio condiviso con il paziente stesso.
Ci si addentra quindi nella comprensione del DID con la lezione magistrale di Martin Dorahy che propone una esplorazione della vergogna, dell’amnesia inter-identitaria e l’ascolto di voci, tre aspetti strettamente connessi tra loro e con un importante impatto nella terapia. Spesso infatti la presenza di un DID non è esplicita, ma coperta da molti sintomi che riflettono lo sforzo dei pazienti di nascondere la vera natura delle loro sottostanti difficoltà. Doray sottolinea come una ragione di questo mascheramento sia la vergogna legata ai fenomeni specifici del DID, ossia le identità dissociate, la mancanza di consapevolezza di queste differenti identità e del loro contenuto, l’udire voci che fanno sembrare questi pazienti degli alieni. Dorahy approfondisce accuratamente la vergogna, l’amnesia intra-identitaria e l’ascolto di voci e mostra come vari studi hanno rilevato che la vergogna nel DID ha caratteristiche simili a quella presente in altri disturbi correlati al trauma come il PTSD, ma i pazienti con DID nonostante la propensione al ritiro e all’evitamento della vergogna riconoscono l’importanza di un trattamento terapeutico focalizzato proprio su questa emozione. Rispetto all’amnesia intra-identitaria Dorahy mostra numerosi studi che hanno evidenziato come le memorie semantiche autobiografiche possano richiamare le identità, nonostante la persona non ne sia consapevole. Una persona con DID, infatti, riferisce amnesie per delle parti del Sé ma può comunque avere una rappresentazione globale del Sé. Trova quindi supporto l’idea che mentre la persona può non essere consapevole di alcune parti di Sé, queste possono essere comunque recuperate. Relativamente all’udire voci, Dorahy mostra studi di comparazione tra le voci nel DID e quelle nella Schizofrenia da cui è emerso come nel DID ci sia un più elevato livello di allucinazioni uditive e soprattutto di voci bambine. Per Dorahy quindi il DID è un disturbo incline alla vergogna, con soggettive difficoltà di recupero dell’esperienza dolorosa e, nei casi in cui c’è una massiccia esperienza allucinatoria ciò sembra apparentemente dovuto dalla natura dissociativa delle loro difficoltà.
Si chiude quindi una prima intensa giornata, ricca di spunti ma anche carica di riflessioni e dubbi legati alla condivisa mancanza di una definizione chiara e univoca del concetto di trauma e di quello di dissociazione, che rende difficoltosa l’individuazione stessa del trattamento più adeguato.
Perplessità che ci accompagnano anche nella giornata successiva che si apre con la lezione magistrale di Benedetto Farina che, in ottica neuroscientifica, cerca di rispondere all’interrogativo rispetto al considerare Dissociazione e Dis-integrazione due processi patogenici correlati al trauma. Sono quindi Dissociazione e Dis-integrazione lo stesso processo etichettato con nomi differenti? L’osservazione clinica e i risultati scientifici, esplicitamente e pienamente debitori all’opera di Gianni Liotti, portano ad ipotizzare che si tratti di due processi differenti, ma altamente correlati. La mancanza di integrazione può essere quindi considerata l’effetto, travolgenti emozioni ed arcaici sistemi di difesa attivati dagli eventi traumatici o dai loro ricordi.
Differentemente, la dissociazione può essere considerata la successiva ricomposizione degli elementi del sistema in più parti separate. La distinzione di questi due processi risulta fondamentale per il trattamento terapeutico.
I lavori proseguono addentrandosi nella comprensione di un altro concetto con cui spesso i terapeuti del trauma si trovano di fronte: il Daydreaming Maladattivo (MD), un’attività fantastica, estensiva, elaborata ed intenzionale, accompagnata da movimenti ripetitivi, che viene messa in atto come una sorta di fuga dalla realtà e assorbe moltissimo tempo interferendo con la vita quotidiana del soggetto. L’MD è un assorbimento dissociativo che sembra basato su un tratto che queste persone si riconoscono fin dall’infanzia, ovvero la capacità di sognare ad occhi aperti come una forma internalizzata di gioco molto gratificante. Un gruppo di terapeuti provenienti da Israele, Polonia, Italia, Ungheria e Stati Uniti affronta il tema condividendo le proprie esperienze cliniche, riflettendo sui criteri diagnostici e ponendosi l’interrogativo se questo sia una delle varie espressioni del trauma e della dissociazione o una dimensione a sé. Si discutono quindi i criteri diagnostici per l’MD, la sua fenomenologia, la comorbilità e le caratteristiche associate, ponendo attenzione anche alla diagnosi differenziale con disturbi da dipendenza, disturbo ossessivo, disturbi dissociativi e disturbi da movimenti stereotipati. Lo stato della ricerca lascia ancora molte domande aperte ed il costrutto è ancora in fase di studio, ma dai primi risultati sembra avere una propria identità distinta, misurata e diagnosticata in maniera affidabile attraverso specifici strumenti. Emerge inoltre un’alta comorbilità con diversi disturbi psichiatrici e una certa correlazione con esperienze traumatiche infantili. Il trauma e la dissociazione sono prominenti nell’MD ma non si presentano in tutti i casi. Tuttavia, anche se la struttura dissociativa non risulta presente, tutti gli individui con MD descrivono una dissociazione tra il loro sé esterno, la loro vita “infelice e bastonata” e il loro mondo interiore fantastico, ricco e colorato. L. Somer ci mostra come questo emerga chiaramente dai disegni di questi pazienti e li compara con i disegni dei pazienti DID: la differenza più evidente è che mentre nei disegni dei pazienti DID tutto appare sfumato e poco definito, nei pazienti con MD c’è una netta differenziazione tra la realtà esterna “grigia” e il mondo interno fantastico “colorato”.
Il congresso si chiude infine con l’illuminante l’intervento di E. Nijenhuis sull’ Enactive Trauma Therapy: un ponte tra mente, cervello, corpo e mondo. Un approccio che considera le persone traumatizzate come incarnate e incorporate nel loro ambiente, orientate nei loro scopi dal sistema organismo-ambiente fondamentale per preservare la loro esistenza, qualcosa di dinamico in cui tutto fa parte di quello stesso organismo, sia la mente che il corpo. Il trauma è quindi considerato in questo approccio come una ferita all’intero sistema organismo umano-ambiente. Nei disturbi dissociativi ciò si traduce nella presenza di due o più consapevoli sottosistemi (parti) che portano avanti il loro proprio sé mentale e fenomenico. Muovendosi tra Spinoza e Kafka, Nijenhuis definisce l’Enactive Trauma Therapy come il tentativo di riparare il deficit integrativo: il paziente e il terapeuta costituiscono un sistema a sé, si muovono in un mondo comune e condividono dei risultati, insieme producono nuove azioni e nuovi risultati “L’ Enactive Trauma Therapy può essere paragonata a una danza in cui paziente e terapeuta mettono insieme la musica, insieme definiscono il ritmo, si sintonizzano e sincronizzano, bilanciano la loro sensibilità, movimenti e ritmo”.
Al termine dei lavori viene consegnato a Ellert Nijenhuis un riconoscimento dall’ESTD per il suo costante e fondamentale contributo allo studio del trauma e della dissociazione, un contributo che come il famoso pittore italiano Giorgio Morandi “sempre uguale a se stesso ma sempre diverso, attento ad approfondire i piccoli oggetti senza cercare temi nuovi” anche Nijenhuis si è focalizzato sulla comprensione dell’essenza delle esperienze traumatiche e dei fenomeni dissociativi con rigore e metodo, approfondendone ogni sfaccettatura.