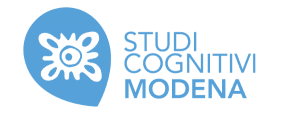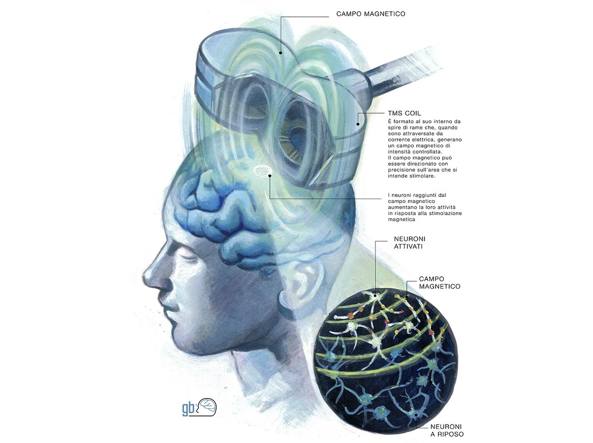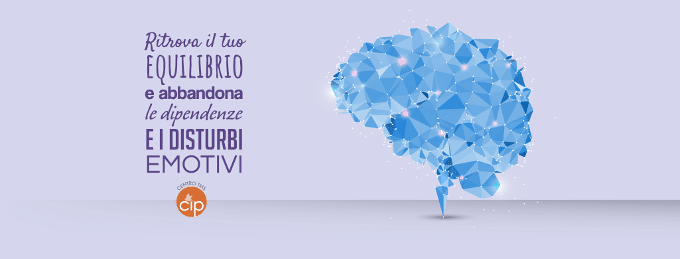E’ arrivata la cicogna: vivranno felici e contenti?
La nascita di un figlio è un evento che porta grande felicità, ma non di rado il passaggio da coppia a famiglia presenta complessità individuali, relazionali e trigenerazionali che possono mettere in discussione la coppia: ma come un’eventuale crisi può dimostrarsi un’opportunità migliorativa per la coppia?
Un lieto evento che comporta anche alcune criticità
La nascita di un figlio è tradizionalmente e culturalmente intesa come un evento gioioso, forse il più lieto in assoluto, quello di cui implicitamente il matrimonio (o la convivenza, in una visione meno culturalmente storicizzata) diviene uno step intermedio nella fase del ciclo di vita di una persona e di una coppia. Ne è prova la presenza di domande e aspettative che la società pone e ripone in una coppia composta da partner arrivati a una certa età e/o dopo un periodo di ‘sufficiente’ collaudo. Ovviamente per stabilire quale sia la ‘certa età’ e una durata del legame ‘sufficiente’ ci si appella a parametri che variano in funzione dei singoli contesti culturali e familiari. Ad ogni modo, se inizialmente le domande che una coppia si sente prevalentemente rivolgere sono del tipo ‘Allora, non è ora di andare a convivere/di sposarsi?’, non sarà sufficiente pronunciare ‘il fatidico sì’ per essersi liberati dalle curiosità altrui. In poco tempo infatti prenderanno il sopravvento domande del tipo ‘Non è l’ora di allargare la famiglia?’ o ‘Quando pensate di fare un figlio?’. Sembra una questione di costume sociale, ma in realtà il lutto da elaborare per una mancata genitorialità (processo di per sé non facile) è a volte ulteriormente complicato anche da un senso di inadeguatezza rispetto al mancato raggiungimento delle aspettative sociali.
Che cosa succede invece alle coppie che riescono a coronare il sogno di diventare genitori? L’arrivo della cicogna rappresenta la classica ciliegina sulla torta nel percorso intrapreso per diventare una famiglia unita? Ci auguriamo di sì, per chi stesse vivendo questo importante momento, ma è utile anche considerare alcune variabili che potrebbero rendere meno idilliaca questa fase del ciclo di vita.
La nascita di un figlio può costituire un fattore di rischio per l’equilibrio di coppia e anche individuale dei genitori, magari soprattutto se il neonato ha un temperamento che lo caratterizza per difficoltà nel sonno, pianti frequenti per coliche o altri problemi e fatica nel mangiare adeguatamente: sono variabili che più facilmente implicano una difficoltà di gestione, e che rendono il bambino, suo malgrado, un alimentatore di tensioni che mette a dura prova l’equilibrio psicofisico dei genitori. Cambi radicali di ritmi, di routine, di abitudini, alterazioni del ciclo sonno-veglia e aspetti legati a eventuali preoccupazioni o senso di inadeguatezza verso i bisogni del neonato sono considerabili come fisiologiche scosse di assestamento che non per forza arriveranno a rappresentare un terremoto interno alla coppia. Vediamo però quali possono essere le faglie da cui è possibile che si sviluppino importanti scosse telluriche nella vita della coppia dei neo-genitori.
Quali sono i fattori di rischio per la coppia presenti già alle radici del desiderio della genitorialità?
Chi si occupa di urbanistica sa bene che la prima regola è non costruire in zone sismiche. Quali condizioni alla base della nascente genitorialità possono essere considerate, appunto, ‘zone sismiche’?
Innanzitutto non è scontato che la nascita di un figlio sia stata l’esito di un progetto condiviso e pianificato: per esempio può capitare che sia presente il desiderio di un figlio, ma che il suo arrivo sia considerato decisamente prematuro, perché, per esempio, possono mancare le condizioni di stabilità abitativa, economica (studi non ancora compiuti, lavori precari…) o perché la coppia non si sente ancora abbastanza ‘stabile e rodata’. Quando invece la gravidanza avviene in una coppia che non aveva mai nemmeno affrontato l’argomento, la complessità aumenta, spesso perché uno dei due partner si rivela contrario o dubitante sull’opportunità di diventare genitore, fino a verbalizzare l’idea di considerare la possibilità di un’interruzione di gravidanza volontaria. A volte può anche succedere che la gravidanza si verifichi nei tempi previsti dalla coppia fortemente desiderosa di avere un figlio, ma una variabile esterna (grave malattia o morte di un familiare, perdita del lavoro, malattia o incidente di un membro della coppia) possa complicare gli equilibri della coppia, rendendo di conseguenza più faticosa anche la gestione del neonato e delle dinamiche relazionali.
Se le situazioni appena illustrate sembrano rappresentare un ovvio terreno sismico, meno evidenti sono altri elementi che è possibile ritrovare anche in coppie in cui vi è la dichiarata intenzione di avere un figlio. Non è scontato infatti che il desiderio di genitorialità sia allo stesso livello tra i due partner: ovviamente non esiste un termometro del desiderio, ma può capitare che uno dei due sia molto più motivato, mentre l’altro risulti semplicemente ‘possibilista’ o tenda a essere adesivo al progetto dell’altro pur non vivendolo con la stessa intensità.
Può capitare anche che, a ‘parità’ di motivazioni, queste ultime siano di natura molto differente: per esempio, un partner può sentire il bisogno di parificare il proprio ruolo nei confronti di altri fratelli (che magari hanno appena avuto figli), o sentire di dover risarcire un genitore (perchè rimasto vedovo, perchè non ha potuto fare il genitore ai tempi per problemi lavorativi o di altra natura….) o di risultare più in vista per i genitori in quanto primo tra i figli a generare un erede o un nipote che sia proprio maschio o femmina: si tratta di pressioni, più o meno esplicite e consapevoli, derivanti dalle famiglie di origine, il cui ruolo è molto importante negli aspetti connessi alla genitorialità, come vedremo nel corso dell’articolo.
Vi possono però essere pressioni interne alla coppia stessa. -Quindi…- magari vi starete domandando -…nemmeno una coppia in cui entrambi i partner che condividono il medesimo grado di motivazione nell’avere un figlio, e quest’ultimo arriva nei tempi pianificati, può dirsi sicura di non essere in zona sismica? – Esattamente così. Infatti, per esempio, costituisce un rischio il desidero di avere un figlio se questi è pensato, più o meno inconsciamente o esplicitamente, come soluzione per risolvere una crisi di coppia già in atto in modo conclamato (magari dopo un tradimento o forti tensioni), puntando tutto sul convergere su un impegno e un progetto comune per rilanciare la coppia, o anche più semplicemente perché si attraversa un periodo di stagnazione, per cui un figlio è ciò che potrebbe rivitalizzare il rapporto o l’esistenza individuale dei partner.
Tutti questi aspetti, che sono solo alcuni dei potenzialmente infiniti scenari, rappresentano il contesto in cui un neonato inizia a co-costruire l’appartenenza alla propria famiglia, un percorso psicologico le cui premesse semantiche (Ugazio, 1998) ‘si costruiscono prima della nascita del bambino e prendono corpo nell’immagine virtuale che si crea intorno a un nascituro‘ (Gandoli & Martinelli, 2008, p.32). Tale presupposto spiega come mai un figlio non è mai neutro o immune a contesti di coppia in cui vi sia conflittualità: i segnali di malessere emotivo che già nella prima infanzia possono insorgere (comportamenti non gestibili dai genitori, difficoltà legate al sonno o all’alimentazione) sono infatti considerabili come una qualità emergente del sistema familiare a cui il bambino appartiene (Gandolfi & Martinelli, 2008; Gandolfi, 2015) e che spesso, nei casi appena descritti, si caratterizza per la presenza di conflitto nella coppia genitoriale (sia essa unita o separata). D’altronde, oramai numerosi studi rendono evidente la capacità dei bambini di percepire l’emotività dei propri adulti di riferimento (Andolfi, 1999; Aucoturier & Lapierre, 2001, Fivaz-Depeursinge, Corboz-Warnery, A., 2000; Fivaz-Depeursinge, Philipp, D.A., Mazzoni, S, 2015.) e di costruire il proprio positioning all’interno dell’impalcatura semantica familiare (Ugazio, 1998 e 2012; Gandolfi e Martinelli, 2008; Gandolfi, 2015).
Quali rischi sono insiti nelle transizioni della nascita, dalla pancia alla culla, da figli a genitori, da coppia a triade?
Tra aspettative e motivazioni più o meno condivise e tempistiche più o meno azzeccate, la nascita del bambino segna un passaggio nel ciclo di vita della persona, che in un’ottica individuale del ciclo di vita (Scabini 1995; Cigoli, 1997) aggiunge al ruolo prevalente di figlio quello di genitore, mentre a livello di coppia (Willi, 2004) il passaggio è da diade a triade (ovviamente nel caso si tratti di un primogenito). Si tratta di transizioni che comportano dei compiti evolutivi per i neogenitori, dal punto di vista psicologico individuale e relazionale, non solo con il partner, ma anche (e soprattutto?) con la propria famiglia di origine.
Uno degli scenari più comuni, esito spesso di un investimento molto diverso rispetto alla genitorialità da parte dei due partner, è il crearsi di un legame di coppia verticale, cioè tra figlio e un genitore, che prevale su quello orizzontale (quello cioè tra la coppia dei genitori), con l’effetto di far sentire uno dei due genitori escluso. Nell’immaginario collettivo è più facile che sia la madre a sviluppare un rapporto maggiormente intenso col figlio, quasi esclusivo, facendo sì che l’uomo si senta trascurato ed escluso, ma vi sono casi in cui i ruoli sono invertiti, nonostante il maggior tempo che la madre vive accanto al figlio. Non di rado, nelle narrazioni di persone che avviano relazioni extraconiugali od occasionali, l’inizio della crisi di coppia o del bisogno di ‘evasione’ è fatto risalire proprio a un vissuto di esclusione da parte del partner in seguito alla nascita di un figlio.
Ho già accennato al ruolo delle famiglie di origine, che nel momento in cui nasce un bambino assumono una rilevanza importante da un punto di vista psicologico e relazionale. Ci sono scenari in cui il legame di entrambi i partner con le proprie famiglie di origine è sereno e vi sono le adeguate condizioni organizzative (vicinanza chilometrica, assenza di fattori quali malattie, impegni massivi su altri fronti…) per cui per la gestione del bambino si crea un legame di cooperazione caratterizzato dall’assenza di competizioni educative e/o da attribuzioni di colpe. Su che cosa sia una competizione educativa ci offre una risposta un aneddoto che chiunque abbia sperimentato una relazione nonni-genitori-figli (a prescindere da quale ruolo abbia interpretato) avrà quasi certamente vissuto: il bambino è con i nonni e quando arriva il genitore a prenderlo si vivacizza impiegando troppo tempo per prepararsi, per sistemare i giochi e dimostrandosi refrattario a ogni richiesta genitoriale. A questo punto scatta la frase da parte uno dei nonni: ‘guarda, è stato tranquillo fino a quando sei arrivato tu’ (a tale frase ricorrono talvolta anche i genitori l’uno nei confronti dell’altro, e suona come un campanello d’allarme per la quiete di coppia). Ovviamente tale frase, presa singolarmente e come episodio isolato, non è patogena, ma ci spiega come è possibile essere in presenza di una nonna che si pone come ‘super genitore’. Mi preme sottolineare che a incidere in questo scenario non è tanto quanto il bambino realmente agisca, ma i significati che gli vengono attribuiti. Non c’è bisogno di aspettare infatti capricci o comportamenti particolari: Miriam Gandolfi insegna come sia sufficiente amplificare i messaggi delle frasi che si ascoltano nelle nursery degli ospedali durante la visita dei parenti ai bambini in culla esposti al pubblico: per esempio, la frase ‘guarda come è tranquillo, hai visto che hai fatto bene a riposarti in gravidanza, come ti dicevo io’ pronunciata da una nonna alla neo-madre, è un’affermazione che non sottolinea tanto il grado di bonarietà del neonato, ma il ruolo di super consigliere e super genitore della nonna in questione (Gandolfi, 2008, p.32). A volte tale situazione può essere indice di una più ampia cornice connotata da giochi di potere tra genitori e nonni in cui, per esempio, tratti fisici o comportamenti del bambino possono essere assunti come marker della sua maggior appartenenza all’uno o all’atro ramo familiare: ‘è tutto suo nonno/ padre/zio…’, che può essere legato a motivi di orgoglio se riferiti a parenti del proprio ramo familiare, o di attribuzione di colpe e responsabilità se imputati agli esponenti dell’altra famiglia (Gandolfi, 1987). Si possono avere situazioni in cui uno dei due genitori provenga da contesti un cui le barriere generazionali nei confronti della propria famiglia di origine sono confuse, con confini labili che possono generare meccanismi di richiamo molto potenti. Ne sono alcuni esempi, ricevere la visita dei nonni in determinati giorni e orari non condivisi dai genitori, o il pranzo domenicale come tappa obbligata, o anche le vacanze estive, vissute, in parte o in toto, insieme ai nonni. Relativamente alle vacanze estive, è curioso poi osservare come gli altri nonni reagiscono. Lo faranno pesare? E il genitore figlio dei nonni meno ‘presenti’, come si sentirà? È già stato affiliato dai suoceri per precedenti contrasti con la propria famiglia o vive un senso di colpa e di esclusione per il quale i propri genitori lo istigano?
In tutto questo, pensate a che riverberi possa avere la scelta di mandare un bambino al nido o scegliere se affidarlo ai nonni, e in tal caso, a una delle due coppie di nonni o a entrambe? In quantità di tempo uguali, oppure no? Ogni scelta rischia di essere percepita come una scelta di campo, come un affronto o un nuovo debito di riconoscenza.
Ho presentato alcuni degli scenari possibili che possono portare la coppia a un aumento delle tensioni interne e, a livello individuale, anche a una messa in discussione del legame con la propria famiglia di origine. Non solo, a prescindere dagli scenari presentati, diventare genitori implica un confrontarsi con il modello genitoriale di cui si è fatta esperienza come figli. A volte ci si trova a comportarsi proprio nei modi dei propri genitori da cui ci si era giurati di voler prendere le massime distanze. Non è infatti rara la frase: ‘ho sempre criticato i miei genitori per questo/quel comportamento, e ora sto facendo lo stesso’. Sono tante le attribuzioni di significato possibili per spiegare un tale meccanismo che a volte mette in crisi una persona.
È utile rivolgersi a uno psicologo?
Abbiamo visto come quindi un neonato e un bambino, loro malgrado, possano rapidamente passare dal rappresentare la ciliegina sulla torta di un perfetto quadro idilliaco familiare a essere un detonatore potente nella coppia genitoriale, sia per fattori strettamente riguardanti la dinamica relazionale tra i due partner, sia per questioni che affondano radici nei legami (irrisolti) con le famiglie di origine, con cui magari uno o entrambi i partner hanno il proprio vero matrimonio psicologico (Andolfi, 1999; Gandolfi, 2015).
Non è certo la nascita di un bambino che avvia e crea tali dinamiche, ‘semplicemente’ ne permette il manifestarsi in maniera più evidente, sia perché rappresenta un intenso investimento emotivo, sia perché si moltiplicano richieste di visite (ed eventuali rifiuti), di consigli, di scambi tra la coppia genitoriale e le famiglie di origine. Talvolta la situazione precipita fino ad aprire una crisi di coppia, che non è necessariamente l’anticamera della separazione, ma può essere, come l’etimologia della parola ‘crisi’ insegna, anche un’opportunità: la coppia, anche tramite l’aiuto di una consultazione psicologica, può cogliere l’occasione per ridefinire alcune dinamiche relazionali, sia interne che esterne.
A livello interno, i membri della coppia possono acquisire modalità di comunicazione più costruttiva e meno distruttiva durante le discussioni, e/o imparare a esplicitare i fattori di malcontento, favorendo un confronto aperto: si tratta di una condizione che è possibile sviluppare nel momento in cui entrambi i partner arrivino ad avere la percezione di una distribuzione equilibrata del potere, maturando l’idea che la verità è relativa. Ammettere che esistano ‘le mie ragioni e le tue ragioni’ e che ‘anche la tue ragioni hanno una certa credibilità’ sono due premesse molto importanti per far sì che i litigi possano essere costruttivi. Il mio pregiudizio è che in una coppia le discussioni siano inevitabili, sane ed evolutive: l’importante è che siano uno stimolo per confrontarsi e chiarirsi, non un modo attraverso cui i due partner si allontanino irrigidendosi sulle proprie posizioni, così come sostiene anche Beavers (1996), dopo un trentennale lavoro con coppie presso il Southwest Family Institute di Dallas, centro da lui fondato.
A livello di ridefinizione dei legami con l’esterno, una consultazione psicologica può aiutare la coppia a delimitare i propri confini con le famiglie di origine, o meglio, utilizzando una metafora di Miriam Gandolfi (2015), a regolare l’apertura e la chiusura dei ‘cancelli’ che delimitano il territorio della coppia (e della neo-famiglia). Non significa escludere ed escludersi dai propri legami familiari, ma vivere senza sensi di colpa per aver ridefinito regole, distanze ed equilibri: è possibile declinare un invito a pranzo senza provare rimorsi e non godendosi quanto si era scelto di preferire all’abituale domenica dai genitori? È possibile iscrivere il figlio al nido, per scelte educative della coppia, anche se i nonni tanto reclamavano la cura del nipotino?
Infine, vi è anche la possibilità che una crisi della coppia porti a una separazione, opzione che non in assoluto rappresenta un esito clinicamente negativo: se è vero, infatti, che si tratta di un lutto da elaborare perché rappresenta il fallimento di un progetto, è comunque un’opzione più evolutiva, sana e preferibile al mantenimento di un legame altamente disfunzionale e patogeno: anche quando fatto ‘per il bene dei bambini’, non è mai un’intenzione (ammesso che sia autentica) che si può concretizzare, date le premesse conflittuali e di disaccordo. Non solo, una separazione è spesso agita e realizzata in linea con le premesse relazionali rivelatisi disfunzionali: si tratta di una premessa pericolosa perché rischia di mantenere un legame disperante (Cigoli, Galimberti, Mombelli, 1988) tra i genitori, anche una volta separati e anche se nel tempo entrambi avranno una nuova famiglia. Un percorso di coppia può supportare i partner anche verso una separazione che aiuti a portare in salvo quanto di positivo maturato nel corso del legame e a mantenere dei rapporti costruttivi per i figli.