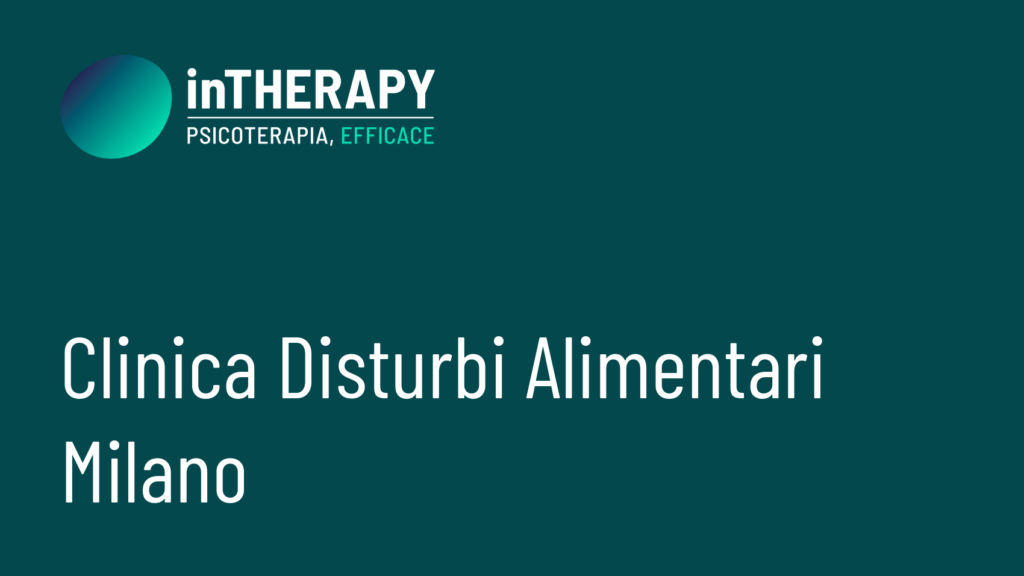Disturbi funzionali della deglutizione: il ruolo dell’ansia nel globus e disfagia funzionale
I disturbi funzionali della deglutizione sono riconosciuti come aventi un ruolo sempre più rilevante nella manifestazione di sintomi esofagei.
Noemi Boschetti – OPEN SCHOOL, Studi Cognitiva Modena
La percezione degli stimoli esofagei è un meccanismo complesso, sostenuto da processi neurali periferici e centrali, dove fattori emotivi, cognitivi e propriocettivi interagiscono tra loro.
Le manifestazioni di disagio cronico che colpiscono il tratto esofageo determinano una riduzione nella percezione della qualità di vita e generano un significativo incremento dei costi economici per la salute individuale.
I disturbi funzionali della deglutizione sono riconosciuti come aventi un ruolo sempre più rilevante nella manifestazione di sintomi esofagei (Guadagnoli, Pandolfino, & Yadlapati, 2019). La natura cronica di queste sindromi, che spesso si protraggono nonostante gli esiti negativi degli esami medici prescritti, porta molti pazienti a sperimentare una riduzione della percezione della qualità di vita e un prolungarsi della condizione di disagio (Taft, Guadagnoli,Carlson, Kou, Keefer, & Pandolfino, in press).
Ad oggi è noto che la complessità del fenomeno coinvolge l’interazione tra il cervello e il sistema viscerale, in cui i processi cognitivi e comportamentali rivestono un ruolo importante per la diagnosi e il trattamento. Tali manifestazioni cliniche comprendono una coorte di sintomi derivanti da ipersensibilità esofagea, ipervigilanza e elevata attenzione agli stimoli corporei (ibidem).
In opposizione ad altri disturbi coinvolgenti il tratto esofageo, non sono infatti dovuti ad ostruzione meccanica, disturbi nella motilità esofagea o reflusso gastrointestinale. Perciò, i meccanismi fisiopatologici alla base dei disturbi funzionali esofagei non sono ancora stati individuati con chiarezza (Guadagnoli et al., 2019).
Ipervigilanza e ipersensibilità esofagea
Dalle evidenze scientifiche è emerso che la combinazione di due processi – ipervigilanza e ipersensibilità esofagea – contribuisce allo sviluppo e al mantenimento dei disturbi esofagei (Guadagnoli et al., 2019; Taft et al., in press). Per tale motivo, validare questi fenomeni come disturbi reali e spiegarne i meccanismi psico-fisiologici alla base può facilitare una maggiore comprensione del disagio sperimentato dai pazienti che spesso giungono all’attenzione clinica.
L’ipersensibilità esofagea comprende due fenomeni: allodinia, ovvero la percezione dolorosa in risposta a stimoli di per sé non pericolosi, e iperalgesia, amplificazione della percezione di stimoli dolorosi. In generale, i soggetti possono percepire come doloroso il movimento del bolo nell’esofago. Tali sensazioni a livello del sistema nervoso centrale deriverebbero da un incremento nell’eccitabilità delle innervazioni nel midollo spinale (Aziz, Fass,Gyawali, Miwa, Pandolfino, & Zerbib, 2016) .
L’ipervigilanza esofagea consiste, invece, nell’incremento dell’attenzione diretta a sintomi esofagei. Tale fenomeno genera reazioni psicologiche, cognitive, affettive e comportamentali che sono sproporzionate rispetto alla reale minaccia dei sintomi (ibidem). L’ipervigilanza è ciclica: la persistenza dei sintomi contribuisce a mantenere un atteggiamento ipervigile ed evitante, interpretando le normali sensazioni fisiologiche come minaccia. Si instaura dunque un ciclo di rinforzo, contribuendo ad esacerbare lo stato di malessere (Taft, Triggs, Carlson, Guadagnoli, Tomasino, Keefer & Pandolfino, 2018). Processi cognitivo-affettivi maladattivi, come rimuginio, catastrofizzazione e sintomi specifici dei disturbi d’ansia, hanno un impatto significativo sull’abilità di coping rispetto a questi disturbi, contribuendo a perpetuare i sintomi (Taft et al., in press) .
Globus e disfagia funzionale
All’interno della categoria delle sindromi funzionali esofagee sono individuati diversi fenomeni accomunati da una sensazione cronica di disagio (Guadagnoli et al, 2019). Tra questi possiamo analizzare le correlazioni psico-fisiologiche ed emotivo-cognitive del globus e della disfagia funzionale.
La sensazione di globus si riferisce a una ricorrente percezione di blocco o aderenza di un corpo estraneo nella gola (Järvenpää, Arkkila, & Aaltonen, 2018). Tale condizione non è associata alla percezione dolorosa nella deglutizione (odinofagia) o difficoltà nella deglutizione del cibo (disfagia). I soggetti infatti riferiscono la comparsa di sintomi durante la deglutizione della saliva o tra i pasti. In questa condizione non sono rilevate lesioni strutturali o anormalità nella mucosa o disordini nella motilità esofagea (Aziz, et al., 2016).
Il fenomeno non è nuovo all’indagine scientifica, in quanto spesso è stato descritto con il termine di “globus hystericus”, suggerendo un’origine psicologica del sintomo (Cashman, & Donnelly, 2010). In effetti, diversi studi hanno indagato tale ipotesi, suggerendo una correlazione con quadri depressivi, alti livelli di stress e eventi di vita traumatici (Deary, Smart, & Wilson,1992; Harris, Deary, & Wilson, 1996). Alcune ricerche condotte su pazienti di sesso femminile di mezza età con percezione di globus, hanno identificato livelli più alti di neuroticismo, minore estroversione e disturbi correlati all’ansia, deflessione del tono dell’umore e preoccupazioni legate al corpo (Deary,Wilson & Kelly, 1995).
D’altra parte, le evidenze degli studi condotti sino ad oggi hanno messo in luce la complessità del fenomeno, individuando risultati parzialmente discordanti. Per esempio, emerge talvolta una sostanziale sovrapposizione tra sintomi di ansia e depressione nella popolazione medica generale, pur non presentando percezione di globus (Farkkila, Ertama.Katila, Kuusi, Paavolainen, & Varis, 1994).
Un altro fenomeno compreso all’interno della classificazione dei disturbi esofagei è la disfagia funzionale. Tale disturbo è caratterizzato dalla sensazione di un bolo solido e/o liquido incastrato o difficile da deglutire attraverso il corpo esofageo. Rispetto al fenomeno del globus si manifesta durante l’attività di deglutizione.
Le evidenze scientifiche sino ad ora raccolte mostrano un ruolo sempre più rilevante dell’ipervigilanza esofagea e ansia nella manifestazione di sintomi disfagici e nella conseguenze riduzione della qualità di vita (Taft, T. et al, in press). L’interazione tra sistema nervoso centrale e sistema viscerale contribuisce all’esordio di sindromi complesse, caratterizzate dalla percezione di disagio e legate a condizioni organiche. I processi cognitivo-affettivi possono determinare infatti un’ipersensibilità neuronale dei tratto digestivo e nei centri deputati all’elaborazione degli stimoli viscerali mediati dai sistemi centrali (ibidem).
L’ipervigilanza: relazione tra rimuginio ansioso e reattività somatica
L’ipervigilanza nei confronti delle sensazioni somatiche contribuisce ad alimentare circoli viziosi, caratterizzati da pensieri catastrofici, che sono alimentati e alimentano gli stessi sintomi corporei.
Tali processi sono caratteristici dell’ansia, che include elementi di rimuginio e preoccupazione cronica. Un quadro di ansia è comunemente caratterizzato da ipervigilanza e ipersensibilità, soprattutto rispetto alle sensazioni corporee. È noto infatti come soggetti con sintomi gastrointestinali presentino un livello alto di comorbilità con disturbi psicologici, in particolare ansia e depressione (Levy, Olden, Naliboff, Bradley, Francisconi, Drossman, et al., 2006; Pellissier, & Bonaz,2017).
Gli studi di neuroimaging hanno permesso di individuare l’interconnessione tra processi di natura psicobiologica, legati a disfunzioni esofagee, e la reattività neurale (Suntrup,Teismann, Wollbrink, Warnecke, Winkels, Pantev, & Dziewas, 2014). Nei pazienti con disfagia funzionale esaminati è emerso un incremento nella attivazione dell’insula, corteccia prefrontale dorsolaterale, corteccia premotoria e lobo parietale inferolaterale. Queste aree costituiscono l’interfaccia tra la percezione interiore dei segnali del corpo, la valutazione cognitiva, il controllo attentivo e dell’elaborazione sensomotoria superiore. Un’interazione disfunzionale in questi circuiti può risultare in una ipersensibilità esofagea e un incremento nell’automonitoraggio durante la percezione di questi sintomi e nella normale deglutizione (ibidem).
L’attività di continuo monitoraggio e la valutazione negativa di queste sensazioni generano un intenso stato di arousal emotivo, riportando continuamente l’attenzione su questi stimoli.
In presenza di una forte reattività emotiva, si instaura dunque un circuito di feedback negativo, che elicita pensieri e credenze di minaccia nei confronti delle sensazioni esofagee, sui quali si concentra il focus attentivo. Questi processi cognitivo-affettivi alimentano un circolo vizioso di pensiero catastrofico rispetto alle conseguenze dei sintomi esperiti. Tali meccanismi, sostenuti da circuiti di interazione frontale-limbica, determinano il fenomeno di ipervigilanza esofagea (Perera, Schneiderman, Sotres-Alvarez, Daviglus, Mirabal, & Llabre, 2020).
Le evidenze sinora acquisite hanno portano alcuni gruppi di ricerca (Taft et al.,2018; Taft et al., in press) a validare scale di misurazione della componente di ipervigilanza e ansia in pazienti che manifestano questo tipo di disagio. Dall’applicazione di strumenti emerge che una buona parte della varianza dei sintomi di disfagia è spiegata dalla presenza di ipervigilanza e sintomi specifici dell’ansia. Oltre a costituire un elemento trigger nella manifestazione di questa condizione, il mantenimento del focus attentivo su queste sensazioni, in combinazione con processi rimuginativi tipici dell’ansia, contribuisce ad esacerbare l’intensità e la complessità dello stesso quadro clinico. Inoltre, la riduzione nella percezione della qualità di vita è spesso associata non tanto alla frequenza e all’intensità dei sintomi stessi, bensì alla percezione e alle successive interpretazioni dei sintomi stessi come pericolosi e minacciosi (ibidem).
Altre ricerche si sono invece concentrate sulla costruzione di strumenti diagnostici, allo scopo di discriminare il fenomeno del globus da altre manifestazioni cliniche (Deary, et al, 1995; Takahashi, Mori, Baba, Sasaki, Ohno, Ikarashi, et al., 2018). Pur non emergendo una chiara correlazione con disturbi psichiatrici legati ad ansia o depressione, è stato possibile sottolineare la complessità del fenomeno e la relazione con una significativa percezione di distress somatico. D’altra parte, i risultati ottenuti negli studi successivi, maggiormente focalizzati sull’analisi dei processi alla base di tali disturbi, dimostrano che un funzionamento ipervigile e rimuginativo, tipico dell’ansia, ha ruolo significativo nella comprensione del disturbo (Taft et al, 2018; Taft et al., in press).
I trattamenti
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si possono introdurre le evidenze raccolte nell’indagine dei trattamenti più efficaci per questo tipo di disturbi.
Dalla letteratura emerge che l’impiego di tecniche ipnotiche e di rilassamento si sono dimostrate utili per la riduzione della sensazione di globus, riscontrando un alto grado di soddisfazione da parte dei pazienti (Kiebles, Kwiatek, Pandolfino, Kahrilas, & Keefer, 2010). In questi protocolli divisi in 5 sessioni, si induce uno stato di rilassamento muscolare, focalizzandosi sulla voce del terapeuta e le sensazioni corporee, utilizzando la respirazione profonda e l’immaginazione visiva. Pur non mostrando significative variazioni alle misurazioni dei parametri esofagei, i soggetti hanno infatti riportato una notevole riduzione nella percezione dei sintomi. Le tecniche di rilassamento si sono dimostrate efficaci anche nel trattamento dei disturbi d’ansia in pazienti con disturbi cronici, favorendo un maggiore senso di auto-efficacia e controllo (ibidem). Tali risultati consentono di rafforzare l’ipotesi di meccanismi cognitivo-affettivi centrale nella cronicizzazione del disagio legato a questi disturbi.
Il trattamento ipnotico condivide con il precedente intervento i benefici derivati dall’induzione di uno stato rilassamento. Il terapeuta contribuisce al restringimento del focus attentivo e all’allentamento dei meccanismi di controllo sulla mente (Palsson, & Whitehead, 2015). La componente di suggestione verbale e di immaginazione guidata sono orientate alla regolazione dell’attività della muscolatura liscia, ai fini di ridurre la sensazione di disagio elicitata dal feedback neuro-viscerale. Inoltre, con l’allentamento del rigido focus sui sintomi, il paziente può sviluppare un maggiore senso di controllo sul proprio stato di disagio.
Tra i trattamenti impiegati nella riduzione dei sintomi funzionali esofagei la CBT ha mostrato risultati efficaci che sono stati oggetto di analisi di alcune ricerche (Palsson, & Whitehead, 2015). Il focus del trattamento è spesso orientato all’individuazione dei pensieri e delle credenze disfunzionali che emergono in relazione all’attivazione somatica. L’incremento della consapevolezza dell’associazione tra pensieri maladattivi e la risposta a livello fisico ed emotivo favorirebbe un maggiore stato di benessere. Tale intervento risulta particolarmente adeguato nelle situazioni in cui si riconoscono trigger ambientali o eventi di vita stressanti, che contribuiscono ad esacerbare i sintomi a livello esofageo. L’efficacia nella riduzione del disagio è osservata in caso di comorbilità con disturbi d’ansia o depressione, per i quali la CBT è il trattamento standard.
L’attribuzione del termine “funzionale” alle sindromi comprendenti sensazione di globus o sintomi disfagici facilita l’accettazione della diagnosi da parte del paziente. La mancata individuazione di una causa organica potrebbe infatti condurre ad una svalutazione del disagio. Per tale ragione, l’analisi globale delle diverse variabili che possono correlarsi alla manifestazione dei sintomi esperiti consente di ampliare le possibilità di intervento, volte a ridurre il malessere del paziente.