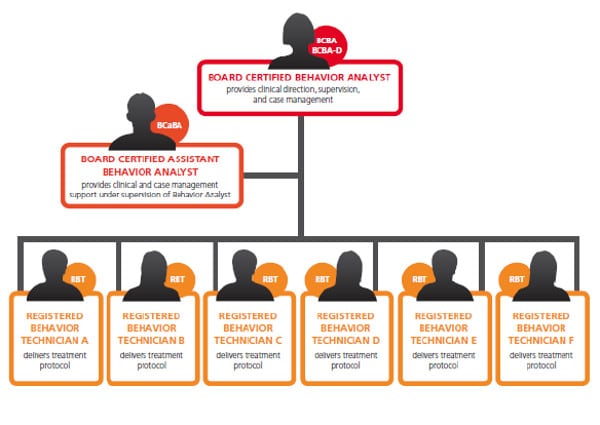L’incidenza dei media nella comunicazione politica: considerazioni sociopsicologiche
Lo studio del linguaggio nei contesti politici è importante non solo per le ripercussioni pratiche, ma anche per le conseguenze sociali che tale miglioramento potrebbe avere sul processo democratico.
Oggi viviamo in una
società che è stata definita “società dell’informazione”. La vita quotidiana, a tutti i livelli, è ampiamente condizionata dai sistemi di
comunicazione; questo è un fenomeno diffuso ovunque e non solo in quello che genericamente viene chiamato mondo occidentale.
Tra i vari aspetti della globalizzazione, emerge soprattutto quello della diffusione in tempo reale delle informazioni, della loro reperibilità e della loro utilizzabilità attraverso i mass media. Come conseguenza c’è un continuo confrontarsi dell’uomo con modelli legittimati dai mass media come attori, influencer, eroi della vita quotidiana.
La nostra, quindi, è una società che comunica intensamente, continuamente con mezzi sempre più versatili e sofisticati, e con finalità innumerevoli, derivate dal suo carattere pluralistico e dalla complessità del sistema sociale. Per questo, il tema comunicazione è un tema ripreso in ogni ambito sociale: se ne discute in politica, in economia, in dibattiti culturali, in famiglia, a scuola e in ogni disciplina. Oggi la comunicazione è diventata oggetto di moda. Da ciò è legittimo ritenere che l’espansione di questo interesse abbia rappresentato una vera rivoluzione che introduce una prospettiva di indagine radicalmente diversa che, a livello tecnologico conduce ai confini della rete internet, e a livello scientifico consente la comparsa di nuove discipline.
Questa condizione di interesse implica come conseguenza che la comunicazione rappresenti oggi un oggetto di studio interdisciplinare. In particolare, molte ragioni spiegano la necessità della comunicazione nella politica. Molti eventi delle cronache politiche, non solo italiane, come le campagne elettorali, gli esiti delle stesse, l’esplosione del fenomeno dei sondaggi politici, la crisi dei servizi pubblici televisivi, le lotte senza quartiere per il controllo dei canali televisivi, le polemiche sull’informazione schierata e conformista, le questioni etiche della professione giornalistica, gli allarmi per i pericoli della “videocrazia” mettono continuamente in cima alle priorità dell’agenda pubblica i problemi del rapporto tra politica e comunicazione.
Un rapporto al tempo stesso ineludibile e difficile, come dimostrano le tensioni che periodicamente si verificano in taluni contesti politici nazionali ed internazionali. La conquista del palcoscenico politico, da parte prima della televisione, oggi della rete dei social, avvenuta rapidamente in concomitanza con radicali cambiamenti della società e nella cultura di massa, ha profondamente cambiato i connotati e lo stesso DNA della politica. Siamo di fronte ad una variante cruciale della necessità della comunicazione, poiché la comunicazione di massa ha amplificato il ruolo della leadership nell’area politica moderna; ha selezionato molta parte delle élite politiche con criteri alieni alle logiche e agli imperativi della competizione politica, ha imposto i registri dello spettacolo alla comunicazione prodotta dagli attori politici e fruita dal pubblico dei cittadini, trasformando la natura dello “spazio pubblico” da luogo del dialogo a ruolo del consumo. Si tratta di processi di grande valenza sociale e politica, che incidono profondamente sull’universo dei rapporti all’interno delle élite politiche, sul funzionamento dei meccanismi democratici della delega e della rappresentanza e sulla qualità dell’esercizio del potere. Per queste ragioni, la comunicazione politica ha progressivamente guadagnato un importante spazio nella ricerca psicologica, ricerca caratterizzata da un elevato spessore teoretico così come da urgenze di natura pratica. Da un lato, infatti, è sicuramente importante chiarire i meccanismi psicologici di base che presiedono alla fruizione della comunicazione politica ma, dall’altro, è altrettanto prioritario mettere la scienza psicologica al servizio delle istituzioni politiche sovra-partitiche, per garantire un monitoraggio della comunicazione politica tesa al supporto della democrazia.
La letteratura si è particolarmente interessata alle dinamiche persuasive ed alle dimensioni identitarie in gioco nella comunicazione politica. Interessante, all’interno di questa tradizione, il filone di studi che fa capo a Cohen (2013) ed alla sua riflessione sui meccanismi che presiedono la costruzione dell’immagine percepita dei candidati, sempre ancorata a dinamiche di difesa del sé e del proprio ingroup.
Alcune evidenze empiriche dimostrano come la televisione, a dispetto del nascente e sempre più determinante ruolo svolto dai social media, rimanga un mezzo di comunicazione preminente per la realizzazione e fruizione della comunicazione politica. In modo particolare, uno studio di Iyengar e Simon (2000) ha dimostrato come le campagne televisive siano determinanti nel disambiguare il voto di quegli elettori indecisi o, come etichettati dai due autori americani, superficiali.
Le interviste televisive dei politici, in particolare, costituiscono una caratteristica importante della campagna politica e per tale ragione hanno da sempre calamitato un certo interesse scientifico.
In Gran Bretagna, ad esempio nei primi anni ’50, l’intervista era considerata principalmente come un mezzo attraverso il quale un politico poteva far conoscere le proprie opinioni, evitando però nel contempo le difficoltà tecniche connesse al parlare di fronte ad una telecamera senza interlocutore; lo stile di queste interviste era estremamente formale e di etichetta. Nel 1955, in conseguenza alla competizione da parte delle pubblicità, la natura delle interviste politiche viene trasformata in qualcosa di molto più aggressivo e di fatto una vera e propria sfida.
Uno dei maggiori esponenti di questo periodo è stato Sir Robyn Day. All’inizio i politici, a detta di Day, si erano trovati non proprio a loro agio, sebbene entro gli anni ’80 i politici acquisirono una sufficiente dimestichezza con questo mezzo comunicativo bastante a rendere molto più difficile la vita all’intervistatore. Di fatto i politici erano diventati molto più competenti nel maneggiare il mezzo televisivo, a prestare molte più attenzioni di prima all’impressione creata nel telespettatore, alle tecniche proprie dell’intervista, alle regole d’ingaggio a mezzo delle quali venivano condotte queste interviste e, non ultimo, nel familiarizzare col set televisivo.
A detta di Jones (1992), si aveva la netta impressione che i politici erano riusciti a mentalizzare gli intervistatori; la minaccia che gli intervistatori ponevano ai politici era stata così di molto ridimensionata. Negli ultimi decenni si è sviluppato tutto un filone di ricerca sull’intervista politica condotta non solo con noti personaggi pubblici, ma anche con persone del pubblico, le quali era la prima volta che venivano intervistate. Eppure, nonostante tutto questo fiorire di ricerca, gli studiosi si sono resi conto che ben scarsa attenzione era stata rivolta alle performances dell’intervistatore. Fa eccezione Claytman (1988-1992), che in due studi ha analizzato le maniere in cui gli intervistatori mantengono la neutralità. Altri ricercatori invece, si sono interessati dell’alternarsi dei turni all’interno delle interviste dei notiziari televisivi.
Lo studio del linguaggio nei contesti politici è importante non solo per le ripercussioni pratiche sui protagonisti e riceventi della comunicazione politica (politici, intervistatori e pubblico) in termini di miglioramento delle loro proprie performances e della loro comprensione del fenomeno, ma anche per le conseguenze sociali che tale miglioramento potrebbe avere sul processo democratico.
Si potrebbe pensare, per esempio, all’influenza che le interviste politiche, le discussioni faccia a faccia e gli altri programmi politici possono avere sull’orientamento del voto dell’elettorato, specialmente del settore degli indecisi.
Od ancora si potrebbe pensare alla rilevanza legislativa che si presenta in alcune nazioni, laddove esistono problemi sociali collegati ad indicatori qualitativi e quantitativi dell’audience, di presenza in televisione e delle diverse rappresentazioni politiche, sia in generale che in periodi pre-elettorali.
Oltre ai parametri sociali e pratici, lo studio del linguaggio politico permette l’utilizzo di test in contesti reali, che saggiano una serie di teorie socio-psicologiche sviluppate a partire da lavori sperimentali (Bavelas, 1983), più tardi poi applicate ad un contesto politico, incrementando così la validità ecologica della ricerca.
Da un punto di vista socio-psicologico, la comunicazione politica è stata affrontata a partire dai suoi legami col fenomeno dell’equivocazione.
Bavelas e collaboratori (1988), ispirati dal concetto della disqualificazione e comunicazione incongruente della scuola di Palo Alto, intendono per equivocazione una forma di comunicazione che sia vaga e tangenziale. Questo include, tra le altre cose, atti linguistici quali il contraddire se stessi, l’incongruenza, il non essere diretti, il cambiamento del soggetto, la mal comprensione, lo stile oscuro e secondo altri autori l’evasione, la circonlocuzione, l’innuendo, i proverbi e le metafore; mentre è ancora dibattuto l’aspetto intenzionale dell’equivocazione.
Quando un politico viene posto in una condizione che Lewin chiama conflitto avoidance-avoidance, il risultato è l’equivocazione. Di fatto, in alcune situazioni, l’oratore è forzato a scegliere tra due alternative indesiderabili: rispondere in maniera semplice ma incompleta, danneggiando in questo modo se stesso e il partito che rappresenta, oppure rispondere in maniera completa ma intricata e complicata, rischiando così di venir considerato evasivo ed inconcludente.
Visto che gli intervistatori politici preferiscono utilizzare proprio questo tipo di domande che mette il politico in una situazione del genere, ne consegue che il politico è forzato ad utilizzare un linguaggio equivoco. Come risultato la spiegazione che molti autori forniscono risulta una spiegazione situazionale, non sono i politici ad essere intrinsecamente evasivi, come ritiene il credo popolare, ma di fatto è la natura della situazione che costringe i politici ad essere equivoci ed evasivi. Tale linguaggio equivoco, non solo permette ai politici di evitare il conflitto avoidance-avoidance, ma anche di raggiungere altri scopi come il salvare la faccia, sia la loro che del partito di appartenenza e degli altri significativi.
Il fenomeno dell’evasione rappresenta uno dei più analizzati aspetti della letteratura socio-psicologica sulle interviste politiche. La prospettiva funzionalista (Bull e Mayer, 1993-94), definisce una domanda in funzione della sua funzione, ovvero quale richiesta di informazione. La conseguenza di questo è che la risposta diventa semplicemente l’effetto della domanda. Solo dopo aver identificato la domanda da un punto di vista di una prospettiva funzionale diventa poi possibile caratterizzare il tipo di domanda e la tipologia della risposta attesa.
Alcuni autori hanno identificato dei criteri generali attraverso i quali le risposte possono essere classificate. I criteri per la formazione dei quattro tipi di domanda (domanda di chiarificazione, domanda sì/no, domanda disgiuntiva, domanda wh), possono variare da una lingua ad un’altra, per esempio, in inglese la domanda dichiarativa si distingue dalla domanda sì/no per la diversa costruzione sintattica; mentre in altre lingue come il portoghese, il greco moderno e l’italiano, l’unico modo per differenziarle è l’intonazione: intonazione ascendente per la dichiarativa, discendente per la domanda sì/no.
Analogamente la tassonomia delle risposte dipende dalle forme base, distinte essenzialmente in risposte e non risposte, che poi dipende dall’aver fornito l’informazione richiesta o meno, a cui vanno aggiunte le risposte per implicazione che, altri autori come Pilips (1984) comunque considerano delle risposte. Le risposte che tradizionalmente vengono chiamate evasioni vengono invece incluse nelle non risposte, anche se comunque l’evasione è una modalità di equivocazione, di cui esistono anche altri tipi.
Questo solo per fare un esempio di come diversi aspetti e sfumature della comunicazione politica possano impattare il comportamento elettorale.
Guardando al futuro, sicuramente la ricerca che si occupa di comunicazione politica dovrebbe approfondire il ruolo che i social hanno in termini di influenza sociale. Alcuni si sono già cimentati nel cercare di capire (vedi, l’interessante articolo su Science uscito a firma di Bakshy e collaboratori qualche anno fa) che tipo di filtri psicologici si attivano per disambiguare notizie divergenti; indubbiamente alcuni dei processi di influenza sociale “dal basso” rimangono inesplorati e meriterebbero una maggiore attenzione.