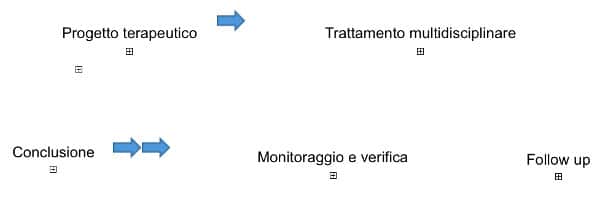Il controllo e i Disturbi Alimentari
Il controllo è una funzione estremamente utile per l’essere umano. Tutti gli individui possiedono un livello di controllo che può essere più o meno elevato, oscillando tra il polo del discontrollo emotivo e/o comportamentale e il polo dell’iper-controllo: ciò che risulta importante è muoversi tra la mediana di questo continuum ed esercitare il controllo in modo flessibile.
Il termine
controllo in ambito psicologico può declinarsi in molte definizioni. Con
controllo cognitivo, ad esempio, si indicano i processi implicati nel coordinamento di pensieri e azioni con l’obiettivo di mettere in atto un comportamento flessibile e orientato allo scopo, che sia coerente con gli obiettivi dell’individuo e le richieste dell’ambiente circostante (Puddu, 2021).
Uno dei primi autori a teorizzare il concetto di controllo in psicologia è stato lo psicologo statunitense James B. Rotter nel 1954; egli, in particolare, conia il termine Locus of control. Il locus of control di un individuo definisce la tendenza soggettiva a identificare le cause degli eventi che si verificano nella propria vita all’interno, ovvero in relazione ai propri comportamenti e azioni, oppure all’esterno, in relazione a fattori indipendenti dalla sua volontà. Secondo questa teoria, chi è in possesso di un locus of control interno sarà più propenso a considerarsi in grado di agire per modificare situazioni ed eventi, esercitando un controllo attivo sulla propria vita; chi, invece, colloca le cause degli eventi che si verificano nella propria vita all’esterno, sarà maggiormente propenso a vivere e affrontare le situazioni con atteggiamento passivo (Redazione, Locus Of Control, State of Mind).
Il controllo inteso come la capacità di inibire comportamenti indesiderati, col fine di perseguire obiettivi a lungo termine, viene invece definito autocontrollo. Esso rappresenta una qualità ritenuta di grande valore nella maggior parte delle società, in quanto consente alle persone di agire in maniera attiva e focalizzata sulla programmazione di obiettivi a lungo termine, rinunciando a quelli a breve termine, anche se questi ultimi potrebbero portare a benefici immediatamente disponibili (De Filippis, 2021).
A questo proposito, lo psicologo Walter Mischel, verso la fine degli anni ’60, ha condotto, presso l’Università di Stanford, uno degli studi più famosi al mondo sul tema del controllo, basato sul cosiddetto Test del Marshmallow. Lo studio valutava la capacità di gratificazione differita, vale a dire la capacità di resistere a una gratificazione immediata per riceverne una più grande in un secondo momento, in un campione di bambini in età prescolare. Le condizioni sperimentali erano le seguenti: il bambino riceveva un marshmallow, successivamente veniva lasciato da solo in una stanza e gli veniva chiesto di resistere dal mangiarlo; se ci fosse riuscito, ne avrebbe successivamente ricevuto un secondo. Dallo studio è emerso come i bambini, per raggiungere l’obiettivo, siano ricorsi ad ogni genere di strategia: allontanarsi dal dolcetto, non guardarlo, passare il tempo giocando o cantando una canzone.
Una parte dei soggetti sperimentali è stata poi, anni dopo, testata attraverso lo Scholastic Aptitude Test (SAT), ovvero il test attitudinale impiegato per accedere ai college statunitensi. I risultati ottenuti hanno mostrato come il comportamento assunto dai bambini durante il test sembrasse essere predittivo della tipologia di adulti che essi sarebbero divenuti, in termini di risultati scolastici e professionali (Mischel, 2014). Inoltre, un maggiore autocontrollo dimostrato durante l’esperimento correlava con un indice di massa corporea minore, livelli più alti di autostima e una maggiore capacità di tollerare la frustrazione, con una conseguente aumentata capacità di gestione dello stress, in età adulta (Mannelli, 2020).
Quando il controllo diventa un problema: ipercontrollo vs discontrollo
Si può quindi pensare al controllo come una caratteristica positiva dell’essere umano; tutti possiedono un livello di controllo più o meno presente, che oscilla tra l’estremo del discontrollo, che caratterizza le persone impulsive, tendenti a sperimentare emozioni intense e maggiormente propense a mettere in atto comportamenti rischiosi, e quello dell’iper-controllo, dove si collocano persone più introverse ed inibite, che tendono a controllare l’espressività emotiva. Ciò che sembra essere importante è la capacità di spostarsi all’interno di questo continuum, esercitando un controllo più o meno intenso a seconda delle situazioni (Alpinoli, 2021).
L’ipercontrollo è un paradigma multifattoriale complesso, veicolato da diversi fattori: biologici, ambientali e individuali, questi ultimi intesi come le differenti strategie di coping che gli individui possono mettere in campo. La tendenza a ipercontrollare può portare a reagire agli eventi di vita in modo rigido, con maggiori difficoltà a flessibilizzare il proprio comportamento al modificarsi delle condizioni ambientali esterne. L’ipercontrollo è quindi spesso associato ad una serie di conseguenze negative, come ad esempio una scarsa ricettività e una difficoltà di apertura alla novità. La persona ipercontrollante tenderà infatti a ricercare struttura e ordine e ad evitare condizioni incerte o situazioni rischiose non pianificate; può inoltre essere presente una difficoltà a tollerare le critiche, un alto livello di perfezionismo, la tendenza a pianificare rigidamente ed infine la propensione ad abbracciare rigide regole morali. Bisogna inoltre citare le possibili conseguenze a livello emotivo, come un’inibizione dell’emotività e una difficoltà a comprendere – anche su di sé – e ad esprimere le emozioni. Questo può a sua volta avere effetti a livello sociale: scarse capacità empatiche possono creare difficoltà nel socializzare e nel costruire relazioni intime, esitando in relazioni poco profonde e distaccate, che possono portare a sperimentare una sensazione di estraneità (Alpinoli, 2021).
A questo proposito, la ricerca scientifica, negli ultimi anni, si è focalizzata maggiormente sui
disturbi di personalità caratterizzati da
disregolazione emotiva, a discapito della psicopatologia con caratteristiche di ipercontrollo e inibizione. Uno
studio ha però dimostrato come la presenza di eccessivo controllo e perfezionismo sia fortemente correlata alla maggior parte dei disturbi di personalità e alla loro gravità complessiva. Anche l’inibizione emotiva è risultata presente in modo significativo in disturbi di personalità specifici, ovvero
evitante,
dipendente, depressivo e
paranoide e anch’essa correlava con la gravità complessiva del quadro clinico (Dimaggio et al., 2018).
Il polo opposto a quello dell’ipercontrollo, quello del discontrollo, è tendenzialmente associato alla messa in atto di comportamenti impulsivi, vale a dire azioni non pianificate espresse senza un’accurata valutazione delle possibili conseguenze; essi si associano spesso, quindi, a risultati indesiderabili.
In ambito psicologico l’ambito della disregolazione emotiva e degli impulsi è stato largamente analizzato da diversi punti di vista (evolutivo, sociale, clinico, psicopatologico e neuroscientifico). La letteratura scientifica ha individuato un’ampia varietà di fattori (biologici, evolutivi, relazionali, socio-culturali e ambientali) implicati nel processo di regolazione e disregolazione delle emozioni (Matarazzo, Zammuner, 2009).
Questa caratteristica è inoltre considerata un elemento transdiagnostico implicato nella psicopatologia di numerosi disturbi mentali (Moeller et al., 2001; Stanford et al., 2009; Pasino, 2021).
Le caratteristiche fondamentali dei disturbi correlati al discontrollo sono:
- L’incapacità o la difficoltà di resistere ad un impulso o ad un desiderio, con la messa in atto di azioni pericolose per sé o per gli altri;
- Una sensazione di tensione crescente che precede l’atto;
- Un’esperienza soggettiva di gratificazione o sollievo sperimentati nel momento in cui viene messo in atto il comportamento stesso; questo viene spesso vissuto come ego-sintonico e quindi dipendente dalla volontà della persona;
- Emozioni di rimorso, dispiacere o senso di colpa, che possono essere presenti una volta compiuta l’azione (Gualtieri et al., 2019).
Il controllo – o l’eccesso di controllo – in psicopatologia: un esempio incentrato sui DA
Ipercontrollo e discontrollo sembrano quindi essere agli antipodi, due modalità completamente opposte di pensare e agire. Le stesse considerazioni si potrebbero applicare, nella sfera dei disturbi alimentari, per quanto riguarda le diagnosi di Anoressia e Disturbo da Alimentazione Incontrollata; l’uno, infatti, è caratterizzato dal controllo e dalla restrizione alimentare estremamente rigidi, mentre l’altro, come dice il nome stesso, da frequenti abbuffate e perdita di controllo sulla propria alimentazione. Questa antitesi percepita nell’immaginario comune ha anche portato alla creazione di programmi TV incentrati proprio su questo. Nel programma TV americano Magri contro grassi, ad esempio, gli episodi si articolano intorno ad uno scambio di diete tra due protagonisti: una persona sottopeso, malnutrita, si trova a scambiare il proprio regime alimentare con una persona sovrappeso.
Tuttavia, nella clinica, se si osservano da vicino queste due situazioni si può notare un elemento che accomuna entrambi, ed è proprio il controllo.
Prima di tutto, un elemento che precede l’esordio del disturbo alimentare è la necessità di autocontrollo. La teoria cognitivo comportamentale dei disturbi dell’alimentazione afferma che uno dei comportamenti caratterizzanti la comparsa della maggior parte dei disturbi dell’alimentazione sia la restrizione alimentare, la quale dipende a sua volta da due elementi principali, che possono essere presenti contemporaneamente. Il primo si riscontra negli individui che sperimentano il bisogno di attuare un controllo in vari ambiti della propria vita, come ad esempio nel lavoro, nella scuola, nelle relazioni e in altri interessi; a un certo punto e in alcune circostanze particolari, queste persone cominciano a incanalare i propri tentativi di controllo nel campo dell’alimentazione. Il secondo elemento è “l’eccessiva valutazione del peso e della forma del corpo”, sperimentata dagli individui che hanno interiorizzato l’ideale di magrezza. “In tutti i casi, il risultato è l’adozione di una restrizione dietetica estrema e rigida che a sua volta rinforza la necessità di controllo in generale e del peso e della forma del corpo in particolare (Dalle Grave, 2018).”
Il fatto che i disturbi dell’alimentazione abbiano in comune la maggior parte delle caratteristiche cliniche e che nel tempo tendano a cambiare senza esitare in disturbi differenti, ha portato gli studiosi a ipotizzare che essi siano connessi ad un substrato di processi comuni. Da questo è stata elaborata la “Teoria transdiagnostica”, sviluppata in particolare da Christian Fairburn e colleghi presso l’Università di Oxford. Tale teoria colloca i disturbi dell’alimentazione in un’unica categoria diagnostica, piuttosto che concepirli come tre disturbi distinti e afferma che, per diagnosticare un disturbo dell’alimentazione, devono essere rilevati nell’individuo i seguenti elementi:
- “Disturbi del comportamento alimentare e/o di comportamenti di controllo del peso e della forma del corpo per almeno tre mesi
- Eccessiva valutazione del peso e/o della forma del corpo e/o del controllo dell’alimentazione
- Danni alla salute fisica e al funzionamento psicosociale causati dai disturbi del comportamento alimentare e/o dai comportamenti di controllo del peso e della forma del corpo
- I disturbi del comportamento alimentare e/o di comportamenti di controllo del peso e della forma del corpo non devono essere secondari a qualsiasi condizione medica generale e psichiatrica conosciuta (Dalle Grave, 2018).”
Negli individui affetti da Anoressia Nervosa, caratterizzati dal tentativo costante di controllare la propria alimentazione e di restringerla in modo rigido ed estremo, non è infrequente che questo porti a perdere il controllo sulla propria alimentazione, esitando in vere e proprie abbuffate – nel DSM-5, a questo proposito, è presente la specificazione “Anoressia Nervosa con abbuffate” – o in altri tipi di alimentazione “non pianificata”, come alimenti introdotti fuori pasto, spiluccamenti ecc. In entrambi i casi, questi episodi portano la persona a sperimentare una perdita di controllo sulla propria restrizione dietetica, con conseguente senso di colpa, e al tentativo successivo di restringere ulteriormente l’alimentazione. Questo circolo vizioso tende a ripetersi nella quotidianità e spesso a far sentire i pazienti intrappolati tra l’eccessivo bisogno di controllo e la sua perdita, interpretata come mancanza di forza di volontà, debolezza e sensazione di fallimento, risolvibile, dal loro punto di vista, solo attraverso l’applicazione di controllo ulteriore (Dalle Grave, 2018).
Le diagnosi di Bulimia Nervosa e di Disturbo da Alimentazione Incontrollata sono, invece, caratterizzate da frequenti abbuffate. Uno dei due criteri che definisce un’abbuffata è proprio la sensazione di perdere il controllo sull’atto di mangiare. Conseguentemente all’abbuffata l’individuo tenta di “ripristinare il controllo” sulla propria alimentazione, spesso in maniera rigida, ipercontrollando, con diete rigide ed estreme per porre rimedio ed evitare così un possibile aumento di peso. Il principale processo che porta ai successivi episodi di abbuffata è questo tentativo di restringere l’alimentazione, di ripristinare il controllo, con scopo di porre rimedio all’accaduto, indipendentemente dal fatto che questo determini una riduzione effettiva delle calorie assunte. Negli individui affetti da Bulimia Nervosa sono presenti anche condotte di eliminazione o compensazione, vale a dire comportamenti (vomito, abuso di lassativi o diuretici o altri farmaci, esercizio fisico eccessivo) mirati all’eliminazione del cibo assunto per evitare di aumentare di peso (Dalle Grave, Sartirana e Calugi, 2020).
“Le persone con un disturbo alimentare hanno quindi la tendenza a reagire al discontrollo con il controllo estremo, e a reagire negativamente quando rompono le loro rigide regole dietetiche, interpretando le minime trasgressioni alimentari come l’evidenza della loro mancanza di autocontrollo. Ciò favorisce a sua volta, successivamente, l’abbandono dello sforzo di controllare l’alimentazione e la comparsa dell’abbuffata, che li porta a vivere in un circolo vizioso continuo di alternanza tra controllo-discontrollo (Dalle Grave, 2018).”
Alla luce di quanto descritto e di questi esempi, la ricerca del controllo costante e rigido sul proprio comportamento, alimentare e non, può essere descritta con la seguente metafora.
Cercare di esercitare sempre e comunque il controllo estremo è come vivere con un elastico tirato fino al suo estremo. Cosa accadrebbe nel momento in cui, per qualsiasi motivo, fossimo costretti a mollare l’elastico? Esso ritornerebbe indietro, non solo alla sua condizione iniziale, ma in maniera più violenta, sconfinando nel verso opposto, ovvero quello del discontrollo.
Tutto quello che non riesci a controllare ti sta insegnando a lasciar andare.
Jackson Kiddard.