Scopi, motivazioni e metacognizione.
Ovvero, il ritorno di Pippo e la strega Nocciola
Francesco Mancini sostiene che nel cognitivismo manchi l’attenzione al concetto di scopo. In particolare critica i modelli in cui si dà particolare centralità a processi di regolazione degli stati mentali. A suo dire tali modelli trascurano quali sono gli scopi che l’individuo tenta di perseguire nel regolare questi processi; in parallelo critica i modelli che si focalizzano sulle difficoltà dei pazienti a riconoscere gli stati mentali e utilizzarli in modo adattivo (LINK ALL’ARTICOLO).
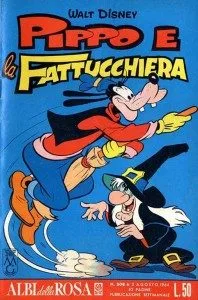
Di che si tratta? Il lettore sappia che nel mondo di Topolino le streghe esistono! Hanno poteri e si comportano da streghe. Pippo però è uno scettico radicale, non crede alle streghe. Nocciola le prova tutte per convincerlo dell’esistenza delle streghe e nei miei ricordi d’infanzia nel farlo faceva anche un minimo di paura: vola sulla scopa, materializza draghi, lo fa inseguire da mostri. Niente. Pippo è irremovibile, le streghe non esistono, sono tutti trucchi. Nocciola (colpo di genio), porta Pippo dallo psichiatra. Quest’ultimo esce dalla seduta con Pippo convinto che non esistano né psichiatri né streghe.
Perché mi viene in mente questa storia?
A mio parere il problema non è la tesi che Mancini sostiene, ma il modo in cui la sostiene, ovvero non del tutto rispettando la prima operazione che fonda il dibattito scientifico: citare correttamente le tesi degli oppositori. In mancanza di questo, dicono gli anglosassoni, si sta dando una versione “strawman” della tesi, ovvero un’argomentazione fittizia, che rende il dibattito almeno in parte falsato.
Il che mi porta a pensare che la convinzione di Mancini rischia di essere inconfutabile, perché ignora gli argomenti dell’avversario e dibatte con una loro versione caricaturale. Il motivo che mi ha spinto a rispondere è questo, dare un resoconto fedele delle tesi che Mancini tenta di confutare. Non entro nel merito dei contenuti, Mancini potrebbe avere torto o ragione, lo accetto senza problemi, purché dibatta sui fatti.
Andiamo nello specifico. La prima affermazione sorprendente di Mancini è la seguente:
[blockquote style=”1″]il vero vulnus dell’approccio cognitivista in generale, e dei filoni di ricerca citati da Ruggiero, è proprio la mancanza di attenzione al concetto motivazionale di scopo. [/blockquote]
‘Possibile?’ mi chiedo. Mi vengono in mente un paio di tipi al volo. Il primo è Giovanni Liotti. Quando sostiene, per dirne una, che la coscienza si disgreghi sotto la pressione della motivazione dell’attaccamento e il timore della risposta dell’altro, costruito come abusante, intrusivo, tirannico, minaccioso, di che sta parlando?
Direi che l’attaccamento è uno scopo, una motivazione primaria. Il bambino, pressato da segnali di fame, freddo, paura, vulnerabilità desidera (scopo) la presenza rassicurante della figura d’attaccamento. Va bene, si può sempre obiettare che Liotti non sia cognitivista, del resto ha persino pubblicato sull’International Journal of Psychoanalysis. Però la memoria mi bracca: ma Liotti non è il fondatore della Società Italiana di Terapia Comportamentale e Cognitiva? Le cose non quadrano. Può darsi allora che Liotti, che per convenzione consideriamo d’ora in poi cognitivista, sia merce rara in un mondo che ignora il concetto di scopo.
E allora che dire di Paul Gilbert? Il tipo, inglese purosangue, razza che ha generato molti cognitivisti ortodossi, ha da più di 20 anni sviluppato una teoria dei sistemi motivazionali, pure ben conosciuta in Italia (complice Liotti, sempre lui), in cui si insiste sulle radici evoluzionistiche dei sistemi motivazionali (leggi: volti al raggiungimento di uno scopo) e sull’idea che la sofferenza umana nasca dal presunto fallimento di alcuni scopi basilari, quali attaccamento, accudimento, rango sociale, inclusione nel gruppo.
Per dire: un paziente con fobia sociale desidera (scopo) essere apprezzato, prevede quasi con certezza che verrà criticato e deriso, di conseguenza si vergogna, evita il contatto sociale, soffre.
Vengo al mio specifico (e male che vada di cognitivisti che si interessano agli scopi ne abbiamo già contati tre, magari ci metto pure Benni Farina che sta contribuendo non poco agli sviluppi delle teorie sulla disgregazione della coscienza così arriviamo a quattro): da anni sostengo che in Terapia Metacognitiva Interpersonale è centrale lo schema interpersonale. Ovvero che a partire da un desiderio (scopo, motivazione), il paziente preveda che l’altro risponderà in un certo modo, tendenzialmente frustrando lo scopo, e a causa di questo soffrirà. Quindi la sofferenza soggettiva è generata dalla previsione del fallimento di uno scopo. La faccio facile, mi cito alla lettera da Terapia Metacognitiva Interpersonale dei disturbi di personalità (Dimaggio et al., 2013):
[blockquote style=”1″]Gli esseri umani agiscono sulla scena sociale guidati da scopi e desideri e da credenze sulle condizioni che permetteranno o meno di realizzare quei desideri. [/blockquote]
Si tratta forse della psicologia scopi/credenze invocata costantemente da Mancini? A me sembra di sì. Devo ammettere che nel libro “I disturbi di personalità: Modelli e trattamento” la centralità del concetto di scopo non era così chiara, motivo per cui nello sviluppo più recente della TMI abbiamo ben pensato di non lasciare spazio ad equivoci. Però forse non sono cognitivista. Mi vengono dei dubbi.
Immagino però facilmente che anche i cognitivisti di stampo, diciamo “Wellsiano” vorranno rispondere alle critiche di Mancini (e quindi supereremmo i quattro cognitivisti che credono all’importanza del concetto di scopo). Per sicurezza nel frattempo mi sono riletto il post di Gabriele Caselli sul pensiero desiderante.
A parte che già parlare di pensiero desiderante mi dà l’idea che si parli di scopo, ma poi quando Caselli scrive che chi abusa di sostanze o soffre di dipendenze comportamentali fa “uso dell’attività o della sostanza per staccare la mente da preoccupazioni o stati di disagio” i dubbi mi paiono fugati. Non si sta usando il concetto di scopo? Mi sa che siamo già a cinque cognitivisti (e che Caselli lo sia sfido chiunque a negarlo) ad usare il concetto di scopo.
E questa era facile. Un altro dibattito infinito con Mancini, purtroppo mai abbastanza certificato per iscritto, ma avvenuto durante congressi, riunioni di lavoro e ristoranti (Francesco, per inciso, è un brillante conversatore e un ospite piacevolissimo) è il concetto di problema metacognitivo. Mancini è abbastanza diretto nel dire che:
[blockquote style=”1″]Il concetto di scopo è cruciale per la spiegazione della sofferenza psicopatologica mentre processi e credenze non sono sufficienti. Questo limite, a mio avviso, è presente in larga parte degli studi sui deficit cognitivi o metacognitivi, nei quali si sottovaluta che i processi cognitivi e metacognitivi sono orientati dagli scopi dell’individuo, e dunque quello che appare come un deficit può dipendere da un uso dei processi cognitivi al servizio degli scopi dell’individuo.[/blockquote]
Mi sento chiamato in causa. E anche qui le prove sono a mio vantaggio (non le prove che la tesi dell’esistenza della disfunzione metacognitiva siano decisive, le prove che Mancini sta attribuendo ai suoi interlocutori delle posizioni che li descrivono in modo inaccurato). Mi cito di nuovo (sempre dallo stesso libro):
[blockquote style=”1″]La metacognizione come concepita nella TMI descrive, invece, la capacità umana di utilizzare gli stati mentali per attribuire significato a eventi personalmente rilevanti e di utilizzare tale conoscenza nel corso di interazioni reali emotivamente calde. Le persone possono infatti avere in laboratorio capacità di ragionamento mentalistico, ma poi non usarle nella vita quotidiana, dove sono realmente necessarie, o non usarle con la velocità necessaria. [/blockquote]
Quindi la metacognizione ci interessa quando si attiva nel ragionare su eventi che per noi sono importanti, ovvero, aggiungo, riguardano il destino dei nostri scopi. Nel libro aggiungo: “le persone compiono atti metacognitivi nel contesto di tutti i sistemi motivazionali (per esempio, rango, sessualità, appartenenza al gruppo)”, ovvero la riflessione sugli stati mentali è rilevante in psicopatologia quando è carente in situazioni che riguardano il potenziale fallimento di scopi cari alla persona.
Più avanti ancora sono più esplicito sulla relazione-dipendenza della disfunzione metacognitiva:
[blockquote style=”1″]D’altro canto, l’attivazione della percezione di pericolo relazionale” è necessario aggiungere, la percezione della possibile compromissione di scopi di sicurezza personale ? – “in cui ci aspettiamo che l’altro ci attaccherà, abuserà di noi, ci vorrà dominare, che sarà uno straniero pericoloso appartenente a un gruppo sociale ostile, restringe la nostra mente e ci porta a pensare che la mente dell’altro sia abitata da intenzioni ostili o malevoli e abbia un set limitato di stati mentali (Liotti, Monticelli, 2008; Liotti, Gilbert, 2011; Lysaker, Gumley, Brüne et al., 2011).[/blockquote]
A proposito, Mancini nel post aveva scritto: “ad esempio un paranoico può apparire povero della capacità di comprendere gli altri, perché attribuisce solo e sistematicamente intenzioni ostili, anche laddove non vi è alcun ragionevole segnale di ciò”. Suona straordinariamente simile alle mie parole, vero? Allora perché Mancini sostiene che in ambito metacognitivo non si tenga conto di queste idee? Saperlo.
Ancora più espliciti, certe cose le ho proprio scritte: “L’idea che la metacognizione, o mentalizzazione, sia contesto-dipendente e legata allo stato affettivo e motivazionale è centrale nella TMI”. Adesso, Mancini avrà tutto il diritto di dissentire e contestare l’esistenza di qualcosa chiamata disfunzione metacognitiva, ma almeno lo faccia citando correttamente le fonti. Insomma, Pippo nega che la strega Nocciola faccia malefici, ma il drago è un drago!
Però può sempre essere che io non faccia testo. Prendiamo allora l’esempio di Liotti e Gilbert (sempre due che hanno scritto pagine marginali nella storia del cognitivismo internazionale e italiano). In un articolo del 2011 contenuto in un numero speciale su metacognizione e mentalizzazione che ho curato con Paul Lysaker e Andrew Gumley (Gumley, per inciso è cognitivista), i due sostengono che le capacità di mentalizzazione dipendono in gran parte dal contesto motivazionale in cui si dispiegano. Un esempio degli autori è una donna che può ben comprendere gli stati mentali dell’altro quando è guidata dallo scopo di accudire (caregiving mentality) e fallire nell’attribuire stati mentali se coinvolta in interazioni competitive (ovvero guidata da scopi di rango sociale, dominanza/sottomissione).
Sempre pochi cognitivisti a sostenere la stato-dipendenza della disfunzione metacognitiva? Elena Prunetti – per dire, oggi responsabile della sede della scuola SPC di Verona (quindi direi che Mancini una smucinata al suo curriculum l’avrà data), nel 2008 pubblicava su Psychotherapy Research
un lavoro empirico in cui emergeva come sotto la pressione della motivazione dell’attaccamento, innescata dalla percepita vicinanza del terapeuta validante, le capacità metacognitive di pazienti borderline andassero incontro ad un declino momentaneo.
Per onestà va detto che nel libro del 2003 “I disturbi di personalità” si usava il termine deficit, che dà molto l’idea di pezzo rotto e questo darebbe valore all’obiezione di Mancini. Infatti da quel momento in poi ho cercato di evitare l’uso del termine deficit, sostituendolo con termini quali: disfunzione, fallimento, carenza che più facilmente si prestano a descrivere il contesto di dipendenza del problema. Va detto che in letteratura in lingua inglese credo che il termine deficit sia usato con una connotazione più funzionale.
Bateman e Fonagy hanno sempre parlato di deficit di mentalizzazione e tutti sanno che hanno sempre insistito sull’attaccamento-dipendenza del problema. A proposito, Mancini invoca che si faccia chiarezza nel distinguere tra metacognizione e mentalizzazione. Perché mai ho affrontato il problema definitorio – con molti colleghi – in almeno una decina di articoli e Mancini non ne cita neanche uno?
La cosa che Mancini manca di riconoscere, e che ahimè negli anni è stata oggetto di molte conversazioni di cui non è rimasta traccia (di solito non uso registrare le cene e i meeting di lavoro) è che il vero uso che si fa del concetto di metacognizione nella clinica dei pazienti non psicotici (dove il pezzo rotto un po’ di più c’è) è di tipo performance. In termini semplici: molti pazienti nel momento in cui avrebbero bisogno di dispiegare conoscenza sugli stati mentali in modo accurato, veloce e flessibile, non lo fanno e questo è un problema.
Se il paziente evitante sotto stress non sa definire la propria emozione altro che in termini di disagio, ben difficilmente potrà adottare strategie alternative all’evitamento comportamentale. La disfunzione sarà probabilmente potenziata dalla pressione ad evitare il giudizio critico, ma poi chi ci dice che una volta che questa pressione sia calata, diventi spontaneamente in grado di definire le proprie emozioni se nessuno gli ha insegnato a farlo?
Vice versa, se per anni a causa dell’isolamento sociale per timore del giudizio (scopo di preservare l’autostima dalla critica) poi, quando mi riaffaccio nel mondo e voglio corteggiare una ragazza… che ne so di come funziona la mente delle ragazze? Mettiamo che ho superato la paura. Ma resta il mancato allenamento. Dottore, dice il paziente, ora temo meno di essere rifiutato, ma non so come si fa!
La disfunzione metacognitiva è anche questa e va affrontata, riattivata, potenziata, in parallelo al lavoro sul cambiare punto di vista sulle credenze riguardo al mancato raggiungimento dei propri scopi. Almeno dalla prospettiva di chi scrive, la dicotomia che propone Mancini tra una psicopatologia scopi/credenze e una psicopatologia deficit funzioni mentali superiori è falsa.
Infine: è stato dimostrato che le abilità metacognitive dipendono dal contesto motivazionale, dal sistema di credenze, dall’arousal attivo? Ad oggi no. Ed è un obiettivo delle ricerche dei prossimi anni.
ARTICOLI CONSIGLIATI:






