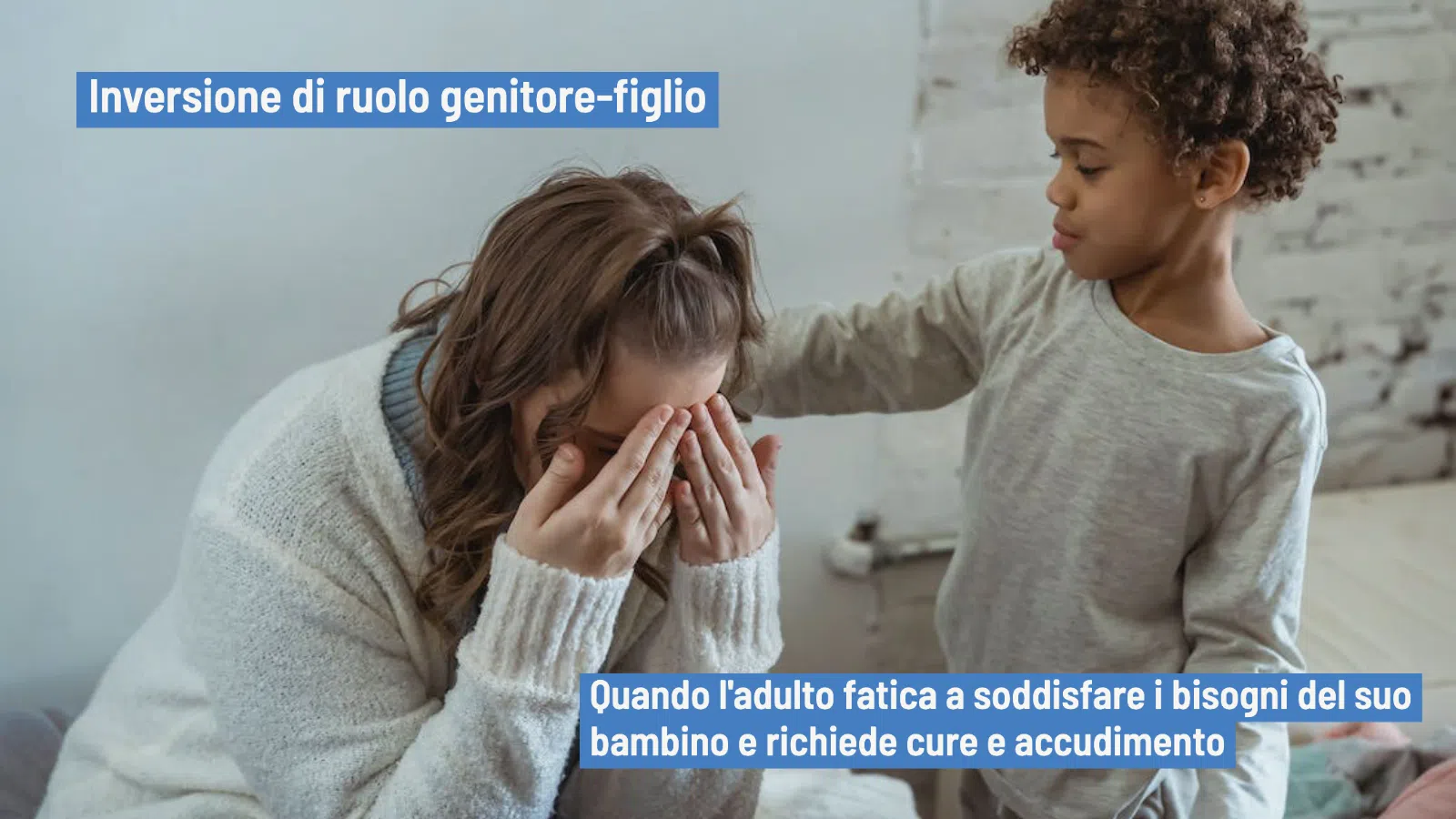A volte mi capita di essere il confidente della mia mamma, soprattutto da quando mamma e papà hanno divorziato…e quante cose brutte mi dice sul mio papà! La mia mamma è spesso triste e a me non piace vederla così, quindi invece di giocare, le sto sempre vicino e cerco di farla ridere. Alla fine, nessuno capisce la mia mamma come la capisco io: mi posso prendere io cura di lei.
Questo bimbo ci sta mostrando forme di inversione di ruolo: ma che cos’è questo fenomeno? Vediamolo insieme.
La relazione genitore-bambino
I bambini, durante il loro sviluppo, sperimentano un lungo periodo di dipendenza fisica e psicologica da chi li accudisce (Bellow et al., 2005) e così, nel tempo, si sviluppa una relazione genitori-figlio, estremamente importante per un sano sviluppo del bambino (Macfie et al., 2015). Infatti, il modo in cui i genitori (o altri caregiver primari) interagiscono con il loro bambino influenza il suo sviluppo socio-emotivo (Macfie et al., 2015). Può capitare però che l’adulto, nell’accudire il figlio, fatichi a soddisfare i bisogni socio-emotivi del suo bambino o non sia in grado di soddisfare tali bisogni in modo ragionevolmente efficace (Bellow et al., 2005). Di conseguenza, il bambino potrebbe sviluppare un modello comportamentale chiamato “inversione di ruolo” (Macfie et al., 2015).
Che cos’è l’inversione di ruolo?
Come dicevamo, può succedere che ci sia una rottura dei ruoli attesi tra genitore e figlio: il bambino viene così elevato a un ruolo simile a quello di un adulto, incaricato di soddisfare i bisogni del genitore (Jurkovic, 1997; Kerig, 2005; Minuchin, 2012). Quando questo avviene, si assiste a ciò che fu definito negli anni Sessanta con il termine “inversione di ruolo” (Morris & Gould, 1963).
Nel tempo sono stati poi coniati diversi termini per riferirsi a questo fenomeno come: “bambino genitore” (Earley & Cushway, 2002), “parentificazione” (Bellow et al., 2005; Boszormenyi-Nagy & Spark, 1973), “genitore come coetaneo” (Earley & Cushway, 2002; Kerig, 2005) e “genitore come coniuge” o “spousification” (Kerig, 2005; Macfie et al., 2015).
Tutti i termini sopra citati evidenziano un cambiamento nei ruoli genitore-figlio in cui il bambino sacrifica i propri bisogni di attenzione, conforto e guida per soddisfare e prendersi cura dei bisogni strumentali (ad esempio, cucinare, pulire, occuparsi dei fratelli più piccoli) e/o emotivi del genitore (ad esempio, dare consigli, confortare e rassicurare, tenere compagnia al genitore; Alexander, 2003; Mayseless et al., 2004).
L’inversione di ruolo tra normalità e disfunzionalità
In generale, l’inversione di ruolo non è considerata patologica di per sé (Jurkovic, 1997; Robinson & Chase, 2001): questo fenomeno fa parte di un processo normativo nella socializzazione dei bambini, che li porta a diventare membri responsabili e moralmente adatti delle famiglie e della società (Jurkovic, 1997). Si è evidenziato, infatti, l’appropriatezza dell’assunzione di responsabilità familiari che rientrano nelle capacità di sviluppo del bambino e che non interferiscono con il suo sviluppo, contribuendo alla formazione di un’identità sana, di una buona autostima e di un senso di autoefficacia e di competenza (Bellow et al., 2005; Macfie et al., 2005, 2015). Di conseguenza, è considerato sano e appropriato che il bambino soddisfi, in qualche misura, i bisogni emotivi del genitore, ma questo deve essere bilanciato dalle cure che il bambino riceve dal genitore stesso (Earley & Cushway, 2002).
Questo processo normativo diventa inversione di ruolo distruttiva quando la relazione genitore-figlio manca di reciprocità emotiva e/o quando le richieste e le aspettative superano le capacità del bambino (essendo inadeguate alla sua età) verificandosi a spese del soddisfacimento dei suoi bisogni di sviluppo (Bellow et al., 2005; Macfie et al., 2005, 2015). Il bambino si trova quindi a tenere il “carico emotivo della relazione”, aumentando il rischio di psicopatologia (Jurkovic, 1997).
Precursori dell’inversione di ruolo: il contesto
L’inversione di ruolo è stata associata a molti tipi di disfunzioni familiari (Alexander, 2003). I fattori che, ad oggi, risultano associati all’inversione di ruolo sono principalmente: il genere del bambino, il conflitto coniugale, il maltrattamento infantile, la storia di perdita o trauma dei genitori e la malattia organica e/o mentale dei genitori (Macfie et al., 2015).
Per quanto riguarda il genere del bambino, sembrerebbe che le figlie femmine abbiano un maggiore propensione all’inversione di ruolo, poiché ci si aspetta che le donne nutrano e mantengano le relazioni (Buchanan et al., 1991). Nonostante ciò, essa può avere un effetto più deleterio sugli uomini (Chodorow, 1999).
Anche il conflitto coniugale sembrerebbe essere associato all’inversione di ruolo, soprattutto nella relazione madre-figlia: quando i genitori sono impegnati in un conflitto, aumenta la probabilità che i figli si alleino con le madri contro i padri (triangolazione; Alexander, 2003; Macfie et al., 2015). In particolare, questo fenomeno risulta associato anche a disfunzioni familiari tra cui il divorzio e stili genitoriali “intrusivi” (Alexander, 2003; Jacobvitz & Sroufe, 1987; Weiss, 1979).
L’inversione di ruolo, inoltre, sembrerebbe più probabile in famiglie maltrattanti: abusi e maltrattamenti dei genitori rappresentano tipologie di disfunzioni familiari a cui si associa l’inversione di ruolo del bambino (Morris & Gould, 1963), soprattutto l’abuso fisico e l’abuso sessuale (Burkett, 1991; Macfie et al., 1999). A tal proposito, si è visto anche che i genitori che hanno subito abusi da bambini hanno una maggiore probabilità di dipendere dai figli per la cura emotiva, soprattutto se esperiti dalle madri (Bellow et al., 2005; Burkett, 1991). Infatti, storie parentali di traumi o perdite infantili (come abusi subiti dai genitori e la morte di un genitore), sembrerebbero potenziare la confusione di ruoli poiché il genitore, faticando ad elaborare la propria esperienza, si affida al figlio per trovare conforto (Burkett, 1991).
Un ultimo fattore che può creare un contesto di inversione di ruolo è la malattia mentale dei genitori come alcolismo, abuso di sostanze, sintomi depressivi e ansiosi, disturbo borderline di personalità, schizofrenia (Earley & Cushway, 2002; Macfie et al., 2015; Mayseless et al., 2004), mostrando il genitore come una figura vulnerabile e bisognosa di aiuto.
Esiti nel breve termine e nel lungo termine dell’inversione di ruolo
In generale, l’inversione di ruolo rappresenta un importante fattore di rischio che può portare a compromissioni sullo sviluppo del bambino (Macfie et al., 2005, 2015): sembrerebbe che l’inversione di ruolo interferisca con lo sviluppo dell’autonomia e dell’individuazione (sviluppo del sé) nel periodo della prima infanzia e questo può a sua volta influenzare futuri problemi di sviluppo, come problemi di autoregolazione nel periodo prescolare (Jacobvitz & Sroufe, 1987; Macfie et al., 2015). In caso di inversione di ruolo patologica, sono state associate conseguenze significative per il bambino come depressione, bassa autostima, pensieri suicidari, isolamento sociale, sintomi psicosomatici e sintomi esternalizzanti come il disturbo della condotta o l’iperattività (Bellow et al., 2005).
Alcuni studi (per esempio, Earley & Cushway, 2002) hanno poi dimostrato l’esistenza di effetti a lungo termine dell’inversione di ruolo: la responsabilità di accudimento da bambini sembrerebbe influenzare il funzionamento di un individuo nelle relazioni adulte. In particolare, è stato osservato che da adulti tendono a continuare ad adottare comportamenti di cura compulsivi nelle relazioni con altre persone adulte in età più avanzata: questo fenomeno viene definito come “sindrome del prendersi cura” (Earley & Cushway, 2002). Inoltre, sembrerebbero mostrare una formazione dell’identità meno coesa con livelli inferiori di esplorazione della propria identità ed essere esposti ad un maggior rischio di disturbi di personalità, depressivi e ansiosi (Bellow et al., 2005; Macfie et al., 2005; Mayseless et al., 2004).
Conclusione
In definitiva, l’inversione di ruolo può essere sia normale, sia disfunzionale e ha una maggiore probabilità di presentarsi in contesti specifici (Bellow et al., 2005). Questo fenomeno si manifesta nei primi anni di vita, può influenzare lo sviluppo dall’infanzia all’età adulta e si trasmette da una generazione all’altra (Macfie et al., 2015). Tuttavia, ad oggi, non è ancora chiaro come la traiettoria evolutiva differisca per l’inversione di ruolo patologica rispetto a quella non patologica (Bellow et al., 2005).