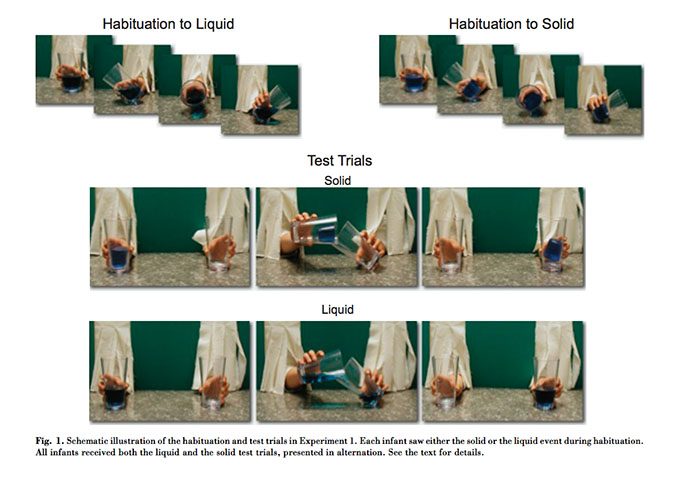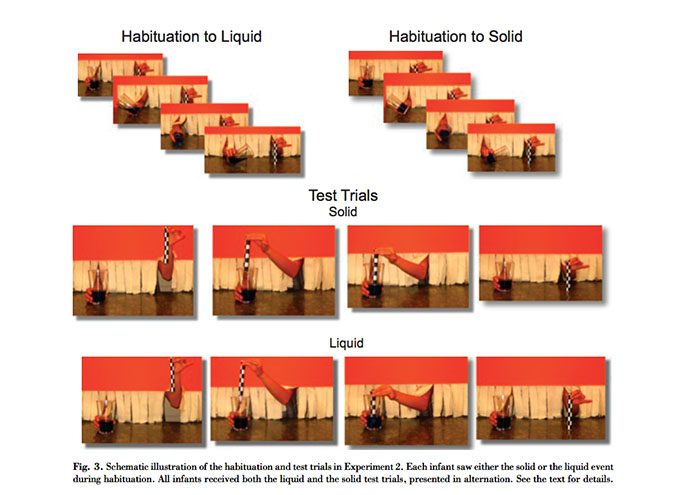Linguaggio Schizofrenico e Psicoterapia d’Intervento: dalla struttura del linguaggio al contesto clinico
Le caratteristiche del linguaggio schizofrenico sono un elemento nodale per l’inquadramento clinico e il successivo orientamento tecnico/terapeutico in corso di trattamento; le sue specificità contenutistiche e le peculiari organizzazioni sintattiche differiscono totalmente da quelle di altre patologie cliniche in ambito mentale.
Il linguaggio schizofrenico: introduzione
Il linguaggio schizofrenico è, più di ogni altra organizzazione comunicativa patologica, il portato tangibile dell’esperienza psicotica interna rispetto alla realtà oggettiva, soggettiva e intersoggettiva. In questo articolo, esaminando la schizofasia, ovvero l’uso schizofrenico del linguaggio e la sua propria forma di retorica, forniremo un quadro di riferimento comunicativo-diagnostico con alcune specificità d’intervento proprio in relazione alla comunicazione terapeuta-paziente nelle psicosi schizofreniche.
Psicofisiologia: la funzionalità schizofrenica
Le teorie, i modelli e gli approcci psicodinamici circa la schizofrenia sono numerosi ed essendo obiettivo di questo articolo il linguaggio schizofrenico in quanto tale, e la tecnica di interazione nel trattamento relativa, è opportuno volgere inizialmente l’attenzione sulla funzionalità psicofisiologica di tale disturbo tramite le evidenze sperimentali e strumentali capaci di fornire comunanze cliniche circa ogni scuola. Iniziamo col dire che gli studi sperimentali accreditati sembrano indicarci come i disordini del linguaggio schizofrenico siano in stretto rapporto con due elementi nodali: la modalità delirante, propriamente detta, con un disturbo formale positivo del pensiero.
Ciò a dire che è la perdita dei nessi associativi tra le idee e la “delimitazione” concettuale delle idee stesse a determinare le forme del linguaggio schizofrenico incoerente, illogico, tangenziale, deragliante, eccentrico (Bleuler 1985; Andreasen, Grove 1986); a questo dobbiamo aggiungere le analisi propriamente linguistiche – sintattiche e di associazione nei test carta/matita (anche simbolici) che hanno evidenziato come il pensiero disorganizzato, il deficit della memoria (a breve e a lungo termine) sarebbero apprezzabili indicatori di una condizione clinica meritevole d’attenzione, ciò specialmente per quanto riguarda test di valutazione dei ricordi e del linguaggio narrativo (Hoffman et al. 2011).
Più specificatamente, a livello di analisi strumentale, l’attivazione cortico-somatosensoriale, sui processi di organizzazione e controllo dell’azione, è stato dimostrato come abbia notevole ruolo nelle cinestesie, nei fenomeni di improvvisa “deriva” cognitivo-sensoriale e nelle allucinazioni uditive, ciò sino ad avere diretta e conseguente influenza nella stessa produzione linguistica schizofrenica (Frith 2004). L’esame alla risonanza magnetica funzionale (f MRI) avrebbe evidenziato due elementi centrali:
un’anomala attività delle aree cerebrali temporali e un’anomala attività delle zone parietali dell’emisfero sinistro (parte posteriore del giro temporale con specificità d’attività nel medio).
Questi due elementi sarebbero in relazione con la presenza delle allucinazioni uditive e con i fenomeni di dissociazione delle rappresentazioni lessicali e semantiche (Wible 2008). La conferma, indiretta ed incrociata, di questi elementi funzionali ci viene dall’utilizzo dei potenziali evento-correlati (ERPs) che confermano i problemi di memoria semantica (N400) e di comprensione verbale (P600) con disturbi d’onda emessa in P300 e ciò a livello delle aree: corticali temporali, frontali e parietali dell’emisfero sinistro (Sitnikova,2010; Ditman et al. 2011; Liddle et al, 2002).
Linguaggio schizofrenico: clinica psicoterapeutica
Le primissime osservazioni cliniche circa la schizofrenia inducevano a teorizzare una sorta di disturbo non specifico dell’organizzazione del linguaggio (Wible 2008), non del tutto distinguibile da un progressivo degrado delle funzioni cognitive. Tale sovrapposizione di elementi definì il termine di dementia o dementia precox. Il linguaggio schizofrenico infatti manifesta elementi semantici estremamente caratteristici ma difficilmente comprensibili in prima battuta e suscettibili di confusione con un deterioramento meccanico-funzionale delle capacità cognitive e di relazione (Frith 2004). Oltre la scarsa trasparenza dei segni linguistici, della loro incomprensibilità, del fatto che essi sembrano dei giochi di parole meta-ricorsivi, vi è la possibilità di trovare un senso condivisibile e terapeuticamente funzionale al linguaggio schizofrenico.
Nelle manifestazioni schizofreniche il significato delle costruzioni linguistiche rimane latente, oscuro, ambiguo; fatti, circostanze, ricordi, idee e sentimenti si perdono nella particellazione di un discorso che finisce col perdere il valore semantico comune e condiviso per privilegiare invece gli aspetti strutturali, esteriori. Allo stesso tempo non sembra avere molta importanza per lo schizofrenico la presenza e il riferimento a un altro da sé: in tali casi il coinvolgimento relazionale si conclude con le esperienze dissociative dell’Io, con il ritiro in sé del soggetto poiché l’altro – sia esso una persona o un evento qualsiasi – è percepito invariabilmente come alieno; si tratta di una struttura/processo in perenne divenire ove disgregazione e ristrutturazione ideativo/emotiva procedono per picchi dai nessi associativi del tutto interni, personali ed arbitrari.
Gli schizofrenici possono adoperare, nel corso della stessa seduta, un registro formale, manierato, incomprensibile, autoreferenziale come anche espressioni esplicite di uso corrente, estremamente dirette pur nella loro brevità e semplicità concettuale. Questo particolare flusso linguistico è il vero e proprio “andamento” della patologia stessa, ovvero il nucleo delirante dissociativo che incorpora, assembla, frammenti percettivi ed ideativi alimentando, ingrossando e contaminando il flusso interno di informazioni. È proprio questo, la labilità dei nessi associativi nelle idee, che favorisce l’overinclusion di elementi concettuali ridondanti, non contestuali o destrutturanti che determinano la rilevabile distorsione dei contenuti rappresentativi, simbolici, espressivi del discorso schizofrenico e si risolvono nei processi linguistici schizofasici (Cameron, 1944).
Questa area di confusività circa il linguaggio schizofrenico è da riferirsi all’uso massivo e alla ricorrenza delle seguenti strutture semantiche ascritte propriamente in questo disturbo, ovverosia:
neologismi;
paralogismi;
lapsus linguae.
Nodali, e ricorrenti, tra le strutture presentate sono i paralogismi (o parafasie) ovvero termini che assumono arbitrariamente il suono (fonema), il referente (reale o immaginario) e il significato (come anche il significante) di altre parole e/o suoni usati altrove correntemente, ciò soprattutto in modo quasi mai connesso a un contesto specifico o argomento. Nella pratica clinica che accoglie ed interagisce col paziente schizofrenico, si colgono enunciati incentrati nella forma di locuzioni olofrastiche, come anche le cosiddette druse verbali, queste ultime estremamente ed ulteriormente peculiari poiché sono “neoformazioni” di parole o di frasi condensati tra loro che, ad una prima analisi, rimandano ad una pluralità di concetti assemblati e confusi tra loro al fine di enucleare un solo e personalissimo concetto (Hoffman et al.2011). Queste ricorrenze e specificità di strutture semantiche destrutturano e frammentano – proprio come è il disturbo schizofrenico – la linearità concettuale e semantica della frase sino a condurre ad un inanellamento di micro concetti, estremamente brevi e all’apparenza non collegati tra loro, in una successione diversa dagli stimoli ambientali o dal referente in campo (Piro 1967).
Il focus del linguaggio schizofrenico non è tanto a livello della struttura sintattica delle frasi ma, piuttosto, ad un livello più profondo che tocca il senso individuale e il significato condivisibile, complessivo, dell’esperienza personale delirante per riflettersi, poi, in quello peculiare della parola come atto comunicativo e di azione nel mondo, con un costante ed inarrestabile rimbalzo del significato delle parole e delle espressioni verso categorie sempre più generiche e dai significati sfumati e/o confusi.
Si viene così a strutturare un “discorso” permeato di un “alone semantico”, senza un preciso inizio e senza reale fine:
– metalinguistico: una parola sottintende un’altra e da questa un’altra ancora in uno spostamento continuo di argomento e contesto.
– ambiguo: non vi è referente chiaro nelle asserzioni e il termine appena detto è metafora dell’altro a venire.
– allusivo: il significato di una parola o frase non è mai identificabile, il discorso è perennemente aperto ad ulteriori interpretazioni.
indeterminato: le frasi sono spesso neutre, senza chiara valenza di positività o negatività di opinione o vissuto verso qualcosa o qualcuno.
Da cui ne deriva la quasi completa dispersione del significato nel discorso schizofrenico.
Questo flusso continuo ma spaiato di concetto/i-contesto/i origina il vero e proprio “alone semantico” fatto di concatenazioni linguistiche incomprensibili, in forme glossolaliche, ovvero le specifiche e rilevabili “lingue” schizofreniche.
Cosa intendiamo con forme glossolaliche associate alle lingue schizofreniche?
Intendiamo (Cameron, 1944; Piro 1967; Hoffman et al.2011) l’insieme di flussi linguistici incomprensibili ma ben strutturati sintatticamente, tali da configurarsi come vere e proprie protolingue legate a un uso referenziale (delirante e allucinatorio) assolutamente privato e molto difficilmente condivisibile sul piano esperienziale e comunicativo. Esempi di questi flussi linguistici e protolingue sono:
– strutturare frasi al contrario
– usare una protolingua creata ad hoc e ciò con particolare riferimento ad una persona che condivide questa modalità o tendenza
– intervallare una frase positiva con una di senso avverso, alternando una lingua ad un’altra o mimando voci
– sottrarre consonanti o vocali (o anche entrambe ma secondo regole numeriche, ad esempio) ad una frase o discorso
– il “pensare” una parola, o frase, e disegnarla con la lingua sulla parete interna dei denti o praticare uno “spelling” lettera per lettera usando i denti
– il “mimare” una parola o frase agendola in tutto e per tutto in una rappresentazione catartica/isteroide di tipo delirante, con conseguenti manifestazioni ed effetti di irrefrenabile euforia o tristezza o disperazione oppure una vera e propria crisi.
Linguaggio schizofrenico: psicoterapia d’intervento
L’approccio terapeutico, inteso come identificazione-accoglienza della patologia ed interazione clinica con essa, deve essere centrato sull’importante distinguo relativo all’alterità del soggetto circa l’altro (un Tu referente) e del mondo (il contesto in vivo) (Andreasen N.C., Grove W.M., 1986; Frith C.D. 2004). In altre parole per lo specializzando in psicoterapia – sia psicologo che psichiatra – è opportuno sempre tenere in conto la “distanza” (o prossimità implicita) che il soggetto schizofrenico e/o paranoide stabilisce ed agisce nelle sue fasi, siano esse episodiche.
In altre parole: nella pratica clinica è la presenza o meno di un tu, rispetto ai discorsi ed affermazioni, del paziente ad orientare il dialogo clinico e strategico.
L’assenza totale di un Tu nella mente schizofrenica rimanda al già enunciato concetto di Nevrosi Narcisistica di freudiana memoria.
Il linguaggio schizofrenico è l’implosione di un soliloquio senza cornice, dove significante e significato si fondono e confondono in una progressione ora lenta, ora veloce, ora ricca ora povera di termini (Sitnikova,2010; Ditman et al. 2011; Liddle et al, 2002). Il clinico avrà la necessità di considerare la fertilità ed “espansione” stessa di questo eloquio anziché il significato reale di questo, come a dire che sarà la frequenza e flusso del linguaggio a determinare il livello di dialogo tra paziente e terapeuta ponendo a parte la pretesa – pur giusta e logica ma in questo caso fuorviante – del “cosa significa tutto questo”. Il significato del suo linguaggio, per lo schizofrenico, è il contatto continuo col suo mondo interno imploso e il tentativo, ora discreto ora inefficace, di “organizzarsi” internamente in una struttura coerente, stabile, capace di scambio.
Rispetto alla schizofrenia la difficoltà è e sarà sempre far concentrare il soggetto su di un referente reale, normativo se si vuole usare questo termine, dialogante e solido, ed in questo è la difficoltà sostanziale di un’alleanza terapeutica e processo terapeutico continuativo con obiettivi terapeutici raggiungibili (Wible C.G., 2008).
Le specifiche psicopatologiche derivanti dall’analisi del linguaggio schizofrenico e le conseguenti attenzioni/azioni cliniche, ad esso relative, sono presentate, esposte e specificate in quanto segue:
– Il linguaggio non ha un referente, non c’è un Tu cui si è rivolti (C. McDonald, K.Schulze, R.M. Murray, P. Wright, 2004)
– I significati e significanti tra loro sono scambiati, interpolati ed espansi
– Non vi è una cornice contestuale di riferimento
– Il confine Io-Tu è abbattuto da percezioni corporee al limite della cinestesia e l’accadimento psicologico è anche l’accadimento psichico e viceversa (C. McDonald, K.Schulze, R.M. Murray, P. Wright, 2004)
– L’eloquio non ha un perché, non ha un tangibile ed intellegibile significato immediato. Il clinico deve “imparare” quella forma particolare di linguaggio soggettivo di quello specifico paziente come fosse una lingua nata e sviluppata in base ad una storia di sofferenza mentale (Wible C.G., 2008).
– Il linguaggio schizofrenico porta comunque una particolare forma di condivisione e disvelamento di eventi traumatici, di conflitti passati e presenti come, anche, del cosiddetto “segreto terapeutico” ovvero del nucleo cognitivo/affettivo restante che serba l’evento traumatico psicologico. Il clinico deve avere disposizione alla massima attenzione ai concetti e sfumature di essi poiché è nelle pieghe di questo linguaggio che risiedono informazioni preziosissime pur non manifeste (C. McDonald, K.Schulze, R.M. Murray, P. Wright, 2004).
– Annotare le forme grammaticali ricorrenti ed i termini maggiormente utilizzati dal paziente. Sono nodi linguistici e concettual-esperenziali che si ripropongono con una certa frequenza, la chiave di accesso alla relazione col paziente schizofrenico è in queste ricorrenze (Wible C.G. ,2008).
A seguito di queste ricorrenze e stabilita una anche pur labile forma di alleanza terapeutica, il clinico sposterà l’attenzione del setting terapeutico e del paziente stesso sui referenti di questi nodi concettuali ed esperenziali, identificando le figure di riferimento a tali nodi (C. McDonald, K.Schulze, R.M. Murray, P. Wright, 2004).
– Mappa Comunicativa: rappresentare graficamente, con uno schema, l’eloquio schizofrenico ed i suoi contenuti (la sintassi, i termini, le ricorrenze, i referenti) aiuterà a creare una mappa d’intervento con e sul paziente. Vi si troveranno almeno due o tre ricorrenze che dovranno poi essere integrate in una ideale life-spam line timing (linea del tempo del paziente, vita e cicli vitali), andando a porre enfasi sulla sequenza di eventi occorsi nella storia clinica sì da individuare i punti di “frattura” interna e le debolezze dell’Io circa la progressione del disturbo (C. McDonald, K.Schulze, R.M. Murray, P. Wright, 2004).
– Creare un ambiente di riferimento stabile (spazio): ciò significa assicurare allo schizofrenico un ambiente il più stabile, coerente e persistente nel tempo possibile. I dialoghi, i confronti o le conversazioni troppo animate devono essere evitate; bisogna rivolgerglisi con fare calmo e parole semplici, frasi brevi, spiegando semplicemente ciò che si fa o si sta per fare (J.S. Kasa-nin, 2012).
– Creare un ambiente di referenza stabile (tempo): indispensabile è provare a stabilire e a far ottemperare qualche minima regola riguardante l’igiene, le sigarette, scandire la giornata con attività di routine normative ed integrative (sveglia, igiene personale, attività intermedie, pasto, passeggiate, ecc.) (J.S. Kasa-nin, 2012).
– Dialogare senza Effrazione: questa specificità è nodale nel setting terapeutico ma è anche una consegna e modalità di relazione che, nel caso vi siano, deve essere volta a familiari ed amici. Un dialogo senza effrazione verbale è un dialogo percepito dallo schizofrenico come non invasivo e facilita, nel quadro di una terapia farmacologica e psicoterapeutica, una strutturazione ideativa. Critiche, imposizioni, minacce il più delle volte non sono nemmeno percepite mentre, in fase fertile, possono essere restituite al contesto in gravi crisi o atti distruttivi. La preferenza va data agli incoraggiamenti piuttosto che alle rimostranze (C. McDonald, K.Schulze, R.M. Murray, P. Wright, 2004; J.S. Kasa-nin, 2012).
– La Risorsa Sistemica: la cerchia di familiari e amici gioca un ruolo importante nel far rispettare le prescrizioni farmacologiche, gli appuntamenti terapeutici e di follow up. Ridondante è la questione della terapia farmacologica e ciò essenzialmente per i relativi e commisurati effetti collaterali, alcuni sono transitori, scompaiono dopo qualche giorno di trattamento, altri possono essere corretti con farmaci o devono condurre a modificare la terapia. Se un’altra persona, in casa, segue un qualsiasi tipo di altra terapia, può essere utile instaurare un momento in comune per l’assunzione dei farmaci, al fine di ridurre i rischi di dimenticanza o negligenza (C. McDonald, K.Schulze, R.M. Murray, P. Wright, 2004; J.S. Kasa-nin, 2012).
– Nella crisi schizofrenica (Piro S., 1967; J.S. Kasa-nin, 2012) è spesso agitato, angosciato, in preda ad allucinazioni o a idee deliranti. Le azioni concomitanti debbono essere tese a contenere onde evitare un suo aggravamento ulteriore o passaggi all’atto. Quindi attenersi a quanto segue:
a) è preferibile essere soli col paziente, anche se ci sono persone in una stanza vicina, e rassicurarlo parlandogli dolcemente nel modo più normale possibile;
b) nessun contatto fisico o fissarlo negli occhi o prossimi fisicamente, men che meno bloccare le uscite (ciò per evitare che il paziente si senta minacciato e per proteggere la persona che è con lui/lei);
c) esprimere empatia, chiedendo cosa c’è che non va o commentando ciò che sente (n.b. riformulazione sull’evidenza:“Hai paura?”), senza moltiplicare o complicare le domande o iniziare dialoghi. Formule semplici, ripetute in modo identico, ciò contiene e minimizza ulteriori destabilizzazioni (Piro S., 1967; J.S. Kasa-nin, 2012).
Conclusioni
La struttura e il significato delle proposizioni schizofreniche, e delle sue molteplici variazioni e declinazioni schizofreniformi, invitano se non impongono allo specialista una curva specifica di neo-apprendimento e dimensionamento dell’intervento su specifiche, sia psicopatologiche che d’intervento. Un’analisi della psicofisiologia specifica del disturbo schizofrenico, gli studi su questo specifico meta-linguaggio – e sulle sue dislocazioni psicopatologiche – facilitano la clinica alla progettazione ed attuazione di un piano terapeutico e d’intervento. Il cogliere contributi multidisciplinari, direziona ed agevola nella ipotesi diagnostica e di cura, alla costruzione, ogni volta sempre più specifica a seconda del caso, di un attuned intervention ove il generale della patologia e il particolare del soggetto possono incontrare adeguata risposta ed aumentata efficacia.