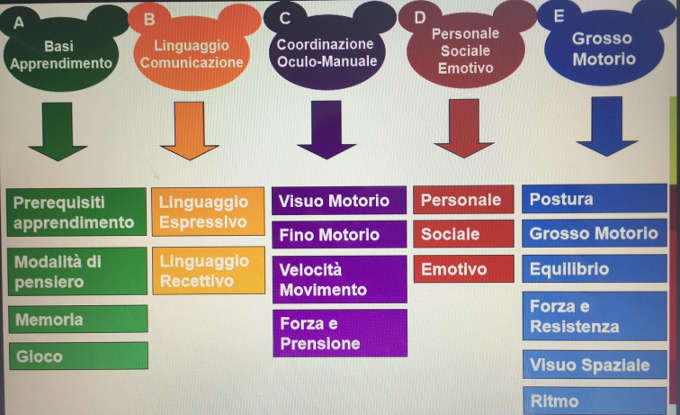Infezione da HIV: effetti psicologici e psicopatologie associate
Nei pazienti sieropositivi si osservano diverse patologie psichiatriche, suddivisibili in patologie secondarie all’ infezione da HIV e all’ingresso in AIDS conclamato e patologie più generiche che possono colpire tutti quanti soffrono di malattie croniche.
Anna Greppi – OPEN SCHOOL Psicoterapia Cognitiva e Ricerca Milano
Infezione HIV e AIDS: uno sguardo al fenomeno
Il virus dell’immunodeficienza umana HIV (HIV, sigla dell’inglese Human Immunodeficiency Virus) è l’agente responsabile della sindrome da immunodeficienza acquisita, AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome).
È un retrovirus del genere lentivirus, che da origine a infezioni croniche, che sono scarsamente sensibili alla risposta immunitaria ed evolvono lentamente e progressivamente. Se non trattate, possono avere un esito fatale. In base alle conoscenze attuali, l’
HIV è suddiviso in due ceppi:
HIV-1 e
HIV-2. Il primo dei due è prevalentemente localizzato in Europa, America e Africa centrale;
HIV-2, invece, si trova per lo più in Africa occidentale e Asia e determina una sindrome clinicamente più moderata rispetto al ceppo precedente.
Nel 2012 si stima che circa 35,3 (32,2-38,8) milioni di persone nel mondo vivono con l’ infezione da HIV, numero che risulta essere in costante crescita. Sono calate del 33% le nuove infezioni da HIV rispetto al 2001 – da 3,4 milioni di persone a 2,3 (1,9-2,7) milioni circa-. Per quanto riguarda i bambini, negli ultimi 11 anni le infezioni sono calate del 53% (sono 260mila nel 2012). Si è riscontrata anche una diminuzione del 30% i decessi collegati all’ AIDS rispetto al picco del 2005 – sono 1,6 (1,4-1,9) milioni nel 2012 (Global Report 2013 del Joint United Nations Programme on HIV/AIDS UNAIDS,ONU).
Per quanto riguarda la situazione italiana, nel 2012 risultano esserci circa 94.146 persone affette in Italia da HIV o AIDS, di cui il 70,1% sono maschi e l’84,3% sono di cittadinanza italiana. La modalità di trasmissione più frequente è quella eterosessuale nella percentuale del 37,2%, i Men who have Sex with Men (MSM – uomini che fanno sesso con gli uomini) sono il 27,7%, mentre i consumatori di sostanze per via iniettiva (INU) sono il 28,5% (Raimondi et al., 2013)
Con l’introduzione, nel 1996, in Italia, delle nuove terapie antiretrovirali (HAART- Highly Active Antiretoviral Therapy) è aumentata la sopravvivenza delle persone che vivono con l’ infezione da HIV ed è diminuito il numero dei decessi correlati all’ AIDS, trasformando così l’ infezione da HIV in una malattia cronica.
Il presente articolo si propone di evidenziare gli effetti psicologici e le possibili psicopatologie correlate all’ infezione da HIV, passando in rassegna alcuni studi in questo ambito.
Patologie psichiatriche associate a infezione da HIV
Nei pazienti sieropositivi si osservano diverse patologie psichiatriche, suddivisibili in patologie secondarie all’ infezione da HIV e all’ingresso in AIDS conclamato e patologie più generiche che possono colpire tutti quanti soffrono di malattie croniche. Al primo gruppo appartengono mania secondaria, psicosi, delirium e demenza complex. Al secondo reazione acuta da stress, disturbo dell’adattamento e depressione maggiore.
Psicopatologie secondarie all’infezione da HIV
La mania secondaria si presenta con una prevalenza del 1,2% nei sieropositivi e del 4,8% nei soggetti con AIDS. E’ un disturbo psichiatrico che segue ad alterazioni organiche o assunzioni di farmaci, che per essere definito tale deve perdurare per almeno una settimana ed è caratterizzato per la presenza di umore elevato o irritabilità e da almeno due dei seguenti sintomi: iperattività, logorrea, grandiosità, insonnia, distraibilità e alterato giudizio.
Nel paziente HIV possono svilupparsi psicosi funzionali, considerate reazioni a infezioni da HIV, collegate all’azione diretta del virus a livello del SNC (diminuite in era HAART). Per ultimo si può manifestare il Delirium e la Demenza Complex, complicazione tardive della malattia.
Il trattamento d’ elezione per questo tipo di patologie è quello farmacologico, spesso complementare al trattamento dell’intero quadro sintomatologico. Il trattamento psicologico e psicoterapico subentra in questo caso con la funzione di gestione dell’intera malattia.
Patologie generiche tipiche delle malattie gravi e croniche
La malattia cronica viene spesso vissuta come un’esperienza che “esplode” dentro, come una realtà che opprime e fa sentire impotenti. Nascono nell’individuo degli interrogativi nuovi relativi al significato dell’esistenza e a ciò che ha guidato fino a quel momento la vita personale e relazionale del paziente.
In concomitanza l’individuo, divenuto “paziente”, sperimenta l’impatto con le cure. La persona malata inizia quindi a vivere sospesa tra un tempo presente, vissuto come un “non tempo”, e padrone assoluto del suo esistere, e un tempo passato carico di obiettivi, a volte di progetti che spesso non è stato possibile portare a compimento (Borgna, 2000).
Il paziente si trova a fare inevitabilmente i conti con il sentimento del limite dei suoi progetti di vita e ad interrogarsi sulla necessità dei progetti passati, in un confronto critico sui valori che hanno informato la sua esistenza fino a quel momento.
La malattia, dunque, rappresenta un tipo particolare di evento di vita stressante che può mettere seriamente alla prova le capacità di adattamento del singolo individuo.
La reazione adattativa ad una malattia richiede sempre al paziente un lungo lavoro emotivo e fisico, intenso e difficile, e tiene conto di vari elementi quali: tipo e stadio della malattia, ospedalizzazione o altro tipo di assistenza, consapevolezza della malattia, struttura della personalità, meccanismi di difesa e loro livello evolutivo e funzionale.
Per quanto riguarda la sieropositività, all’atto della comunicazione della diagnosi, il paziente può presentare diverse reazioni psicologiche (Spizzichino, 2008).
Lo shock per la diagnosi ricevuta, si manifesta con agitazione, collera, pensieri ed espressioni di incredulità e pianto. Il paziente può entrate in uno stato confusivo che non aiuta in un momento in cui è necessaria concentrazione per prendere decisioni importanti rispetto alla propria salute. Confusione che tende ad abbassarsi in presenza di una buona comunicazione alla diagnosi e l’offerta ed inizio di un buon percorso psicologico.
Si possono riscontrare rabbia e frustrazione relative al fatto di essersi infettato, per le nuove restrizioni nello stile di vita, per doversi sottoporre sempre alle terapie, per l’incertezza sul futuro, per l’ostilità, il pregiudizio degli altri.
Può manifestarsi il senso di colpa nell’interpretare l’accaduto come una punizione, per i comportamenti a rischio avuti, per la paura di poter infettare gli altri.
E’ spesso presente l’ansia e la paura riguardo alla prognosi incerta e il decorso severo, per gli effetti collaterali legati alla malattia, per la paura del rifiuto sessuale, per la perdita della capacità cognitive, fisiche e lavorative.
Si può presentare poi depressione legata all’idea di dover fare i conti con una malattia cronica, l’impossibilità di guarigione, con i limiti imposti dalla malattia, con un possibile rifiuto sociale La diminuzione dell’autostima, perdita dell’identità e di sicurezza sono altre reazioni spesso riscontrabili all’atto della comunicazione della diagnosi.
Infine, raramente, si possono manifestare disturbi ossessivo compulsivi nella forma di pensieri continui e disturbanti relativi alla morte, il fallimento, la ricerca di nuovi trattamenti, terapisti e medici, controlli ripetuti per sintomi sempre nuovi (Spizzichino, 2008).
Alcune di queste reazioni possono essere transitorie, altre più durature e potranno andare a caratterizzare l’intera vita con il virus. E’ possibile che la vulnerabilità sia legata anche a precedenti esperienze del paziente riguardo a malattie e traumi. Altre variabili che possono determinare il tipo di reazione sono la personalità, il temperamento, la flessibilità, le risorse sociali, famigliari e occupazionali, il sostegno disponibile.
La reazione all’ infezione da HIV e il processo di accettazione
Sono stati individuati alcuni stili di reazione all’ infezione da HIV, ed è stato riscontrato che lo stile adottato è predittivo dell’eventuale successivo benessere psicologico e fisico (Spizzicchino, 2008).
I pazienti che utilizzano lo stile evitante hanno livelli in generale più elevati di preoccupazione riguardo alla salute, ai problemi esistenziali, verso gli amici e verso se stessi. Manifestano notevole depressione, autostima bassa e difficilmente ricevono del sostegno psicologico. I pazienti invece che adottano uno stile attivo-cognitivo costruiscono delle difese mentali e fanno affidamento sul pensiero cognitivo e spesso sviluppano pensieri ossessivi e ruminazione.
Infine gli individui che sono capaci di sviluppare uno stile attivo-comportamentale hanno un migliore tono dell’umore, un minor numero di preoccupazioni, una più alta qualità della vita percepita e livelli di autostima più alta.
L’evoluzione psicologica del paziente con infezione da HIV dovrebbe terminare con la fase di accettazione e adattamento. Tale evoluzione può essere spontanea ma è certamente facilitata da più variabili individuali e ambientali, quali le caratteristiche di personalità del paziente, le caratteristiche socioculturali del paziente e la presenza di un adeguato supporto sociale e in particolare la presenza di persone affettivamente significative
Questa fase è caratterizzata da un abbassamento del livello di tensione emotiva che consente la modificazione dei comportamenti a rischio e alla corretta applicazione alle norme profilattiche. Non è una condizione stabile e dipende dal decorso della malattia.
L’avvento degli antiretrovirali ha apportato delle grandi trasformazioni nella vita delle persone sieropositive. Grazie ai benefici della terapia farmacologica alcune delle persone abituate a convivere con l’incertezza del futuro e con la precarietà della salute e della vita stessa, persone che cercavano si prepararsi alla morte, si trovano a doversi confrontare con i problemi e le situazioni, anche positive, che questa pone. Il trattamento farmacologico nel momento in cui si è dimostrato efficace nel prolungare la sopravvivenza e nel migliorare la qualità della vita ha dato la possibilità di iniziare una seconda vita e ha dato luogo in molti pazienti della sindrome di Lazzaro.
E’ stato dimostrato attraverso l’uso della metodologia dei focus group che la prospettiva delle terapie HAART rende necessario rinegoziare le speranze e le aspettative riguardo al futuro, i ruoli e le identità sociali, le relazioni interpersonali e la qualità della vita. Emergono soprattutto tematiche relative ai rapporti sentimentali (possibilità di diventare genitori, avere l’aspettativa di rimanere abbastanza in vita per poter crescere un figlio) e l’assunzione di nuovi ruoli sociali.
Tutti questi fattori possono rappresentare un motivo di stress o di disturbi mentali (Brashers et al., 1999). Studi successivi sull’impatto psicosociale dell’HAART hanno evidenziato il ruolo centrale della speranza del futuro (Fernandez, 2001) anche se permane nelle interviste incertezza ed ansia circa i benefici sulla salute e quindi sul senso della speranza. In un altro lavoro (Rabkin et al., 2000) si è osservata un’evoluzione positiva dello stato psicologico nei termini di tono dell’umore, speranze e soddisfazione in chi non mostrava un miglioramento con la terapia. Gli autori ipotizzano che la prospettiva di seconda vita porta con sé una serie di difficoltà potenzialmente stressanti per chi vede confermato il miglioramento fisico anche dai numeri (conta dei CD4) rispetto a chi ritiene di avere ancora poco tempo da vivere poiché i parametri continuano a essere poco confortanti.
Non è stata verifica una correlazione diretta tra salute mentale e infezione HIV. Ci sono delle persone che nonostante siano affette da HIV conservano la speranza, sperimentano un maggiore senso di benessere, partecipano più attivamente alla gestione della malattia e si dimostrano in grado di occuparsi della propria salute (Carson et al., 1990). Una ricerca che prevedeva una serie di interviste a donne sieropositive (Siegel & Schirimshaw, 2000) ha evidenziato che , pur riconoscendo le conseguenze negative dell’infezione, molte di loro riferivano che la malattia aveva cambiato le loro vite in modo positivo e riportavano un generale miglioramento della loro vita che si è concretizza in un aumento del numero di relazioni instaurate e coltivate, una maggiore forza percepita, un più alto senso di responsabilità e più capacità di entrare in relazione con altri.
La valutazione psicologica delle persone con infezione da HIV
E’ centrale attuare un’attenta valutazione psicologica delle persone con infezione da HIV anche per evitare diagnosi di patologie non presenti, etichettature scorrette, interventi non necessari o risposte standardizzate.
La difficoltà consiste nel fatto che dei sintomi somatici correlati alla presenza del virus e degli effetti collaterali delle terapie richiamano ai disturbi psicologici veri e propri. Le reazioni depressive in questa popolazione si caratterizzano spesso come un senso di disperazione riguardo al futuro o una percezione di mancanza di controllo sul corso della propria vita. I disturbi somatici correlati ad esse (anoressia, insonnia, depressione, disturbi della memoria, sudorazione notturna) sono molto difficili da differenziare dalle manifestazione delle infezioni. Lo stesso si osserva nel caso dei disturbi d’ansia. Questa difficoltà diagnostica in alcuni casi ritarda i percorsi di presa in carico psicologica e psicoterapica.
Altro elemento da tenere in considerazione nella valutazione clinica, è il rischio suicidario. Le motivazioni possono essere diverse a seconda della fase in cui si trova il paziente. In uno studio con poco meno di 3.000 sieropositivi (Carrico ed al., 2007) si è riscontrato che il 19% di essi ha ideazioni suicidarie nella settimana precedente.
I disturbi più frequenti in pazienti con HIV
I disturbi più frequentemente diagnosticati in persone con infezione da HIV sono i seguenti:
- Il disturbo acuto da stress può presentarsi in qualunque fase della malattia anche se è più frequente immediatamente dopo la diagnosi o in concomitanza con degli aggravamenti. Il quadro sintomatologico può consistere in rabbia, senso di colpa, paura, diniego e disperazione. Data la variabilità dei sintomi non è possibile reperire dati sulla prevalenza di questo disturbo.
- Il disturbo dell’adattamento è caratterizzato da ansia, insonnia e depressione e di solito ha un decorso benigno. L’incidenza si attesta intorno al 4-10 % (Lipsitz et al. 1994) e nelle popolazione sieropositiva che si rivolge ai servizi di salute mentale è di circa il 30%.
- Per quanto riguarda i disturbi depressivi i dati sulle prevalenze sono divergenti in quanto variano tra il 30% e il 61% (Rosenberger et al., 1993; Dew et al., 1997). Nell’ambito dei disturbi di ansia si riscontrano episodi di ansia della durata di un mese o la prevalenza è molto è bassa se si prendono in considerazione strettamente i criteri del DSM-IV-TR e potrebbe dar conto della disparità dei diversi risultati dei vari studi sul tema (4-73%) (Cohen et al., 2002). Abuso di sostante e alcol sono presenti nella popolazione sieropositiva rispettivamente nella percentuale del 22%-64% e nel 29%-60% e si presentano tendenzialmente in comorbidità con altri disturbi. La variabilità dei tassi di prevalenza dei diversi disturbi può essere messa in relazione con l’eterogeneità metodologica degli studi presi in considerazione ( Spizzichino, 2008).
Secondo la letteratura internazionale le donne sieropositive risultano essere più a rischio per quanto riguarda i disturbi psichiatrici rispetto agli uomini. E’ stato dimostrato che le donne positive presentano più spesso degli uomini ansia, depressione, eccessiva sensibilità, disturbi paranoidi e somatizzazione. E’ stato sottolineato inoltre che le donne si rivolgono ai servizi sociali per la salute mentale meno degli uomini (Havens et al., 1996).
Sono state fatte varie ipotesi su questa distribuzione. Uno studio (Faithfull, 1997) ha riscontrato tre fattori ulteriormente stressanti per le madri con infezione da HIV quali la difficoltà di rivelare la propria sieropositività ai figli, la paura di infettarli e la possibilità che la malattia infici la capacità di prendersene cura e di crescerli.
In letteratura si riscontra la presenza di almeno un disturbo psicologico nella vita di una persona con HIV in percentuali che vanno dal 38% al 73% di tutti i pazienti che sono stati studiati (Gallego et al, 2000). L’esordio della psicopatologia nella maggior parte dei casi è antecedente alla sieroconversione (Rosenberger et al., 1993). Sono stati identificati dei fattori associati allo sviluppo dei disturbi mentali nelle persone positive quali il supporto sociale scarso, la storia psichiatrica precedente, l’uso di meccanismi quali l’evitamento e il diniego, una rapida progressione dell’infezione ed esperienza di lutto per AIDS.
Uno studio in quattro città degli Stati Uniti, su un campione di 1000 donne HIV, ha messo in luce una relazione tra la sintomatologia depressiva e l’esperienza di sintomi fisici dell’infezione e loro grado di intrusività percepita nella vita dei pazienti (Remien et al., 2006). Il benessere psicologico delle persone positive in terapia antiretrovirale dipende più che dalla situazione in sé da variabili cognitive e comportamentali, quali la soddisfazione riguardo al sostegno sociale, l’idea della punizione relativa alla malattia e il grado di integrazione della malattia nella propria vita e nella percezione di sé (Safren et al, 2002).
Molti lavori hanno analizzato l’associazione tra problemi di salute, strategie di coping e reazioni allo stress durante il decorso di malattie come il cancro, l’artrite reumatoide, l’infarto del miocardio e l’ infezione da HIV. Sono stati riscontrati risultati molto simili tra le diverse patologie. Generalmente le forme di coping evitante sono associate a maggiore stress mentre quelle focalizzate sulle emozioni sono a livelli minori di quest’ultimo. Una posizione attiva e l’attitudine a considerare nel modo più positivo possibile la situazione hanno delle influenze benefiche sul tono dell’umore rispetto alla fuga e all’evitamento.
Nello specifico dell’infezione dell’HIV si è potuta osservare una correlazione positiva tra la percezione di un buono stato di salute e tre stili di coping: il focalizzarsi su altro, il pensiero positivo e la gestione della malattia (Phillips et al. 2001). E’ stato verificato che strategie di coping maladattive da parte di persone sieropositive diminuiscono notevolmente la qualità della vita relativamente al funzionamento cognitivo, salute mentale e stress legato al lavoro.
In conclusione, dalla rassegna presentata, emerge come la sieropositività sia ancora un problema largamente diffuso, sia nel mondo che sul territorio italiano e di come la scoperta dell’infezione vada ad incidere non solo sulla salute fisica ma anche su quella mentale. Occorre quindi, da parte di tutti gli operatori, che si occupano a vario titolo delle persone sieropositive o malate di AIDS, porre attenzione non solo al livello generale di salute ma anche al benessere psicologico, messo in pericolo dalle conseguenze di una malattia cronica ed a oggi incurabile. Ciò per costruire e implementare percorsi di accompagnamento psicologico e psicoterapico che consentano a questi pazienti di raggiungere il miglior livello di benessere possibile e che si integrino ai percorsi tradizionali di cura previsti per chi soffre di questa patologia.