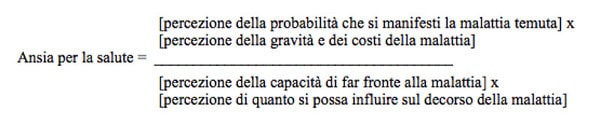La dipendenza e lo stile comportamentale – Fatica a credito: storie parziali di dipendenza patologica
Una persona, anche quando non usa sostanze, continua ad essere condizionata da determinati processi cognitivi, continua ad attribuire determinati significati alle esperienze e continua a provare determinate emozioni in risposta ai contesti in cui interagisce.
FATICA A CREDITO: STORIE PARZIALI DI DIPENDENZA PATOLOGICA – (Nr. 4) La dipendenza e lo stile comportamentale
– Alice, ma tu ogni tanto impari qualcosa dalle tue esperienze passate o cosa?
– Cosa.
(Carroll,1865)
Molti comportamenti, atteggiamenti e schemi di pensiero del soggetto tossicodipendente sono osservabili anche quando il paziente attraversa un periodo di astinenza dall’uso. Si possono rilevare le modificazioni neurobiologiche causate dall’uso di
sostanze stupefacenti e i disturbi psicopatologici o di personalità sottostanti, ma è altrettanto importante osservare come l’uso e l’abuso di droghe imponga all’individuo di vivere e di relazionarsi in un ambiente ed in un contesto tossico in cui vengono favoriti, suggeriti e privilegiati determinati comportamenti.
Vivere nella tossicodipendenza impone delle regole molto rigide, anche per proteggersi.
Dire che la tossicodipendenza è un problema di forma e non solo di sostanza, significa che è possibile rintracciare nel paziente astinente dall’uso, atteggiamenti e comportamenti che solitamente emette quando utilizza sostanze.
Queste modalità comportamentali, derivanti dai contesti di vita e relazionali del paziente, spesso sono le uniche che egli ha appreso o le uniche che conosce, e possono esprimersi automaticamente (o inconsapevolmente).
Potremmo dire che, nonostante l’interruzione dell’uso di sostanze, permane nel paziente uno stile di comportamento, una rigida modalità di attribuire significato alle esperienze.
Puoi togliere il ragazzo dal ghetto ma non puoi togliere il ghetto dal ragazzo (Z. Ibrahimovic).
Smettere di usare sostanze, decidere di modificare il proprio rapporto con il mondo ed essere motivati e disponibili ad impegnarsi per questi obiettivi, è necessario ma non sufficiente al fine di ricostruirsi una vita.
Il paziente anche quando non usa sostanze, continua ad essere condizionato da determinati processi cognitivi, continua ad attribuire determinati significati alle esperienze e continua a provare determinate emozioni in risposta ai contesti in cui interagisce.
E’ facile rilevare come permanga una traduzione distorta di temi importanti nelle relazioni umane, come la fiducia, l’onestà, la tolleranza della frustrazione o la capacità di condividere e raccontare se stessi. Il paziente resta attaccato a codici e convinzioni che riducono o alterano la sua possibilità di emanciparsi dal contesto da cui proviene, rendendo difficoltosa la sua decisione di trasferirsi in un contesto differente.
Si osserva un vero e proprio deficit di conoscenza rispetto a contesti diversi da quelli correlati all’uso di sostanze, il paziente appare a corto di alternative quando deve relazionarsi in un contesto altro, quando deve decifrare i processi di una relazione interpersonale, è spaesato come di fronte ad un compito in classe che non sapeva di avere.
Un cambiamento ha bisogno di un’alternativa, si smette di fare una cosa perché se ne può fare un’altra, senza un’alternativa praticabile, o almeno immaginabile, si resta congelati nella posizione in cui si è, ripetendo le stesse azioni aspettandosi un risultato diverso.
Inoltre, non si può evitare di considerare che questi pazienti hanno una scarsa o inesistente capacità di sognare, prefigurarsi o decidere obiettivi futuri che non dipendano dal loro umore del momento.
Queste persone, essendo sopravvissute ed essendo state spesso modellate da contesti ambientali in cui venivano trascurate, criticate, punite e disprezzate, non sono state incoraggiate a sognare o a tradurre le loro idee e qualità personali in percorsi di vita che rispondessero al meglio alle loro caratteristiche.
In un ambiente invalidante, infatti, comunicare un (grande) sogno può avere come risultato critiche ed umiliazioni.
Nel tempo queste interazioni dolorose possono creare un’associazione tra il fatto stesso di immaginare il futuro e il senso di umiliazione e delusione che ne deriva.
In un contesto tossico ci sono poche verbalizzazioni e regole rigide che hanno strutturato comportamenti e risposte automatiche, paradossalmente il paziente è lì che ha colmato il suo bisogno di regolarsi, in quei luoghi conosce anticipatamente i segnali con cui orientarsi.
Quando si trasferisce in un altro contesto, per lui non così etichettato e standardizzato, si trova a fare i conti con tutta una serie di sfumature inconsuete, si trova di fronte a relazioni umane in cui deve imparare a capire gli altri mentre si relaziona con loro, si aggira in una complessità su cui deve riflettere e sulla quale ha meno conoscenze e certezze.
In queste situazioni incerte, in cui il paziente riceve segnali ai quali non sa come rispondere o che si prestano a più interpretazioni valide, la paura prenderà il sopravvento e favorirà le solite alternative: fuggire e/o aggredire.
Quando l’istinto di fuggire è impedito, la costrizione a restare in una situazione angosciante prelude a due possibili risposte dell’individuo: una risposta aggressiva o un evitamento passivo che genera una reazione endocrina di stress.
Tutto ciò che si oppone ad una azione gratificante che soddisfa un bisogno innato o acquisito, come può essere il contatto con la madre per un bambino, una conferma da parte del padre per un adolescente, il cibo quando si ha fame, la droga quando si sta male, genera una reazione endocrino-simpatica.
Quando la reazione endocrino-simpatica è prolungata pregiudica il funzionamento degli organi periferici e produce affezioni psicosomatiche.
L’ambiente tossico in cui il paziente è vissuto ha favorito una serie di apprendimenti, questi apprendimenti sono diventati delle abitudini e ‘a lungo andare un’abitudine diventa una necessità‘ (Sant’Agostino, 400 d.c.).
Abbiamo già detto di come un soggetto tossicodipendente impari a fidarsi di persone non affidabili (ad esempio lo spacciatore) e di come questo confonda il significato che attribuisce al concetto di fiducia, ma ci sono anche altre situazioni che vengono tradotte ed interpretate in modo disfunzionale o paradossale.
Lo stesso concetto di libertà viene ridefinito, perdendo le sue caratteristiche imprescindibili di responsabilità, di rispetto e di condivisione con l’altro.
Non si traduce in libertà di poter scegliere come comportarsi o non comportarsi, ma diventa la libertà di non occuparsi delle conseguenze del proprio comportamento.
Anche per questo, in nome della libertà, il paziente arriva ad isolarsi, ad escludersi, incapace di conciliare la sua libertà con quella degli altri, riducendosi a relazioni silenti solo con chi condivide la sua stessa patologia.
Il concetto di libertà può essere critico anche per chi interviene terapeuticamente con questi pazienti, le conseguenze delle loro azioni, i rischi che corrono per la loro vita e i gravi danni che spesso hanno prodotto, portano il terapeuta a sentire l’urgenza di bloccare la persona, di ristabilire un ordine attraverso il controllo.
Questi pazienti però percepiscono il controllo come coercizione e questo favorisce in loro un’ulteriore disregolazione emotiva con conseguenti comportamenti impulsivi e/o aggressivi.
Per quanto riguarda il riconoscimento o la gestione delle sensazioni e delle emozioni, il paziente è fuorviato da una delle funzioni svolte dalle sostanze stupefacenti, cioè quella di essere un’utile strategia di evitamento emotivo.
L’uso di droghe, infatti, stabilizza e spesso risolve un’attivazione emotiva, rende piatta una risposta corporea che per sua natura è ondulatoria e instabile.
Un’emozione può diventare disfunzionale quando non è coerente con la situazione o con il significato che diamo alla situazione, se sono triste ad un funerale vuol dire che funziono bene, che ho una reazione di tutto il corpo coerente con l’esperienza che sto vivendo.
L’uso di sostanze, fungendo da strategia di evitamento delle emozioni, anestetizza l’esperienza emotiva lasciando uno stato corporeo neutro in risposta ad una situazione che ne richiederebbe un’attivazione. Questo vale sia in situazioni avverse quando si provano emozioni spiacevoli sia in situazioni favorevoli quando si provano emozioni piacevoli.
In entrambi i casi la sostanza stupefacente spegne l’emozione coerente con la situazione e crea uno stato neutro che viene appreso come migliore da parte del paziente.
Migliore non significa gratificante o piacevole, ma in grado di eliminare un’attivazione emotiva, di creare una sorta di estraneità dal contesto, di sospensione della realtà. Il paziente può vedere chiaramente che l’uso di sostanze rappresenta l’arsenale con cui procurarsi un certo sollievo, anche se temporaneo, dalla sofferenza emotiva, e rendersi conto che questa dipendenza gli sta rovinando la vita.
Il punto è che se non avesse questa strategia di regolazione emotiva, non saprebbe cosa fare.
La persona ha difficoltà nel raccontarsi, nel descrivere e dare significato alle proprie emozioni e sensazioni, possiede uno scarso vocabolario con cui riferirsi a ciò che sente o a ciò che gli accade, il suo stesso ambiente ha espresso ed esprime poche parole.
In pratica, per lui, è più facile a farsi che a dirsi.
Il tossicodipendente, in alcuni casi, riesce a tollerare la relazione con l’altro solamente se quest’ultimo è disposto a sopportare anche tutti i suoi comportamenti disfunzionali, come se questi fossero una parte imprescindibile della sua identità, come se questi comportamenti non fossero ciò che fa ma ciò che è.
Raramente il paziente riesce a passare dal sono fatto così al mi sono fatto così.
La tossicodipendenza è un elemento costante e totalizzante nella vita del soggetto, ogni cosa viene organizzata in base ai sintomi (somatici, emotivi e cognitivi) che il paziente avverte, ogni cosa è relegata in secondo piano o rimandata rispetto alla sostanza, ogni piacere è confrontato con il piacere della sostanza, ogni soluzione è paragonata con quella proposta dalla sostanza.
La memoria di sé nel tempo è correlata ai periodi di uso di sostanze o ai periodi astinenziali, il parametro con cui vengono richiamati i ricordi o le esperienze passate è —Se facevo uso di sostanze o meno in quel periodo.
Anche l’appartenenza alla categoria dei tossicodipendenti diventa un elemento determinante per definirsi simile o diverso dagli altri.
Quest’ultimo aspetto trova la sua estremizzazione quando il paziente ritiene capace di proporgli una cura solo chi ha avuto le sue stesse esperienze, è convinto che l’avere avuto la stessa patologia garantisca la competenza nel curarla.
La tossicodipendenza diventa parte integrante dell’identità del soggetto, cioè elemento costante della sua vita attraverso il quale mantiene la percezione e la memoria di sé nel tempo (identità diacronica) e attraverso il quale percepisce sé stesso nel confronto di somiglianza o di differenza con gli altri oggetti o individui (identità sincronica).
La tossicodipendenza diventa un elemento di identificazione per il soggetto, una categoria alla quale appartiene, un’etichetta con cui si differenzia dagli altri, una serie di codici con i quali ha imparato a raccontare la sua storia e a dare significato alla realtà o a difendersi da essa. Il modo di vivere che è stato utile in strada diventa inutile e controproducente a casa, ma il paziente lo riproduce, automaticamente, come se fosse incapace di riconoscere gli stimoli alternativi che riceve in un contesto diverso.
— Se continui a giocare a calcio in un campo di basket, probabilmente verrai espulso.
Se avrai un po’ di fortuna verrai espulso con educazione.
Se ti arrabbierai perché ti hanno espulso invece di capire che dovevi provare a giocare a calcio, penseranno che sei matto.
Ciò che è importante non è solo che il paziente abbia appreso un serie di comportamenti in determinati contesti, quanto che continui ad esprimerli anche in altri contesti, insomma se cambia sport dovrebbe imparare ed esprimere nuove modalità comportamentali.
E’ quando lo fa che tende a non riconoscersi, come se certi comportamenti non gli appartenessero, come se fossero estranei alla sua identità, prova quelle sensazioni che proviamo tutti quando ci comportiamo in un modo che non condividiamo.
Se proviamo a dire ai nostri pazienti che con una bacchetta magica abbiamo al possibilità di rendere la loro dipendenza patologica una cosa che non hanno mai avuto o che non avranno mai più, molti di loro non proveranno un senso di sollievo e tanto meno di gioia, ma ci riferiranno di sentirsi persi, spaesati, non identificati, tenderanno a chiedersi —Cosa sono adesso?—, per loro è come se svanisse un modo di essere, non una cosa che fanno. Forse è proprio da questa impossibilità di appigliarsi ai soliti meccanismi a cui facevano riferimento o dall’impegno a non cercare nelle sostanze il modo per orientarsi nella propria esistenza, che dipende quel senso di smarrimento che è uno dei primi segnali di miglioramento del paziente.
Anche per questo motivo il terapeuta diventa un’intromissione tra il disagio che il paziente avverte e la soluzione che ha a disposizione.
L’alcolista sa che il suo malessere (problema) terminerà una volta che inizierà a bere (soluzione), quindi il terapeuta (oppure il genitore, la moglie, il marito, l’amico, il figlio, il lavoro…. ) rappresenta un’intromissione tra il problema e la soluzione del paziente.
Ecco perché vi sono occasioni in cui il paziente, governato dall’urgenza di stare meglio come chiunque avverta un disagio, contrasta il terapeuta (la terapia), contrasta chi gli impedisce di applicare la sua strategia risolutiva per il suo malessere, contrasta chi si frappone tra lui e la soluzione veloce, certa ed efficace.
Imparare un nuovo modo di fare avviene in modo esperienziale, a volte addirittura per tentativi ed errori: errori che si deve essere disposti a tollerare. Ora, per il paziente tossicodipendente, questo presenta almeno due elementi di criticità.
Il primo è la tendenza automatica ad agire secondo predisposizioni di base strutturate e rinforzate nel tempo e nei contesti in cui è vissuto. Il secondo è la paura di lasciare il certo per l’incerto, cioè il timore di non possedere un altro modo di fare o il timore che un altro modo di fare non funzioni per lui.
Il paziente, come ogni altro essere umano, non può ripartire da zero, non può dimenticare le sue abitudini, ciò che lo ha protetto, non è possibile dimenticare gli apprendimenti.
Un particolare comportamento o un modo di pensare (che è una cosa che si fa) si può estinguere ma non disimparare, tutti noi possiamo fare delle azioni che abbiamo appreso anche se non le agivamo da molto tempo.
Questo aspetto può risultare molto importante in un percorso di cambiamento, il terapeuta può mantenere un atteggiamento volto a favorire nel paziente l’apprendimento di cose nuove invece che l’estinzione di ciò che ha imparato.
In particolare, il terapeuta potrebbe intervenire rinforzando i comportamenti adattivi e funzionali del paziente anziché punire i comportamenti disfunzionali, anche perché questi ultimi sono stati puniti ripetutamente in passato senza che ne sia stata favorita l’estinzione.
Vale la pena ricordare che si parla di principio di estinzione quando un comportamento precedentemente rinforzato non è più seguito da un rinforzo positivo, quindi le probabilità che quel comportamento venga nuovamente emesso diminuiscono.
Inoltre sappiamo dalla psicologia sperimentale (Karsh, 1964) che quando un comportamento è seguito contemporaneamente sia da un rinforzo sia da una punizione ad agire su quel comportamento è solamente il rinforzo (Legge di Karsh).
Per questo tra il piacere della cioccolata ed il dispiacere dell’ingrassare vince il piacere, per questo se un alunno fa il pagliaccio in classe e riceve contemporaneamente le risate di approvazione dei compagni e una nota dalla professoressa, continua a fare il pagliaccio.
Nel corso della sua storia di apprendimento il paziente, come conseguenza punitiva per l’uso di sostanze, ha ricevuto la perdita dei rapporti familiari, del lavoro, l’esperienza detentiva, l’overdose, l’emarginazione…
Tutte conseguenze punitive che non hanno funzionato per estinguere il comportamento di abuso, se non temporaneamente, e che non sarebbero neanche praticabili in un contesto o in una relazione terapeutica qualora il paziente emettesse comportamenti disfunzionali.
Inoltre il terapeuta non può disporre di eventuali punizioni paragonabili, o dello stesso peso, di quelle che il paziente ha già ricevuto, ogni conseguenza punitiva che potrebbe proporre sarà sempre meno potente di quelle già sperimentate dal paziente e non riuscirebbe mai a pareggiare l’intensità del desiderio di assumere una sostanza.
Se una moglie dice al marito che punirà un eventuale tradimento smettendo di cucinargli le linguine al pesto, per il marito potrebbe non essere difficile accettare lo scambio.
A questo proposito, in un contesto terapeutico, si ritiene maggiormente utile adottare tecniche comportamentali che intervengano sul rinforzo più che sulla punizione, procedure come il modeling e lo shaping.
Il modeling deriva dalle osservazioni della psicologia sperimentale di Bandura sull’apprendimento tramite imitazione di comportamenti rinforzati dall’accettazione sociale da parte dell’ambiente (Bandura, 1962). L’imitazione è una modalità di apprendimento connessa da una parte al comportamento verbale e dall’altra al comportamento sociale.
Il paziente viene invitato a riprodurre determinati comportamenti del terapeuta in situazioni appropriate. Il terapeuta articola il comportamento mancante nel repertorio del paziente in modo didascalico e in varie emissioni di differente e crescente difficoltà.
Dopodiché chiede al paziente di imitarlo, correggendo eventuali errori e rinforzando con l’approvazione ogni emissione corretta, sottolineandone le caratteristiche salienti.
Il nuovo comportamento sarà poi mantenuto e generalizzato per effetto dell’accettazione che troverà nell’ambiente naturale.
Lo shaping è una pratica applicabile solo quando a dover essere incrementato è un comportamento già presente nel repertorio comportamentale del paziente, anche se viene emesso con una frequenza troppo bassa rispetto agli standard adattivi.
Lo shaping consiste nell’applicazione del rinforzo positivo non al comportamento – bersaglio, ma ai singoli comportamenti di una gerarchia costruita mettendo al vertice il comportamento desiderato e all’estremo opposto i comportamenti, pur quantitativamente diversi, che si avvicinano passo dopo passo verso la meta.
Il terapeuta stabilisce un comportamento non ancora esistente e, per costruirlo, definisce il maggior numero possibile di comportamenti intermedi funzionali alla sua emissione.
Il terapeuta rinforza positivamente gli step più bassi della gerarchia, passando allo step successivo solo quando il comportamento precedente è stabile.
Alla fine, quindi, ad essere rinforzato sarà solo il comportamento – bersaglio.
Imparare cose nuove significa anche avere la possibilità di sbagliarle durante il processo di apprendimento, impone al terapeuta di considerare che il paziente possa esprimere una maggiore criticità proprio mentre tenta di migliorarsi, che possa esprimere i propri sintomi, come le ricadute, i comportamenti disfunzionali, le emozioni disregolate, proprio in questo momento della relazione terapeutica.
E’ per questo che il terapeuta deve mantenere un atteggiamento strategico rispetto a ciò che accade, riflettendo su quella persona in quel contesto e in quel momento.
E’ importante ciò che il paziente tossicodipendente ha imparato a pensare, al linguaggio con cui pensa i suoi pensieri, al modo con cui traduce le parole e le usa per comprendere ed essere compreso dagli altri.
Tutti gli essere umani, compresi i tossicodipendenti anche se in modo deteriorato, possiedono l’abilità di immaginare cose, pianificare, risolvere problemi nella loro mente, è per questo che i pensieri ed il pensare hanno un’importante incidenza sui problemi psicologici.
Nel paziente tossicodipendente si possono rilevare schemi di pensiero caratteristici, tipiche modalità con cui richiama alla memoria i ricordi, specifici indizi con cui interpreta le relazioni interpersonali e modalità con cui avverte le proprie emozioni.
Il paziente spesso utilizza strategie disfunzionali per gestire le emozioni, ha la tendenza a sovraregolarle, a perdere il controllo su di esse e disregolarsi.
I pazienti tossicodipendenti, che nella maggior parte dei casi (potremmo anche dire la totalità) evidenziano un disturbo di personalità, tendono a irritarsi o vergognarsi quando si scoprono turbati, percepiscono le critiche come umiliazioni.
Hanno sentimenti negativi verso le proprie emozioni, perciò incontrano maggiore difficoltà quando devono usare le proprie risorse cognitive per riflettere sulle stesse e impegnarsi a modularle.
Usando come metafora una partita a carte, per riflettere su quali possibilità ha un giocatore (cioè come pensa, in base a cosa riflette) dobbiamo vedere con quali carte deve giocare la sua mano.
Nel caso del paziente tossicodipendente, le carte che possiede possono essere: le convinzioni che ha sul mondo e sulla relazione con gli altri, le strategie che ha per tollerare la sofferenza, una serie di giudizi e pregiudizi che ha appreso dalle esperienze, una scarsa conoscenza dei segnali con cui il corpo suggerisce le emozioni, il paradosso con cui dichiara il suo desiderio di libertà, la contraddizione con cui ama la vita, la difficoltà a capire quali sono i nemici da combattere, la tendenza a chiedere un aiuto per poi sabotarlo, l’istinto a ricercare la felicità nello stesso posto in cui l’ha persa, l’apparente arroganza del sapere come curarsi da solo, la superstizione con cui segue le prescrizioni farmacologiche, la tendenza a scusarsi solo per non parlare del dolore che ha provocato, la superficialità con cui si giustifica per proteggersi dalla vergogna, il narcisismo con cui ascolta le informazioni che riceve, l’illusione che il vuoto è meglio di niente.
Andare a vedere le carte in mano al paziente, ci può consentire di riflettere dal suo punto di osservazione, proponendo interventi che partano dalle sue condizioni e convinzioni di partenza.
Avvicinarsi per andare a vedere le carte può non essere particolarmente semplice ed è necessario capire se e come ci viene richiesto.
La richiesta d’aiuto spesso non avviene verbalmente, nel senso di: —Salve, ho iniziato a drogarmi e vorrei smettere— ma può essere espressa solamente dagli esiti della condotta tossicomanica, ad esempio il paziente è stato cacciato di casa, è stato lasciato dalla moglie, ha perso il lavoro, ha un problema legale, ha un’overdose…
Frequentemente il primo contatto con il paziente avviene per un altro problema.
Ammesso che questo primo contatto si stabilisca, affinché si possano osservare le carte del paziente, è necessario sedersi accanto a lui e anche qui si potrebbe incontrare una certa riluttanza.
Nel caso in cui si superi questo ulteriore ostacolo, il giocatore deve fidarsi di chi osserva le sue carte.
Emerge di nuovo il tema della fiducia nella relazione interpersonale, concetto contraddittorio nella mente del paziente, molte volte disatteso nelle sue esperienze e molte volte tradito da lui stesso.
Il paziente tossicodipendente, spesso, si è impegnato a costruire rapporti di fiducia con l’intenzione di poterli tradire, ha superato il timore di fidarsi per poi essere tradito, non ha accettato la condizione per cui perdere la fiducia è un processo rapido, mentre acquistarla o riacquistarla è un processo molto più arduo, non considera la differenza tra tradire ripetutamente e tradire una volta sola.
Inoltre, anche chi soffre di una dipendenza patologica è, come tutti gli altri esseri umani, vittima dell’euristica secondo cui il comportamento degli altri si deduce dal proprio, quindi tenderà a pensare che gli altri si comporteranno con lui come lui si comporterebbe con gli altri.
Fare in modo che il giocatore sia disponibile a condividere le sue carte, dipende prevalentemente dalle abilità del terapeuta, dalle capacità di quest’ultimo di addentrarsi nelle diffidenze, nelle paure, nelle fughe, nei depistaggi più o meno consapevoli e nelle impulsività del paziente, per delineare un sentiero condiviso.
Questo non è sempre possibile, vi sono condizioni che potremmo definire imperturbabili.
C’è una storia dietro ogni persona. C’è una ragione per cui loro sono quel che sono. Loro non sono così solo perché lo vogliono. Qualcosa nel passato li ha resi tali e alcune volte è impossibile cambiarli (S. Freud).
All’interno della relazione terapeutica è possibile rispondere al paziente in modi diversi da come è abituato, da come si aspetta o suppone che gli si risponda.
Molti problemi psicologici sono mantenuti dal modo in cui gli altri rispondono o interagiscono con la persona che ne soffre, ad esempio la condizione depressiva è mantenuta quando gli altri fanno le cose al posto del depresso, favorendo in lui uno stato di inattività.
Rispondere o interagire con il paziente in modo diverso da come gli accade di solito, significa comportarsi con lui schivando le sue predisposizioni di base, non fare ciò che lui si aspetta che noi facciamo, non dare attenzione a ciò che di solito la riceve.
Quando il paziente agisce prevede di ricevere una certa risposta dall’altro, e ha già ragionato su come rispondere successivamente ad essa, evitare quell’aspettativa significa interrompere degli automatismi e costringerlo a pensare.
In pratica, se siamo riusciti a sederci accanto a lui, possiamo mischiargli le carte che ha per fare in modo che le osservi da un punto di osservazione alternativo, e quando accade restargli accanto senza suggerimenti. Possiamo stare lì mentre perde l’equilibrio senza diventare un appoggio, possiamo osservare con lui le emozioni che prova senza interromperle, possiamo modificare il contesto, in questo caso la relazione, affinché lui trovi nuove strategie di adattamento.
A stare davanti o dietro sono buoni tutti, il difficile è stare appaiati (F. De Andrè).
Affiancare il paziente non in un processo volto a trovare sé stesso, perché si cercherebbe nei soliti posti, ma in un processo di costruzione di sé stesso, in cui sperimentare nuove modalità di risposta agli eventi, nuove modalità di pensare e di osservare i propri sentimenti e quelli degli altri.
Affiancarlo vuol dire anche non fare al posto suo, significa deviare i concetti precostituiti per stimolare il paziente a pensare, significa osservare con caute rassicurazioni le occasioni in cui il paziente perde e ripristina il suo equilibrio.
Quando si salgono le scale c’è un momento in cui si sta su un piede solo, è lì che ci si solleva.
Quando un paziente arriva in una Comunità Terapeutica, oltre ai suoi problemi, si porta dietro anche le sue convinzioni.
Le sue convinzioni su cosa sia una Comunità, dedotte da altri percorsi terapeutici o da altri contesti simili, le sue convinzioni su come la pensano gli operatori rispetto ai tossicodipendenti, sul fatto che qualcuno vorrà addomesticarlo o che è contro di lui.
E’ da queste convinzioni, da questi preconcetti, che inizierà a relazionarsi all’interno della Struttura Terapeutica, probabilmente sospettoso e diffidente.
Quando si inizia un percorso terapeutico in Comunità anche la paura (o lo stato ansioso) ha delle implicazioni importanti, soprattutto perché molti pazienti si vergognano di avere paura e la connotano come un cosa da persone deboli.
A questo proposito, dal punto di vista terapeutico sarà importante agire prima sulla vergogna e successivamente sulla paura, creando un contesto sufficientemente sicuro in cui permettere al paziente di sperimentare l’emozione che evita o che si obbliga ad evitare.
La vergogna è un’emozione sociale che si prova quando si teme un fallimento personale rispetto a degli standard che ci si è posti, è un’emozione secondaria che deve essere appresa e si sviluppa con la crescita dell’individuo e con l’interazione sociale.
La vergogna è un’emozione dell’autoconsapevolezza che si produce in seguito all’autovalutazione di un fallimento personale rispetto ad uno standard desiderato in accordo a regole, scopi o modelli di comportamenti condivisi.
E’, quindi, un’emozione legata alla competenza sociale, cioè alla valutazione e alla comprensione di standard culturali a cui la persona cerca di aderire.
La vergogna scaturisce quando l’individuo devia rispetto alla norma sociale, percependo il senso di fallimento tipico di questa emozione.
Poiché la vergogna nasce dalla valutazione della propria inadeguatezza, l’individuo mette in discussione non il cosa fa ma il cosa è, rendendo impossibile l’opportunità di porre rimedio al proprio errore.
Questa è una importante differenza che c’è tra il senso di colpa e la vergogna.
Il senso di colpa, infatti, mette in discussione il cosa ho fatto, concedendo alla persona la possibilità di riparare all’errore.
Inoltre, mentre la vergogna è accompagnata dalla percezione di un fallimento totale o parziale della propria dignità e dalla sensazione di pericolo per un abbandono affettivo, il senso di colpa segue la trasgressione e attiva l’angoscia della punizione.
La vergogna è il frutto di uno stato interno del sé e non il prodotto di un conflitto esterno, essa va a minare l’integrità del sé e delle proprie capacità.
Anche per questo riconoscersi tossicodipendente genera prevalentemente vergogna per ciò che si è piuttosto che senso di colpa per ciò che si è fatto.
Spesso il paziente non avverte di aver creato dei danni a qualcuno con il suo comportamento ma solo a se stesso, come se la sua condotta tossicomanica non avesse ripercussioni, anche solo affettive, per le persone che gli stanno vicino.
Recenti studi (Damasio et al, 2007) hanno anche evidenziato come a livello cognitivo la vergogna (ma anche il senso di colpa) siano elaborate dalla corteccia prefrontale ventromediale, suggerendo che un danneggiamento di questa area cerebrale interferisca con l’elaborazione affettiva soprattutto nei dilemmi morali che implicano una violazione personale di quella che è considerata, in base agli standard del contesto culturale di appartenenza, una violazione della norma morale.
Osserviamo in pazienti molto diversi tra loro per le loro storie di apprendimento, atteggiamenti e schemi di pensiero automatici in particolari contesti e situazioni, rileviamo un concatenamento di emozioni e di pensieri che si traducono in azioni come se ci fosse un copione prestabilito.
Tale aspetto va a confermare quanto la tossicodipendenza sia una patologia con specifiche caratteristiche di funzionamento sia dal punto di vista neurobiologico sia dal punto di vista prettamente psicologico e comportamentale.
Le predisposizioni di base del paziente sono automatiche, non pensate e nemmeno dubitate, è come se ogni tipo di valutazione cognitiva, che dovrebbe far seguito alla registrazione emotiva di un evento esterno, non avesse tempo di attivarsi, sopraffatta dall’azione. La sequenza utile per esprimere sé stessi nel mondo è: emozioni/sensazioni – riflessione – azione, in altre parole: corpo – mente – comportamento.
Affinché questa sequenza si realizzi è necessario che gli stati affettivi si esprimano in modo regolato, e questo avviene quando ci si sente sicuri cioè, come direbbe Winnicott, quando la madre è sufficientemente buona.
In uno stato affettivo regolato un individuo ha una capacità riflessiva maggiore e più accessibile, le sue percezioni non sono filtrate rigidamente, non ha rappresentazioni preconfezionate di sé e degli altri.
Gli automatismi vengono sostituiti dalla flessibilità della risposta e la reattività è sostituita dalla spontaneità.
Compito del terapeuta è quindi quello di favorire la costruzione di un contesto affettivamente sicuro in cui il paziente, dopo l’attivazione emotiva, non abbia a disposizione i suoi automatismi, ma sia costretto a pensare, o almeno a cercare modalità comportamentali diverse o nuove.
Proporre risposte alternative da quelle che ha avuto nel corso delle sue esperienze di vita e diverse da quelle che pensa o suppone di ricevere, da quelle che si sono concatenate nel corso delle sua storia, rappresenta una strategia utile per creare un tempo di latenza tra l’emozione e il comportamento.
Il paziente parte dal presupposto di ricevere una determinata risposta se porrà una domanda in un determinato modo, permettere che questo non accada, può stimolarlo a pensare, a cercare alternative, ad aprire un primo spiraglio di autoriflessività.
Finché il militare non uccide, è come un bambino. Lo diverti facile. Non essendo abituato a pensare, quando uno gli parla è costretto, per cercare di capire, a decidersi a sforzi opprimenti. Il capitano Frèmizon non mi uccideva, nemmeno se ne stava a bere, non faceva niente con le mani, né con i piedi, cercava solamente di pensare. Era assolutamente troppo per lui, lo tenevo per la testa (Celine, 1932).
Non si suggeriscono modalità alternative, non è neanche importante che il paziente trovi la modalità più funzionale di esprimersi, è sufficiente che possa sperimentarsi in assenza di un copione da recitare.
E’ probabile che a questo punto il paziente non sappia cosa fare e che il suo sistema emotivo si attivi, ci sarà un momento di crisi dopodiché sarà costretto a pensare.