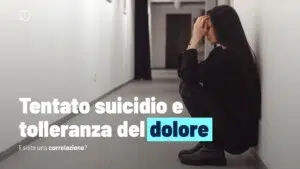È possibile prevedere e prevenire un suicidio?
La valutazione del rischio suicidario, prevedere e prevenire un suicidio, è una delle maggiori sfide in campo clinico psicologico e psichiatrico. Tra i fattori di rischio suicidario vengono spesso citati, per esempio, la presenza di disturbi mentali (in particolare depressione), la disperazione (intesa come mancanza di speranza), l’impulsività, l’anedonia, uno scarso sentimento di appartenenza, il bullismo, la disregolazione emotiva, la sensazione di sentirsi in trappola e la disconnessione sociale (isolamento e solitudine).
Tuttavia questi fattori sembrano in grado di predire l’ideazione suicidaria, ma non la messa in atto del proposito.
Suicidio: le teorie dall’ideazione all’azione
Secondo le cosiddette “Ideation-to-action theories of suicide” l’ideazione suicidaria (l’idea di togliersi la vita) e l’azione suicidaria (la messa in atto dell’idea) sono due processi distinti, sottesi da meccanismi specifici e caratterizzati da predittori differenti. Poiché non tutte le persone che desiderano suicidarsi si tolgono effettivamente la vita, quali sono i fattori che determinano il passaggio dall’ideazione all’azione?
La Teoria Interpersonale Psicologica del Suicidio
Sviluppata da Thomas Joiner (2005), la Teoria Interpersonale Psicologica del Suicidio identifica due fattori che portano un individuo a sviluppare l’idea di togliersi la vita:
- l’appartenenza contrastata, cioè la mancata soddisfazione del bisogno umano di appartenenza, dovuta all’assenza di relazioni sociali positive o alla sensazione di non essere realmente connessi con gli altri (solitudine e mancanza di relazioni di cura reciproca);
- l’onerosità percepita, cioè la sensazione di essere un peso per gli altri (la famiglia, gli amici, la società).
Il fattore che invece determina il passaggio dall’ideazione all’azione è la capacità acquisita di effettuare un atto di autolesionismo letale. Infatti uno dei più grandi ostacoli evolutivi da superare quando si vuol porre fine alla propria vita è la paura della morte e del dolore. Secondo la Teoria Interpersonale Psicologica del Suicidio la continua esposizione a eventi dolorosi (es. maltrattamenti, autolesionismo) determinerebbe una sorta di abituazione al dolore e alla paura; l’individuo acquisirebbe così gradualmente la capacità di commettere suicidio (capacità suicidaria acquisita).
Il modello integrato motivazionale-volitivo del comportamento suicidario
Il modello integrato motivazionale-volitivo del comportamento suicidario ritiene che il processo che conduce al suicidio si articoli in due fasi: motivazionale e volitiva.
A seguito di determinate circostanze di vita è possibile provare sentimenti di umiliazione e sconfitta che, in associazione a fattori quali, per esempio, scarsa capacità di coping o di problem solving, possono portare a sentirsi in trappola (entrapment). L’entrapment può a sua volta, in presenza di moderatori come per esempio l’onerosità o una visione del futuro negativa, spingere una persona a pensare al suicidio come unica soluzione possibile.
Tuttavia, il passaggio alla fase volitiva, e quindi all’azione, richiede la presenza di fattori come l’aumentata capacità, l’impulsività, l’accesso a mezzi letali.
3-step theory
Secondo questa teoria l’ideazione suicidaria si sviluppa quando dolore (spesso psicologico) e disperazione si combinano tra loro (Step 1).
Quando il dolore supera qualsiasi aspetto della vita che renda la vita stessa degna di essere vissuta nonostante il dolore (es. l’amore per i propri cari), l’ideazione suicidaria si intensifica (Step 2).
L’acquisizione della capacità di suicidarsi, influenzata non solo da fattori acquisiti (come sostenuto anche dalla Teoria Interpersonale Psicologica del Suicidio), ma anche da fattori disposizionali (es. alta soglia del dolore, ridotta paura della morte) e pratici (es. accesso a mezzi letali), determina il passaggio dal pensiero all’azione (Step 3).
Teoria della vulnerabilità fluida
Sviluppata da Rudd nel 2006 a partire dal concetto cognitivo-comportamentale “suicidal mode” di A. T. Beck, è un approccio cognitivo alla comprensione del rischio suicidario.
Secondo il modello di Beck, in presenza di fattori di rischio (es. vulnerabilità genetica, storie di abuso), fattori di vita scatenanti (es. perdita di lavoro, lutto) possono portare all’attivazione del cosiddetto “suicidal mode”, risultato dell’interazione tra sfera cognitiva (es. pensieri di indegnità, di intollerabilità), emotiva (es. senso di colpa, vergogna, ansia), fisiologica (es. disturbi del sonno) e comportamentale (es. ritiro sociale).
La teoria della vulnerabilità fluida estende tale modello e pone l’accento sul concetto di sistema di credenze suicidarie, identificando un ampio spettro di credenze che porterebbero all’azione suicidaria (es. odio verso se stessi, intollerabilità, disperazione…). Questo sistema sarebbe la manifestazione psicologica di due meccanismi di vulnerabilità alla base del comportamento suicidario: l’inflessibilità cognitiva e un deficit nella regolazione delle emozioni. Infine l’aspetto che differenzia la teoria della vulnerabilità fluida dalle altre teorie è l’accento posto sul processo di rischio suicidario: il rischio suicidario varia nel tempo poiché presenta sia caratteristiche stabili (resistenti al cambiamento), sia variabili (che fluttuano in risposta a fattori ambientali e individuali) la cui interazione determina il comportamento suicidario.
Valutare non solo l’ideazione suicidaria, ma anche la capacità suicidaria
Le teorie che considerano il processo dall’ideazione all’azione hanno permesso una maggiore comprensione del comportamento suicidario. In particolare, diverse evidenze suggeriscono che il dolore, la disperazione e altre variabili a essi collegati possono portare all’ideazione suicidaria, ma chi si occupa di valutare il rischio suicidario deve avere in mente che è la capacità suicidaria a differenziare tra chi pensa di togliersi la vita e chi effettivamente compie tale gesto e intervenire anche su questo aspetto.