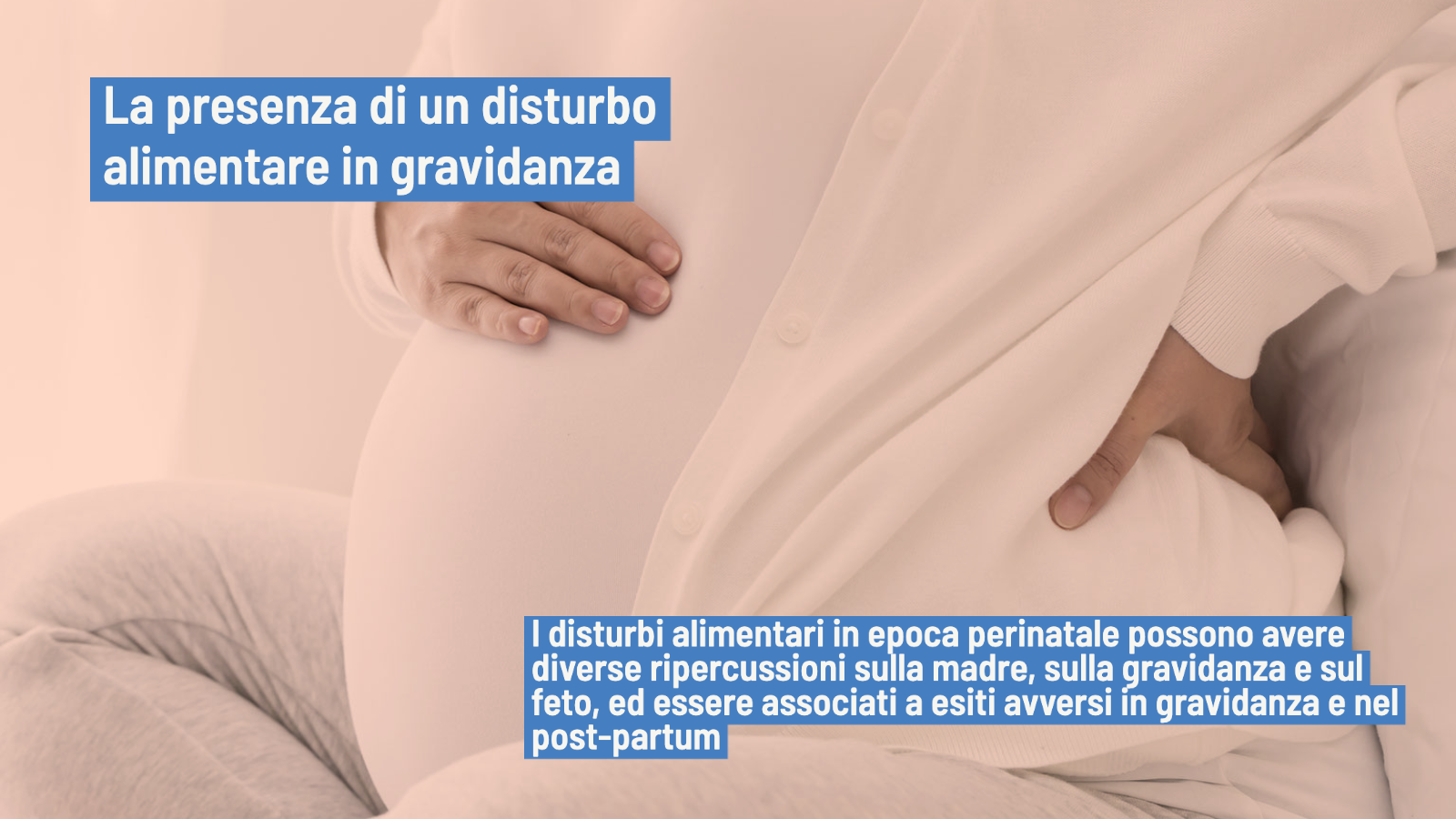È importante che la psicosi post-partum non venga confusa con la depressione post-partum e con altri disturbi psichici perinatali, per questo è fondamentale rivolgersi ad operatori specialistici della salute mentale.
I disturbi psichici perinatali gravi possono impattare in primis sulla salute materna ma anche sulla relazione madre-bambino e sullo sviluppo di quest’ultimo. Per questo è essenziale sensibilizzare la popolazione e gli operatori socio-sanitari su questi disturbi al fine di riconoscerli e trattarli precocemente.
I disturbi psichiatrici perinatali: la psicosi puerperale
Tra i disturbi psichici perinatali ritroviamo condizioni che fanno riferimento alla psicosi puerperale. Con questo termine in letteratura perinatale ci si riferisce a una condizione clinica che viene definita dagli autori “caleidoscopica” vista l’elevata complessità ed eterogeneità delle composizioni sintomatologiche osservabili. Possono esservi sintomi maniacali, depressione severa o quadri misti. Si possono riscontrare deliri, allucinazioni, insonnia persistente, comportamenti bizzarri, fluttuazioni del tono dell’umore (depressione, mania, fasi miste), preoccupazioni ossessive per la salute del neonato e labilità emotiva (Heron, 2008; Sit, 2006), fino a casi estremi quali suicidio (Appleby, 1998, Orsolini, 2016) e infanticidio (Spinelli, 2004). In alcuni casi sono descritti sintomi cognitivi atipici quali disorientamento, confusione, perplessità, derealizzazione e depersonalizzazione (Bergink, 2014). La psicosi puerperale rappresenta quindi un’emergenza psichiatrica che spesso necessita di un’ospedalizzazione.
La psicosi puerperale ha una temporalità di esordio specifico, generalmente entro le quattro settimane dal parto (Di Florio et al, 2013), anche se può esordire tardivamente anche nelle settimane successive.
Il quadro clinico può essere altamente mutevole, grave e presentarsi subdolo all’osservazione, e anche per questo motivo è essenziale non sottovalutarne i segnali sospetti.
La psicosi puerperale è un disturbo raro nella popolazione generale, con una stima all’incirca di uno/due parti su mille (Di Florio, Smith e Jones, 2013), anche se tali stime possono essere inficiate da diagnosi differenziali non corrette. Infatti, la psicosi puerperale non va confusa con il disturbo bipolare, con la depressione post-partum, con la schizofrenia.
L’eziologia della psicosi puerperale
I fattori eziopatogenetici fanno riferimento a fattori genetici, fattori ostetrici, fattori ormonali, deprivazione di sonno e fattori psicosociali, anche se la ricerca presenta ancora molto da approfondire in termini eziologici in relazione a tale disturbo.
Tra i fattori genetici, un elemento di vulnerabilità può essere la diagnosi di disturbo bipolare, anamnesi positiva per disturbi psichiatrici e familiarità per disturbi psichiatrici; alcuni studi genetici identificano possibili geni candidati. Tuttavia va sottolineato che per la metà delle donne con diagnosi di psicosi puerperale si presenta una anamnesi psichiatrica muta. Riguardo ai fattori ostetrici, la letteratura sembra coerente nell’indicare l’essere primipare come fattore rischio di carattere ostetrico. È inoltre possibile che una maggiore suscettibilità ai significativi sbalzi ormonali possa essere un fattore di rischio; anche la carenza di sonno può essere un fattore di vulnerabilità significativo da considerare. A differenza della depressione post-partum, i fattori psicosociali sembrano giocare un ruolo minoritario nell’esordio della psicosi puerperale.
Diagnosi differenziale della psicosi puerperale
È importante che la psicosi post-partum non venga confusa con la depressione post-partum e con altri disturbi psichici perinatali, per questo è fondamentale rivolgersi ad operatori specialistici della salute mentale per poter chiedere aiuto e procedere a una diagnosi e trattamento tempestivo.
In una review sistematica Dolman, Jones e Howard (2013) hanno identificato alcuni temi caratterizzanti il vissuto delle madri che presentano diagnosi di disturbi psichici gravi, tra i quali emergono: lo stigma, il senso di colpa, l’isolamento, la paura degli effetti della malattia e dei farmaci sul figlio, la perdita della custodia del figlio.
Il trattamento per la psicosi puerperale
Le linee guida internazionali (NICE, 2015) raccomandano la necessità di un ricovero congiunto di madre e figlio in reparti specializzati, le cosiddette “Mother-Baby Units”, che offrono trattamenti multidisciplinari e integrati a livello medico-farmacologico, psicosociale, psicoeducativo e psicoterapico rivolti alla diade in epoca perinatale. In tali reparti specializzati, madre e neonato non vengono separati, ma si lavora in contesto protetto per favorire il mantenimento del rapporto madre-neonato.
Il trattamento farmacologico risulta essenziale e dipende dall’anamnesi psichiatrica personale e familiare della paziente. Se tempestivamente identificata e trattata, la psicosi puerperale ha una prognosi a breve termine generalmente buona. Alcuni studi evidenziano che il 95% dei casi trattati raggiunge una remissione dei sintomi a un anno dall’esordio. Tuttavia, la psicosi puerperale rappresenta uno dei principali fattori di rischio per il suicidio dopo il parto. Per questo motivo, queste donne vanno monitorate attentamente, essendo la patologia a decorso fluttuante.
A lungo termine, uno studio effettuato retrospettivamente ha evidenziato che solo il 58% delle donne con psicosi puerperale affronta una seconda gravidanza; altri studi evidenziano che si può sviluppare un disturbo bipolare ricorrente non legato al periodo perinatale.