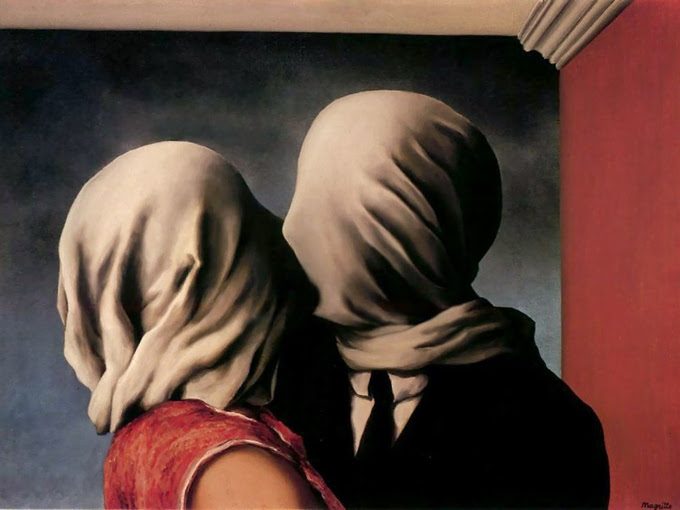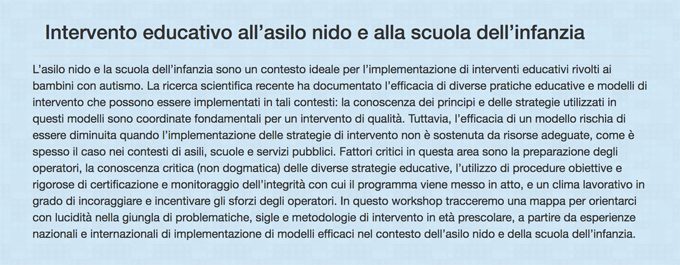Problemi alimentari dell’infanzia? Come affrontarli con l’ABA
Diverse ricerche mostrano come si possa utilizzare l’ABA (Applied Behavior Analysis) nei problemi alimentari dell’infanzia, soprattutto nei bambini a sviluppo tipico, in maniera tale da educarli ad un’alimentazione corretta ed aiutare genitori, insegnanti, educatori, psicologi e soprattutto i bambini stessi.
Artoni Grazia e Atti Martina – OPEN SCHOOL Studi Cognitivi Modena
I problemi alimentari rappresentano un argomento di notevoli dimensioni e con svariate sfaccettature, di cui si occupano medici, nutrizionisti, psicologi clinici ma anche psicologi dell’educazione. Diverse ricerche mostrano come si possa utilizzare l’ABA (Applied Behavior Analysis) nei problemi alimentari presenti, in particolar modo, nei bambini a sviluppo tipico, in maniera tale da educarli ad un’alimentazione corretta ed aiutare genitori, insegnanti, educatori, psicologi e soprattutto i bambini stessi.
Ma che cosa è l’ABA?
L’ABA, ovvero Applied Behavior Analysis, è la scienza applicata che deriva dalla scienza di base conosciuta come Analisi del Comportamento (Skinner, 1953), la quale ha come oggetto lo studio delle interazioni psicologiche tra individuo e ambiente e come metodo quello scientifico proprio delle scienze naturali. Una caratteristica fondamentale dell’ABA è quella di essere evidence-based. L’attenzione dell’ABA è rivolta ai comportamenti socialmente significativi (abilità scolastiche, sociali, comunicative, adattive), questo la rende adatta ad essere applicata a qualsiasi ambito di intervento e non, come comunemente (e erroneamente) si pensa, solo all’autismo.
Problemi alimentari nell’infanzia: l’obesità infantile
Esistono diversi tipi di problemi alimentari nell’infanzia, problemi che, di conseguenza, rivestono anche l’area sociale, emotiva, affettiva dei più piccoli. Bisogna sottolineare che ogni caso è a sé e che ogni bambino è immerso in un contesto, in particolare, quello sociale, che è sicuramente una grande risorsa per la sua crescita, ma può rivelarsi anche controproducente e, addirittura, dannoso come si nota negli ultimi anni, ad esempio, per quanto riguarda l’obesità.
Si può parlare di obesità infantile quando il peso di un bambino supera del 20% il peso ideale (in base al sesso e all’altezza), di sovrappeso se lo supera del 10-20%. I super-obesi, invece, sono quei bambini il cui peso supera del 40% i valori normali.
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) i bambini in eccesso ponderale nel mondo sono 44 milioni. In tutti gli Stati membri dell’UE la diffusione di sovrappeso e obesità nei bambini e negli adolescenti ha raggiunto dimensioni epidemiche ed è particolarmente preoccupante.
In Italia, il sistema di sorveglianza nazionale OKkio alla SALUTE (Nardone et al., 2016), promosso e finanziato dal Ministero della Salute/CCM, coordinato dal Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute dell’Istituto Superiore di Sanità e condotto in collaborazione con tutte le regioni italiane e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dal 2007 costituisce una solida fonte di dati epidemiologici sugli stili di vita dei bambini della scuola primaria e rappresenta la risposta istituzionale al bisogno conoscitivo del problema del sovrappeso e dell’obesità nella popolazione infantile.
Sono state presentate quattro rilevazioni (2008/9, 2010, 2012 e 2014), ognuna delle quali ha coinvolto oltre 40.000 bambini e genitori e 2.000 scuole. La metodologia standardizzata a livello nazionale garantisce la riproducibilità e la confrontabilità dei dati raccolti su: stato ponderale, abitudini alimentari, esercizio fisico e sedentarietà dei bambini della terza classe primaria e sul contesto scolastico e familiare.
La recente ricerca del 2014 ha evidenziato che i bambini di 8-9 anni in sovrappeso sono il 20,9% e i bambini obesi sono il 9,8%, compresi i bambini severamente obesi che da soli sono il 2,2%. Emerge, inoltre, che le prevalenze più alte si collocano nelle regioni del centro e del sud Italia.
Dal confronto delle quattro rilevazioni, oggi si evidenzia una leggera e progressiva diminuzione del fenomeno, nonostante i valori italiani di tali problemi alimentari nell’infanzia permangano elevati.
Dai dati 2014, come nel passato, emerge una tendenza dei genitori a sottostimare lo stato ponderare dei propri figli. In particolare tra le madri di bambini in sovrappeso o obesi, il 38% ritiene che il proprio figlio sia sotto-normopeso e solo il 29% pensa che la quantità di cibo da lui assunta sia eccessiva. Inoltre, solo il 41% delle madri di bambini fisicamente poco attivi ritiene che il proprio figlio svolga poca attività motoria.
In riferimento all’esercizio fisico e alla sedentarietà i dati rimangono piuttosto invariati rispetto al passato, con tendenza al miglioramento. Nel 2014 il 18% pratica sport per non più di un’ora a settimana, il 42% ha la TV nella propria camera, il 35% guarda la TV e/o gioca con i videogiochi più di 2 ore al giorno e solo 1 bambino su 4 si reca a scuola a piedi o in bicicletta.
Soffermandosi sulle abitudini alimentari, nel 2014 emerge che l’8% dei bambini salta la prima colazione, il 31% fa una colazione non adeguata (ossia sbilanciata in termini di carboidrati e proteine) e il 52% fa una merenda di metà mattina abbondante. Il 25% dei genitori dichiara che i propri figli non consumano quotidianamente frutta e/o verdura e il 41% dichiara che i propri figli assumono abitualmente bevande zuccherate e/o gassate. La situazione rimane piuttosto stabile rispetto alle precedenti rilevazioni e solo per quanto riguarda il consumo di una merenda abbondante e di bevande zuccherate e/o gassate si registra una diminuzione rispetto alla precedente raccolta (Nardone et al., 2016).
L’obesità è dovuta, quindi, ad un insieme di concause: predisposizione genetica e differenze metaboliche, aspetti fisiologici della regolazione del peso, ambiente familiare e condizioni socioeconomiche ambientali, scarsa educazione alimentare e stile di vita (spesso troppo sedentario) (Pruneti, 2005; Direzione generale della prevenzione sanitaria, 2010).
Tra le conseguenze precoci, le più frequenti sono rappresentate da problemi di tipo respiratorio (faticabilità, apnea notturna), di tipo articolare, dovute al carico meccanico (varismo/valgismo degli arti inferiori, ossia gambe ad arco o ad “X”, dolori articolari, mobilità ridotta, piedi piatti), disturbi dell’apparato digerente, disturbi di carattere psicologico: i bambini ‘grassottelli’ possono sentirsi a disagio e vergognarsi, fino ad arrivare ad un vero rifiuto del proprio aspetto fisico; sono spesso a rischio per la perdita di
autostima e sviluppano un senso di insicurezza, che li può portare all’isolamento: escono meno di casa, stanno più tempo davanti alla televisione, instaurando un circolo vizioso che li porta ad una iperalimentazione reattiva.
Per quanto riguarda le conseguenze tardive, occorre sottolineare che l’obesità infantile rappresenta un fattore predittivo di obesità nell’età adulta (Sofo & Dipalma, 2013).
L’impatto dell’obesità e le conseguenti ripercussioni dirette sulla salute sottolineano, quindi, come sia prioritario e necessario contrastare tempestivamente tale fenomeno (Direzione generale della prevenzione sanitaria, 2010).
Verrà mostrata la situazione di bambini obesi o in sovrappeso e con tendenza all’obesità e, in particolare, la scelta di tecniche educative che possano prevenire una patologia per molti versi invalidante.
L’obesità non rientra nelle categorie diagnostiche del DSM-5.
Problemi alimentari nell’infanzia: il disturbo evitante/restrittivo dell’assunzione di cibo
Un cambiamento riscontrabile in questa nuova edizione del Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali è il disturbo evitante/restrittivo dell’assunzione di cibo che sostituisce ed estende la diagnosi DSM-IV di disturbo della nutrizione dell’infanzia.
La maggiore categoria diagnostica di questo disturbo, che può essere riscontrato anche negli adulti, è l’evitamento o la restrizione dell’assunzione di cibo per tre motivi principali:
- Apparente mancanza d’interesse per il mangiare o il cibo;
- Caratteristiche sensoriali del cibo;
- Preoccupazioni per le conseguenze avversive del mangiare (es. vomito e soffocamento)
L’evitamento o la restrizione producono un persistente fallimento nel soddisfare le necessità nutrizionali e/o energetiche appropriate determinando una o più delle seguenti 4 conseguenze:
- Perdita di peso significativa (o fallimento nel raggiungere l’aumento di peso atteso o inadeguata crescita nei bambini);
- Deficit nutrizionale significativo;
- Funzionamento dipendente dalla nutrizione parenterale (sondino nosogastrico) o da integratori nutrizionali orali;
- Marcata interferenza con il funzionamento psicosociale.
Non è presente la preoccupazione per il peso e la forma del corpo né deve manifestarsi durante il decorso dell’anoressia nervosa e della bulimia nervosa o in presenza di digiuni religiosi. Infine, il disturbo non è dovuto a una mancanza nella disponibilità di cibo o a un’altra malattia medica o mentale.
In caso di presenza di condizioni mediche particolari (disturbi gastrointestinali, allergie e intolleranze alimentari) o altri disturbi mentali, viene apposta la diagnosi di disturbo evitante/restrittivo dell’assunzione di cibo solamente in presenza di un quadro clinico importante, non spiegato dalla stessa patologia.
Un recente studio inglese (Kurz et al., 2015) rivela che i problemi alimentari nell’infanzia di tipo restrittivo sono comunemente riportati nei più piccoli, con una prevalenza del 3,2% per il disturbo evitante/restrittivo dell’assunzione di cibo. In particolare, emerge che la restrizione alimentare è legata alle caratteristiche sensoriali del cibo (60,9%), ad apparente mancanza d’interesse per il mangiare o il cibo (39,1%) e, infine, a preoccupazioni per le conseguenze avversive del mangiare (15,2%).
Si affronterà, quindi, anche il problema della selettività per i cibi e verranno mostrati interventi basati su tecniche educative rivolte al rifiuto di cibo/liquidi e selettività.
ABA e Obesità infantile
Rispetto all’Obesità infantile nel regno Unito Horne & Lowe (2009) hanno promosso un’iniziativa per incoraggiare e mantenere sane abitudini alimentari nei bambini. Si tratta di un intervento progettato per essere utilizzato nelle scuole elementari, che spinge i bambini a mangiare frutta e verdura a scuola e a casa, li aiuta a sviluppare il piacere di mangiare frutta e verdura e li incoraggia a diventare orgogliosi di pensare a se stessi come individui sani, che mangiano cibi sani, cambia la ‘cultura’ delle scuole, affinché sostengano con forza il ‘mangiar sano’.
Il programma ha due fasi principali: durante la prima fase (di 16 giorni di durata) i bambini possono leggere una lettera e/o guardare un video appositamente progettato, che fornisce un ruolo influente come modello da imitare. Ai bambini viene, quindi, data una porzione di frutta e verdura e a chi mangia entrambi viene data una piccola ricompensa (ad esempio, palle da giocoliere, contapassi). Ciò incoraggia a ripetere il consumo, in modo tale che i bambini inizino ad apprezzare questi alimenti. Durante la seconda fase è presente un sostegno continuo, ma meno intenso: in aula sono utilizzati pannelli appesi al muro per registrare i livelli di consumo di frutta e verdura di ciascun bambino, il quale guadagnerà ulteriori premi e certificati (token economy). Tutte le valutazioni dimostrano aumenti notevoli e di lunga durata per quanto riguarda il consumo di frutta e verdura nei bambini dai 2 agli 11 anni di età. Gli aumenti maggiori nel consumo sono rappresentati da quei bambini che, all’inizio, mangiavano meno frutta e verdura.
Lo studio di Horne, Hardman, Lowe, Tapper, Le Noury, Madden et al. (2009) valuta l’efficacia dell’intervento, presentato in precedenza da Horne & Lowe (2009). Questo viene progettato per aumentare notevolmente il consumo di frutta e di verdura da parte dei bambini, in Irlanda, dove i pasti scolastici non sono forniti dalla scuola e i bambini devono portarsi il cibo da casa. I partecipanti sono bambini dai 4 agli 11 anni, che frequentano due scuole elementari; l’assegnazione delle scuole alla condizione sperimentale o di controllo viene fatta tramite randomizzazione.
Durante l’intervento di 16 giorni nella scuola ‘sperimentale’, i bambini guardano un video che racconta le avventure di un eroe, creato appositamente per il programma alimentare. I bambini ricevono piccoli premi a patto che mangino frutta e verdura. In entrambe le scuole, vengono valutati la presenza di frutta e verdura nel lunchbox (il contenitore per il pranzo), preparato dai genitori, ed il consumo di esse da parte dei bambini sia in baseline sia durante i 12 mesi di follow-up. Frutta e verdura vengono fornite dai genitori in entrambe le scuole 8 giorni su 16 nella baseline e 16 giorni su 16, durante l’intervento. Il consumo da parte dei bambini viene misurato.
I risultati mostrano che rispetto alla baseline, il consumo di frutta e verdura forniti, è aumentato durante l’intervento nella scuola sperimentale, mentre nella scuola di controllo si rileva un significativo calo. A 12 mesi di distanza (follow-up), i genitori della scuola sperimentale forniscono più frutta e verdura ai loro figli e, di conseguenza, i bambini ne consumano quantità notevolmente maggiori, rispetto alla baseline e all’inizio dell’intervento. Quindi, l’intervento si è dimostrato efficace nel cambiare la predisposizione al consumo di frutta e verdura sia nei genitori che nei bambini dell’Irlanda.
Horne, Hardman, Lowe & Rowlands (2009) presentano uno studio al fine di prevenire la tendenza all’obesità infantile e adolescenziale. Gli autori presentano, quindi, un trattamento per l’incremento dell’attività fisica dei bambini tramite procedure di modeling dei pari, rinforzi e un intervento che utilizza un contapassi. Lo studio è stato condotto in due scuole elementari in Galles. I partecipanti sono 47 bambini (21 maschi, 26 femmine), appartenenti alla scuola sperimentale e 53 bambini (29 maschi, 24 femmine) appartenenti alla scuola di controllo, tutti di età compresa tra i 9 e gli 11 anni e con sviluppo tipico. I bambini della scuola sperimentale hanno preso parte all’intervento: per oltre 8 giorni gli sono stati presentati modelli da imitare, tramite l’utilizzo di materiali audio e video, in seguito hanno ricevuto piccoli premi (rinforzi), quando il loro contapassi registrava un aumento quotidiano di 1500 passi rispetto alla loro baseline. Le misure del contapassi sono state prese direttamente dai bambini in entrambe le scuole sia in baseline, sia durante l’intervento, sia durante le 12 settimane di follow-up.
I risultati mostrano che tra le ragazze del gruppo sperimentale, il numero di passi al giorno è significativamente più elevato durante l’intervento e al follow-up, rispetto alla loro baseline e ai risultati delle ragazze del gruppo di controllo. I ragazzi del gruppo sperimentale hanno mostrato un numero significativamente più elevato di passi al giorno durante l’intervento, sia rispetto alla loro baseline, sia rispetto al gruppo di controllo dei ragazzi. Non ci sono differenze significative tra i livelli di attività del gruppo sperimentale e di controllo dei ragazzi al follow-up. L’intervento ha portato a un sostanziale incremento dell’attività fisica dei bambini, mantenuto, però, al follow-up solo dalle ragazze.
In uno studio classico (Epstein, Parker, McCoy & McGee, 1976), invece, vengono rilevate le percentuali di bocconi, di sorsi e di attività concorrenti di sei bambini di 7 anni, tre obesi e tre non obesi, osservati durante il pranzo, per un periodo di sei mesi. Viene applicata una procedura per diminuire il numero di bocconi, posando le posate tra un boccone e l’altro. Le percentuali di sorsi e attività concorrenti vengono osservate per valutare le covariazioni comportamentali. Inoltre, vengono calcolati il tasso di bocconi e la quantità di cibo completati in base a sei categorie di prodotti alimentari, al fine di analizzare le preferenze alimentari. I risultati indicano un maggior controllo del comportamento alimentare, una percentuale inferiore di bocconi ingeriti da tutti i soggetti e una significativa riduzione della quantità di cibo consumato. Differenze nel comportamento alimentare di soggetti obesi e non obesi vengono, invece, osservate nel consumo di latte e pane. Come si può notare, le procedure sono ben diverse da quelle utilizzate nei trattamenti precedentemente presentati, ma presentano, comunque, una buona validità.
ABA e Rifiuto o Selettività di cibo/liquidi
Il rinforzo negativo, in forma di evitamento del cibo, è stato ipotizzato essere un fattore primario al mantenimento di problemi alimentari nell’infanzia. Tuttavia, i trattamenti per i problemi alimentari nell’infanzia sono costituiti spesso da strategie integrate basate sia sul rinforzo positivo sia su quello negativo. Finney, Itawa, Riordan, Stanley & Wohl (1984) cercano di incrementare il consumo di alimenti non preferiti usando i cibi preferiti come rinforzo positivo nei bambini con selettività alimentare. Tuttavia, l’efficacia del rinforzo, in assenza di estinzione del comportamento di evitamento del cibo, è difficile da valutare, a causa dei comportamenti problematici legati all’evitamento.
Il rinforzo positivo e negativo sono stati esaminati come trattamenti per altri comportamenti problema mantenuti dall’evitamento. Per esempio, è stato mostrato che i livelli di compliance sono superiori e i livelli di comportamento – problema sono più bassi, quando la compliance fa sì che venga elargito cibo commestibile (rinforzo positivo), rispetto ad una pausa (rinforzo negativo), anche se il comportamento distruttivo continua a produrre evitamento. Questi risultati suggeriscono che, in assenza di estinzione dell’evitamento, i rinforzi positivi possono a volte essere più efficaci, rispetto ad un rinforzo negativo, soprattutto, quando la qualità del rinforzo positivo è relativamente alta.
L’obiettivo di uno studio presentato da Kelley, Piazza, Fisher & Oberdorff (2003) è quello di valutare gli effetti separati e combinati del rinforzo positivo e negativo sull’acquisizione del comportamento “bere liquidi da una tazza”, in assenza di estinzione dell’evitamento. Il partecipante è un bambino di 3 anni con sviluppo tipico, ammesso in precedenza ad un programma di trattamento diurno per il rifiuto del cibo e dipendenza dal biberon.
Al momento del ricovero, il bambino riceve il 100% del suo fabbisogno nutrizionale tramite il biberon e rifiuta tutti gli alimenti solidi (tra cui pesche e carote) e i liquidi dalla tazza. Il rifiuto del cibo da parte del bambino è stato trattato prima dell’inizio di questo studio tramite tecniche di fading, rinforzo non contingente ed estinzione dell’evitamento. Al momento dell’inizio dello studio, il bambino mangia tre pasti selezionati al giorno, costituiti da alimenti per l’infanzia. Lo scopo dell’analisi è quello di aumentare il consumo di liquidi da una tazza. Le frequenze di scelte e di consumo vengono registrate e convertite in percentuali di prove in cui il comportamento si è verificato. La “scelta” viene definita come l’atto del bambino di indicare una carta. Il “consumo” viene definito come il comportamento di accettazione di cibo o liquidi e di non espulsione, prima dell’inizio del processo successivo.
Vengono condotte da 6 a 12 sessioni, di 10 prove ciascuna, ogni sessione dura 5 minuti, per 5 giorni alla settimana. Lo studio consiste di una valutazione delle preferenze del bambino tra 15 prodotti alimentari, una seconda valutazione della preferenza (confrontando pesche, carote, e 30 secondi di pausa), un’analisi del trattamento. I risultati della prima valutazione indicano che le pesche e le carote sono i cibi preferiti e non preferiti, rispettivamente. Durante la prima fase della seconda valutazione, vengono presentate tre carte contemporaneamente (una raffigurante pesche, una raffigurante carote e una raffigurante la pausa) e si suggerisce al bambino di scegliere una carta. Durante la seconda fase, gli vengono presentate 2 carte contemporaneamente (carote e pausa) e gli viene chiesto di scegliere. Se il bambino sceglie un prodotto alimentare, quel cibo gli viene presentato su un cucchiaio a 2,5 centimetri dalla bocca e lo si tiene lì fino a quando non apre la bocca e accetta il boccone. Se il bambino sceglie la pausa, riceve 30 secondi di pausa dalle carte e dal cibo.
Vengono utilizzati i risultati delle valutazioni di preferenza per sviluppare un trattamento, per aumentare il comportamento di bere dalla tazza. Nella baseline, il terapeuta presenta 7,5 ml di liquido in una tazza e dà un prompt verbale (“Bevi”), in un tempo determinato di 30 secondi. Viene espresso apprezzamento, se il bambino accetta o consuma la bevanda. Non vengono, invece, date conseguenze differenti per l’espulsione, il vomito, o l’assenza di una risposta. Se il bambino fa un qualsiasi comportamento inappropriato, durante la presentazione, la tazza viene rimossa per 30 secondi, dopo di ché, viene avviato il processo successivo. La procedura di trattamento è identica alla baseline, ma con le seguenti aggiunte: durante la condizione di rinforzo positivo (Sr+), viene presentato un cucchiaio di pesche a seguito del consumo della bevanda; durante la condizione di rinforzo negativo (Sr-), viene dato un cucchiaio di carote, se il bambino mette in atto un comportamento inadeguato o non consuma la bevanda, entro 30 secondi dalla presentazione.
I risultati della prima valutazione delle preferenze dimostrano che le pesche vengono scelte e consumate nel 100% delle sperimentazioni, considerando che le carote vengono scelte di rado e raramente vengono consumate. I risultati della seconda valutazione delle preferenze mostrano che il bambino sceglie le pesche rispetto alle carote e alla pausa. Sulla base di questi risultati, si prevede che l’accettazione di pesche e l’evitamento di carote potrebbero funzionare come rinforzo positivo e negativo, rispettivamente. Il consumo di bevande (tre tipi diversi) durante la baseline è dello 0%, del 44,6%, del 12,5%, rispettivamente. Il consumo è vicino al 100% per tutti i tre tipi di bevande nelle condizioni di trattamento. Il comportamento “bere da una tazza” aumenta con il rinforzo positivo e negativo, presentati sia da soli che in combinazione (senza estinzione dell’evitamento).
Solberg, Hanley, Layer & Ingvarsson (2007) valutano gli effetti dell’associazione di procedure di rinforzo e fading sulla scelta di snack da parte di bambini in età prescolare, progettando un disegno con baseline multiple. Le scelte fatte per gli snack preferiti in baseline, vengono valutate mediante le preferenze date a voce. Poi, i rinforzi consumatori, sociali e orientati ad attività vengono esclusivamente associati alla scelta di uno snack meno preferito. Una volta associato ad un rinforzo, lo snack viene selezionato più frequentemente dai bambini e, progressivamente, i tre tipi di rinforzo vengono utilizzati sempre meno (fading). I genitori sono spesso chiamati a garantire che i loro figli consumino una sufficiente quantità e varietà di cibi per soddisfare le loro esigenze nutrizionali (per esempio, verdura e prodotti lattiero-caseari). I bambini che non assumono determinate classi di prodotti alimentari sono particolarmente a rischio per lo sviluppo di problemi da adulti. Per esempio, l’inadeguata assunzione di calcio è associata ad un aumento dell’insorgenza di osteoporosi, ipertensione, obesità. Tuttavia, sia i bambini che le bambine spesso non riescono a consumare adeguati livelli di calcio. Uno dei motivi principali per spiegare questi deficit può essere che solo il 75% dei bambini beve latte, fonte significativa di calcio nella dieta.
I diversi interventi basati sul rinforzo descritti nel trattamento dei gravi problemi alimentari nell’infanzia, possono essere applicabili ai problemi quotidiani più comuni vissuti dai genitori. Un tale trattamento comporta l’associazione di un alimento preferito con uno non preferito ed, in seguito, l’applicazione di una procedura di fading del cibo preferito. Per esempio, Mueller, Piazza, Patel, Kelley & Pruett (2004) trattano 2 bambini con selettività per alimenti, associando un alimento preferito con un alimento non preferito. Il rapporto tra cibo preferito/cibo non preferito viene poi progressivamente ridotto. Dopo questa procedura di fusione, i partecipanti accettano diversi alimenti inizialmente rifiutati.
Una procedura simile è stata utilizzata da Patel, Piazza, Kelly, Ochsner & Santana (2001) per aumentare l’apporto calorico di un bambino con un
disturbo alimentare grave. Questa procedura si sviluppa mescolando e aumentando gradualmente la quantità di una bevanda non preferita con una maggiore quantità di un liquido preferito (acqua), e poi, a poco a poco applicando il fading per il liquido preferito.
Tiger & Hanley (2006), nel presente studio, replicano ed estendono ricerche effettuate in precedenza sul trattamento della selettività alimentare, tramite l’associazione di procedure di rinforzo e fading, al fine di aumentare il consumo di latte di un bambino in età prescolare. Durante la procedura di fading e rinforzo, mescolano una sostanza preferita (sciroppo di cioccolato) in un liquido non preferito (latte), poi gradualmente eliminano lo sciroppo di cioccolato. Questo intervento viene attuato dagli insegnanti di una classe prescolare durante i regolari pasti. Successivamente a questo intervento, il consumo di latte del bambino viene misurato a casa, dai genitori. Il partecipante è un bambino di 4 anni, che frequenta una scuola materna. I genitori hanno espresso preoccupazione, poiché il figlio ha rifiutato il latte per diversi mesi. Alla scuola materna, latte e altri cibi vengono serviti due volte al giorno durante la colazione e il pranzo. Durante i pasti ogni insegnante si siede ad un tavolo da 5-7 bambini. Quando vengono servite le bevande, l’insegnante riempie un’unica brocca di latte, e ogni bambino se ne versa una tazza, a sua volta.
Per diversi mesi prima di questo studio, il bambino si era versato il suo latte da una brocca separata (contenente latte di soia). Questa brocca viene utilizzata durante lo studio, per consentire precise misurazioni del consumo di latte ed applicare la procedura di rinforzo, in modo poco vistoso. La brocca in cui viene servito il latte del bambino è segnata in once. Pertanto, il consumo di latte è riportato in once, invece che in millilitri.
La procedura ha inizio con una baseline, durante la quale l’insegnante dà al bambino 4 once di latte in una piccola brocca durante il pasto. L’insegnante, quindi, richiede al bambino di versarsi il latte nella tazza e non dà istruzioni, né rinforzi sociali per bere o non bere latte. Prima di ogni pasto, l’insegnante misura il volume di latte nella brocca, che poi viene servita al bambino. Alla fine del pasto, il latte rimanente nella sua tazza viene rimesso dentro la brocca e la quantità di latte viene misurata di nuovo. La quantità di latte presente dopo il pasto viene sottratta alla quantità presente prima del pasto, per determinare la quantità consumata. Durante la procedura di trattamento, i pasti sono uguali alla baseline, tranne per il fatto che l’insegnante mescola 5 ml di sciroppo cioccolato al latte, prima di servire la brocca in classe. Viene usato lo sciroppo di cioccolato perché i genitori riferiscono che il bambino lo aveva già bevuto in passato con il latte. Prima della sessione iniziale di associazione, viene detto al bambino che potrà bere, se vorrà, il cioccolato nel latte.
Dopo circa 2 settimane di rinforzo, la quantità di sciroppo di cioccolato mescolato nel latte viene progressivamente diminuita di 0,2 ml ogni due pasti, tramite una procedura di fading. Al fine di garantire effetti prolungati oltre i pasti nella scuola materna, i genitori del bambino vengono invitati a svolgere lo stesso trattamento anche a casa. La misurazione del consumo di latte viene raccolta utilizzando le stesse procedure della scuola. I risultati della valutazione mostrano che durante i pasti in baseline, il bambino non ha consumato latte. Tuttavia, quando lo sciroppo di cioccolato viene aggiunto al latte, il bambino consuma l’intera quantità servita ad ogni pasto. Questi risultati sono di notevole importanza perché mostrano come una procedura svolta a scuola può essere riportata anche a casa ed, eventualmente, estesa anche all’ambito clinico.
Conclusioni
Si è voluto trattare questo argomento, poiché si crede che quella dei problemi alimentari nell’infanzia sia una questione delicata, da affrontare in maniera sempre più approfondita. Si è certi, anche e soprattutto supportati dalle evidenze scientifiche presentate, che l’ABA sia lo strumento adatto per fronteggiare tali problematiche. Le tecniche educative utilizzate in questi progetti hanno mostrato come si possono risolvere problemi alimentari nell’infanzia di grave e moderata entità con gli stessi principi.
Tramite l’analisi di queste ricerche, si è cercato di dare spunti per trattamenti futuri, da poter mettere in pratica a scuola, come in centri educativi, in ambito clinico, come in famiglia. Dai risultati ottenuti in questi interventi, si può notare come, con un buon training effettuato da esperti in materia, le tecniche presentate possano essere utilizzate anche dagli insegnanti a scuola e dai genitori a casa. Infatti, genitori ed insegnanti raggiungono esiti del tutto simili a quelli di psicologi esperti del settore. Si ritiene che questo sia molto importante in ambito educativo poiché genitori ed insegnanti sono maggiormente a contatto con i bambini ed hanno un impatto sociale ed emotivo positivo nei confronti dei bambini.
Si crede, infine, che siano ‘straordinari’ i risultati che si possono ottenere con principi semplici; semplici principi che, se ben utilizzati, possono cambiare la vita.